Davar acher – Siamo tutti coloni
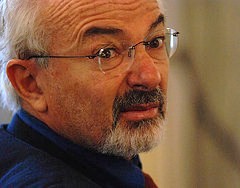 Sono stato colpito anch’io come altri, fra cui Donatella di Cesare su questo sito, dell’uso disumanizzante che palestinesi, politici europei, stampa internazionale e anche qualche parte del mondo ebraico hanno fatto della parola “colono” in occasione della strage di Itamar. E’ un uso del linguaggio così inaccettabile e velenoso da meritare una riflessione, al di là del rifiuto dell’odio. Non si tratta solo di un linguaggio giuridicamente sbagliato e fondamentalmente razzista, vi è in esso un attacco all’identità ebraica. C’è in esso qualcosa di antiebraico, più generale di tutte le spiegazioni che si possono dare sul fatto che Giudea e Samaria sono territori contestati e non territori occupati; che non esiste nessun diritto legale palestinese a tutte le terre al di là di una linea armistiziale che fu stabilita nel ’49 con un accordo a Rodi in cui se ne escludeva esplicitamente la funzione di confine internazionale; sul ridicolo di riportare lo schema dell’imperialismo ottocentesco (“madrepatria” e “colonie”) a una situazione in cui le distanze sono di pochi chilometri e le due popolazioni (“occupanti” e “occupati”, ebrei e arabi) si mescolano da entrambe le parti della linea verde.
Sono stato colpito anch’io come altri, fra cui Donatella di Cesare su questo sito, dell’uso disumanizzante che palestinesi, politici europei, stampa internazionale e anche qualche parte del mondo ebraico hanno fatto della parola “colono” in occasione della strage di Itamar. E’ un uso del linguaggio così inaccettabile e velenoso da meritare una riflessione, al di là del rifiuto dell’odio. Non si tratta solo di un linguaggio giuridicamente sbagliato e fondamentalmente razzista, vi è in esso un attacco all’identità ebraica. C’è in esso qualcosa di antiebraico, più generale di tutte le spiegazioni che si possono dare sul fatto che Giudea e Samaria sono territori contestati e non territori occupati; che non esiste nessun diritto legale palestinese a tutte le terre al di là di una linea armistiziale che fu stabilita nel ’49 con un accordo a Rodi in cui se ne escludeva esplicitamente la funzione di confine internazionale; sul ridicolo di riportare lo schema dell’imperialismo ottocentesco (“madrepatria” e “colonie”) a una situazione in cui le distanze sono di pochi chilometri e le due popolazioni (“occupanti” e “occupati”, ebrei e arabi) si mescolano da entrambe le parti della linea verde.
Come fece notare Shmule Trigano in un suo bellissimo libretto di qualche anno fa (“Les Frontères d’Auschwitz”, Livre de poche 2005), anche se letteralmente l’italiano “colono” e l’inglese “settler” traduce piuttosto “mityashev”, colui che si insedia, che va a risiedere – termine usato per gli immigranti nell’Yishuv che precedette lo stato di Israele -, “colono” nel senso disumanizzato è la traduzione del termine ebraico “mitnahel”, usato adesso, che significa “chi prende possesso della sua eredità (nachala)”.
Il problema per i nemici di Israele non è solo che ci siano degli insediamenti, ma che questi vengano rivendicati come ebraici, come eredità. Per questo si tenta sempre più spesso di definire “colonie” anche luoghi che non sono certo nuovi insediamenti, come Gerusalemme, e la loro ovvia origine ebraica è contrastata e negata dai palestinesi e dai loro sostenitori al di là di ogni buon senso, delle testimonianze storiche e archeologiche e perfino del Corano. Che poi a Gerusalemme i decenni di “occupazione” ebraica non abbiano affatto eliminato la popolazione araba né sconsacrato i luoghi di culto islamici (al contrario della pulizia etnica e della vera e propria distruzione del quartiere ebraico, della sconsacrazione dei cimiteri ecc. compiute dall’occupazione giordana), non interessa a nessun cultore della correttezza politica. Se uccidere i coloni non è reato, figuriamoci falsificare la storia e distruggere le memorie delle “colonie”.
Del resto, che da parte della Chiesa e dell’Islam ci sarebbe stata il tentativo di negare la nostra appartenenza alla Terra di Israele – a tutta la Terra, non solo alla porzione al di là della linea verde – era chiaro a chiunque sapesse vedere fin dall’inizio di queste religioni. Per vederlo basta rileggere oggi la celebre nota di Rashi al primo versetto della Torah (“Per quale ragione inizia con il racconto della creazione? […] Se i popoli del mondo dicessero a Israele ‘voi siete dei predoni [dei coloni?] perché avete preso con la forza le terre [… si potrebbe] replicare loro ‘Tutta la terra appartiene al Santo benedetto Egli sia, è lui che l’ha creata e l’ha data a chi parve giusto ai suoi occhi.”). Quel che è in gioco insomma è il nostro rapporto con Eretz Yisrael, che la Torah definisce il nostro lascito (morashà). Chi disumanizza i coloni considera innanzitutto intollerabile questo rapporto.
Bisogna aggiungere che Rashi, nel suo commento, si riferiva ovviamente non alle terre “dei Palestinesi” che allora non c’erano e non ci sarebbero stati per altri ottocento anni, ma al primo ingresso del popolo ebraico in Eretz Yisrael, quello di Giosuè e della sconfitta dei “sette popoli”. Il fatto è che il popolo ebraico (fin dal nome ivrì, attribuito per primo ad Avraham e solitamente interpretato come “colui che viene da altrove”) è fra i pochissimi se non l’unico a non proclamarsi indigeno, ma a dirsi invece nei propri testi fondativi immigrato, “occupante” o “colono” della sua terra. In realtà la storia ci insegna che questa condizione non indigena è comune a tutti i popoli, che si sono insediati dove stanno ora dopo migrazioni e battaglie, magari antiche come per celti e latini, o piuttosto recenti come arabi e turchi; ma quello ebraico si caratterizza per non averlo scordato o nascosto: “mio padre era un arameo errante”, diremo fra un po’ di nuovo nel seder di Pessach.
La verità è che noi ebrei, quando non siamo esuli, siamo tutti, da sempre, coloni. Siamo stati stranieri-residenti con Abramo (Gn 23,3), esiliati con Giuseppe, stranieri in terra straniera con Mosè e Gershom, conquistatori con Giosuè, e poi di nuovo esiliati in Babilonia, di nuovo “occupanti” con Esdra e Neemia, di nuovo esiliati e oggi “coloni” ancora, al di qua o al di là della linea verde. Chi fra noi o fra i nostri “amici”, pensa di poter dividere il popolo ebraico fra coloni cattivi (“mitnahelim”) e cittadini buoni (mityashevim”), si sbaglia profondamente e tradisce il senso della nostra storia. Chi attacca i “coloni” lo fa tatticamente, ma attacca tutto il popolo ebraico, rifiutando una delle basi della sua esistenza, il rapporto con Eretz Yisrael. Per ragioni pratiche, per tentare delle vie di pace, per non farci schiacciare possiamo dover rinunciare a una parte della nostra eredità, lo sappiamo tutti. Ma non perché vi sia un diritto diverso al di qua e al di là della linea verde. Non perché i “coloni” abbiano minori diritti o più torti degli abitanti di Tel Aviv; ma perché i rapporti di forza sono quelli che sono. Dunque, ricordiamoci sempre che “siamo tutti coloni”.
Ugo Volli
