PENSIERO EBRAICO Talmud: anche Dio prega ogni mattina
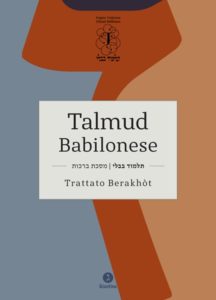 Gianfranco Di Segni (a cura di) / BERAKHOT / La Giuntina
Gianfranco Di Segni (a cura di) / BERAKHOT / La Giuntina
Il primo trattato dal Talmud Babilonese è dedicato alle preghiere, più esattamente alle benedizioni o berakhot, e inaugura la serie dei trattati sulla vita economica, nell’epoca antica l’agricultura. Il massimo della spiritualità, se così si può dire, introduce al massimo della concretezza: le semine e la vita dei campi, i raccolti e la loro distribuzione. Questa nuova traduzione di Berakhot, ampia al punto da necessitare di due tomi (quasi mille pagine, testo ebraico a fronte, curati da Gianfranco Di Segni e pubblicati da Giuntina), offre la possibilità di conoscere e penetrare nel mondo, arcano ai più, della preghiera ebraica, così vicina e al contempo così lontana dal mondo della preghiera cristiana. A cominciare dall’idea che si tratta di un precetto rabbinico e non biblico (la Bibbia prescrive solo i sacrifici nel tempio), che esistano tempi fissi per recitare le preghiere pubbliche, che le donne ne sono esonerare, che l’unica lingua in cui si prega è l’ebraico. E che, come insegna il rabbino Bachjà ben Asher del XIV secolo, le preghiere «sono una necessità non per Dio ma per l’uomo». In realtà, anche se dedicato alle benedizioni, questo trattato talmudico è una vera e propria enciclopedia della fede ebraica, ricca di commenti biblici e di parabole (che i maestri di Israele chiamano aggadot), di precetti specifici e di insegnamenti universali, dove abbondano ardite metafore teologiche. Si prenda per esempio la voce di Dio, qui paragonata ora al tubare della colomba ora al ruggito del leone, oppure la “nuca divina” sulla quale Mosè poté scorgere il nodo dei filatteri, lasciando intendere che anche Dio prega ogni mattina (gli ebrei religiosi infatti dicono le preghiere mattutine feriali indossando i filatteri). In questo trattato, spiega il curatore Di Segni, la parte normativa s’interseca con quella narrativa: «La prima ci indirizza dall’astratto al concreto, mentre la seconda ci riconduce dal concreto all’astratto», dal particolare all’universale. Non sorprende allora lo scoprire che la tradizione ebraica insegna che un buon ebreo dovrebbe dire almeno cento benedizioni al giorno. Ma perché dire una benedizione su tutto ciò che facciamo o ciò di cui godiamo? Spiegano i rabbini: «Chi gode dei beni di questo mondo senza dire una benedizione su di essi commette un atto di infedeltà e prende ciò che non gli appartiene, perché non chiede il permesso al Signore del mondo a cui tutto appartiene». E come se commettesse un furto. Le berakhot dunque servono ad accrescere la consapevolezza del nostro posto nel mondo e a cogliere il valore delle cose mondane, le conseguenze delle nostre azioni, i limiti (etici) entro cui dobbiamo muoverci. Da qui la grande discussione, che occupa molte pagine di questo trattato, sull’importanza della giusta intenzione o kavvanà non solo quando preghiamo ma anche quando compiamo un qualunque atto mondano osservando i precetti. A cominciare da quell’atto quotidiano che è il mangiare, che prevede una lunga benedizione di ringraziamento a Dio perché il cibo «ci viene dalla sua bontà: mangiamo del suo» dice alla lettera questa preghiera dopo i pasti, detta birkhat hamazon. Si dovrebbe poi benedire il Cielo ogniqualvolta assistiamo a fenomeni naturali inaspettati (un lampo, il passaggio di una cometa, un terremoto) oppure siamo scampati a un pericolo, quando assaggiamo un cibo nuovo, quando riceviamo buone o cattive notizie, o sentiamo un profumo o indossiamo un vestito mai usato prima. In tal modo non c’è aspetto della vita che non venga vissuta con gli occhi della fede e che non sia mediata dalla benedizione che gli corrisponde. Spiega ancora il rabbino Gianfranco Di Segni, che è anche un biologo: «La vita è piena di fenomeni privi di indirizzo, di significato e di scopo. La berakhà li mette al riparo da tale assenza di scopo e li rende significanti, li relaziona con le loro origini e il loro destino. L’abbondanza di benedizioni è conseguenza della loro necessità». Non è tutto. Chi studiasse queste pagine, che appartengono al grande corpus della sapienza ebraica elaborato a Babilonia tra il terzo e il sesto secolo, scoprirebbe molti passi che sembrano echeggiare insegnamenti simili che si trovano nel Nuovo Testamento. Per esempio, là dove si dice che «a differenza di questo mondo, nel mondo futuro non si mangia né si beve né ci si riproduce, ma i giusti sono seduti (al banchetto celeste) e godono dello splendore della divina Maestà». Insegnamento che presuppone la convinzione rabbinica che esiste un “mondo a venire”, che ci sarà una resurrezione dei morti, che Dio remunererà nel bene chi gli è fedele. Principi tutti che il giudaismo forgiato dai rabbini condivide con il cristianesimo delle origini. Incluso uno sguardo positivo sulle donne. Nel trattato si parla di Berurià, moglie di Rabbi Meir, la quale riusciva a correggere suo marito in materia di esegesi biblica e dava persino lezioni (di speranza) a un sadduceo, che nell’interpretazione di un versetto prendeva una parola alla lettera trascurando il contesto e perdendone il senso. Forse nessun elogio delle donne ebree è più alto di quello che leggiamo in queste pagine, dove pure esse sono esonerate dall’obbligo, maschile, di recitare la preghiera pubblica. Si interroga il testo: «Che merito hanno le donne? Ecco la risposta di Ray (Jehuda haNassi): insegnano la Scrittura ai bambini e fanno studiare (l’insegnamento rabbinico) ai loro mariti nella casa dei maestri, e poi li attendono fedelmente quando tornano dalla case dello studio». Per una tradizione che mette lo studio e l’educazione dei figli tra i valori religiosi più alti (più alti della stessa preghiera) non è un elogio da poco. Le prime berakhot che le madri insegnano ai propri figli e figlie-sul pane, quando si lavano le mani, sull’accensione dei lumi del sabato – sono le lenti attraverso cui il mondo appare non come mera natura ma, appunto, come mondo ossia creazione divina: esse costituiscono l’antidoto alla doppia desolazione dell’ateismo e dell’idolatria.
Massimo Giuliani, Avvenire, 29 novembre 2017
