| se non visualizzi correttamente questo messaggio, fai click qui |
| |
| |
 |
|
L'Unione informa |
|
| |
|
22 maggio 2009 - 28 Yiar 5769 |
|
 |
|
| |

|
| alef/tav |
|
|
 |
| |
 |
Roberto
Colombo,
rabbino |
Parlando
del momento in cui gli ebrei si accingevano a ricevere la Torà si
legge nel Testo: “Stettero sotto il monte” (esodo 19,17). Rashì riporta
il noto commento talmudico secondo il quale Dio pose il monte Sinai
sopra il popolo e disse: “O accetterete la Torà o qui sarà la vostra
tomba”. Il rebbe di Sadegora commentava: “Dio non costrinse Israele a
ricevere la Torà; si limitò a una semplice constatazione. Chi ha un
monte sopra di sé anche quando alza gli occhi al cielo vede solo terra.
Un ebreo che non riesce più a vedere il cielo per mezzo della Torà, è
destinato a scomparire”. |
 |
| L'appello lanciato da Elie Wiesel, da Claude Lanzmanm e da Bernard-Henry Lévy contro la candidatura a direttore generale dell'Unesco. dell'egiziano Farouk Hosny
merita di essere ripreso e amplificato ovunque. L'Unesco è, come è
noto, il ramo dell'ONU che si occupa dell'educazione, la scienza e la
cultura. Dell'Unesco fanno parte i 192 paesi che fanno parte
dell'ONU. Nulla da stupirsi, quindi, che l'Unesco abbia preso in
passato e continui tuttora a prendere posizioni molto discutibili nei
confronti di Israele. Ma questo è ancora più grave. Farouk Hosny,
ministro della Cultura egiziano, è personalmente un attivo antisemita,
un personaggio che sostiene pubblicamente la sua volontà di bruciare i
libri israeliani presenti nelle biblioteche egiziane (e subito dopo, si
immagina, quelli ebraici). "Un incendiario, per riprendere le parole
dell'appello, dei cuori e degli spiriti". Affidargli una carica così
importante e prestigiosa equivarrebbe ad affidare a un piromane
l'organizzazione della tutela delle foreste, ad un pedofilo la
direzione di un asilo d'infanzia. Una simile candidatura, ci dice
l'appello, sarebbe per l'Unesco una catastrofe, "una provocazione così
manifestamente contraria ai propri ideali" che l'Organizzazione non
riuscirebbe più a risollevarsi. |
Anna Foa,
storica |
 |
|
|
 |
|
|
torna su |
| davar |
|
|
| |
| |
 Torino e i libri - "pagine ebraiche",
Torino e i libri - "pagine ebraiche",
la grande sfida di parlare alla gente
“Buongiorno signora! Prego prenda pure la sua copia!”.
“Che cos’è?”. “Si tratta di pagine ebraiche
la nuova pubblicazione nazionale dell'Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane. Fresco di stampa.”. “Ah ehm.. no mi scusi ma ho lasciato il
gatto in forno e il pollo fuori di casa.. cioè volevo dire il pollo in
forno e il gatto fuori di.. Insomma devo scappare”!
Succede
davvero un po’ di tutto in questo grande esperimento antropologico che
è la distribuzione a decine di migliaia di persone di un nuovo
giornale. La sfida è sicuramente nobile: dare voce ad una minoranza che
ha una certa visibilità mediatica, ma di cui si conosce senza dubbio
troppo poco. Eppure è solo attraverso la conoscenza che si possono
prevenire o combattere i germi dell’intolleranza. Le reazioni
all’iniziativa, però, sono le più svariate. C’è il vecchietto che,
entrato al Salone del Libro
per assistere a qualche incontro letterario, s’imbatte in questo nuovo
foglio, chiede, s’interessa, prende la sua copia e non se ne stacca
più, dimenticandosi di andare a sentire quella conferenza in Sala Azzurra.
C’è
l’espositore ben vestito che allunga il passo facendo elegantemente
finta di non vedere quella lieve montagna di decine di migliaia di
giornali, ma anche quello che sin dal primo giorno della Fiera non gira
senza le sue pagine ebraiche sottobraccio insieme con i grandi quotidiani nazionali.
La
distribuzione, a conti fatti, è certamente un successo: il punto
dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane allestito all’ingresso del
Lingotto è un passaggio obbligato per tutti e permette di regalare il
giornale praticamente ad ogni singolo visitatore della Fiera, che
giorno dopo giorno chiude i battenti a tarda ora invasa di Pagine.
Molti
son ben disposti ad accettare il giornale, non fosse altro che perché è
gratuito (ma che fatica spiegare che non si tratta né di Leggo né di
Metro!). Ma non mancano neanche i diffidenti, quelli che proprio non ne
vogliono sapere, e qui ogni scusa è valida. C’è chi in ottima fede si
lamenta della quantità eccessiva di materiale con cui si esce
regolarmente dalla Fiera, chi declina cortesemente e chi si dilegua
temendo di avere a che fare con il solito scocciatore, chi infine si
scusa dicendo di avere le mani troppo piene, salvo che abbassando lo
sguardo le si vedono comodamente posate nelle tasche.
L’esempio
più bello, invece, è forse quello di una professoressa di una delle
migliaia di scolaresche in visita che, visto il giornale, chiede ad
ognuno dei suoi alunni di prenderne una copia e li invita a portarla a
scuola il giorno successivo per leggerlo e analizzarlo insieme.
L’augurio migliore, per pagine ebraiche, arriva da quella classe.
Simone Disegni
 Mario Giacometti, marinaio italiano del dopoguerra Mario Giacometti, marinaio italiano del dopoguerra
e l'immigrazione clandestina in Eretz Israel
“Nel
dopoguerra, nel 1947, mi capitò di imbarcarmi su un vecchio bastimento
che era stato acquistato dall’Haganà per portare i profughi dei campi
di concentramento tedeschi nella terra di Sion. Si presentarono a bordo
tre persone, ci spiegarono lo scopo del viaggio e ci raccomandarono di
tenere il segreto su tutto: chi non voleva partire poteva rimanere a
terra e avrebbe avuto una ricompensa. Io e il mio amico Carlino
accettammo, perché allora era difficile trovare un imbarco.”
Inizia così il racconto di Mario Giacometti a Sorgente di Vita: una storia scritta con l’aiuto della figlia Daniela in un libro, “Rotta per la Palestina” edito da Mursia.
E’
la storia di due viaggi dell’ “alyà beth”, l’immigrazione
clandestina, da un punto di vista insolito: non quello degli ebrei
sopravvissuti ai campi che cercavano di raggiungere Eretz Israel, nè
quello degli organizzatori, come Ada Sereni, che raccontò quella
vicenda in prima persona. E’ il punto di vista di un, allora giovane,
marinaio italiano.
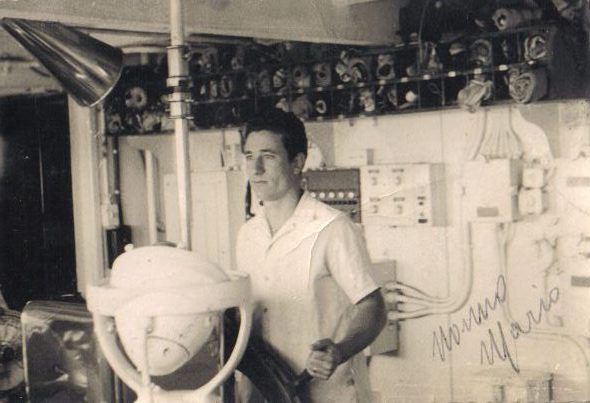 Lo
incontriamo al porto di Viareggio, spostandoci da un molo all’altro,
tra yacht, motoscafi e pescherecci: il suo mondo di sempre, perché
marinaio, e poi comandante, Giacometti (nell'immagine a fianco) lo è
stato per tutta la vita. Oggi è uno scattante pensionato di ottantuno
anni che snocciola i suoi ricordi con una colorita parlata viareggina,
infarcita di termini marinari. “Mio padre era cuoco su navi mercantili:
dopo le scuole elementari feci anche io il libretto di navigazione e mi
imbarcai come mozzo, in piena guerra”. Spirito di avventura,
incoscienza giovanile e bisogno di guadagnare negli anni difficili del
dopoguerra lo trascinarono poi nella missione della “alyà beth”.
Naturalmente Giacometti ignorava che dalle coste italiane tra l’estate
del ’45, fino alla proclamazione dello Stato d’Israele, il 14 maggio
1948, partirono tante navi cariche di ebrei scampati ai lager; non
sapeva che la sua scelta l’avrebbe portato nel meccanismo di una
efficiente organizzazione che riuscì a far partire circa
23.000 persone. Fu così che nel settembre del ’47 si imbarcò
sul “Giovanni Maria”. Lo
incontriamo al porto di Viareggio, spostandoci da un molo all’altro,
tra yacht, motoscafi e pescherecci: il suo mondo di sempre, perché
marinaio, e poi comandante, Giacometti (nell'immagine a fianco) lo è
stato per tutta la vita. Oggi è uno scattante pensionato di ottantuno
anni che snocciola i suoi ricordi con una colorita parlata viareggina,
infarcita di termini marinari. “Mio padre era cuoco su navi mercantili:
dopo le scuole elementari feci anche io il libretto di navigazione e mi
imbarcai come mozzo, in piena guerra”. Spirito di avventura,
incoscienza giovanile e bisogno di guadagnare negli anni difficili del
dopoguerra lo trascinarono poi nella missione della “alyà beth”.
Naturalmente Giacometti ignorava che dalle coste italiane tra l’estate
del ’45, fino alla proclamazione dello Stato d’Israele, il 14 maggio
1948, partirono tante navi cariche di ebrei scampati ai lager; non
sapeva che la sua scelta l’avrebbe portato nel meccanismo di una
efficiente organizzazione che riuscì a far partire circa
23.000 persone. Fu così che nel settembre del ’47 si imbarcò
sul “Giovanni Maria”.
“Era un viaggio diverso dal solito.
Questa volta non si trasportava mercanzia varia ma persone. Io
non sapevo nulla dei campi di concentramento: solo tra i più
anziani era trapelata qualche notizia”. Nel porto di La Spezia la nave
fu trasformata: “costruimmo una cabina grandissima sopracoperta, per
accogliere le donne, i bambini e creare una specie di infermeria. Nella
stiva, a partire dal fondo, montammo dei tubi innocenti e reti
metalliche. Così potevamo caricare circa 1200/1300 persone”. Sembra di
vedere le scene del film “Exodus” e i particolari sono fedeli ai
rari filmati dell’epoca. Partirono di notte dal porto di La Spezia: la
prima tappa fu a Bocca di Magra, per caricare i viveri. “Salirono
a bordo 7 persone dell’Haganà, tra questi il comandante, Amnon, e
c’erano anche dei telegrafisti. Avevamo infatti una sala radio che
faceva invidia a un transatlantico, si parlava fino in America”. “Amnon
– ricorda Giacometti - aveva circa 30 anni, era un vero
comandante di marina, un giovanotto alto con i capelli rasati, sul
biondiccio, aveva un accento americano, ma parlava bene italiano. Una
volta ci disse: qui siamo tutti pirati”.
Il “Giovanni Maria”
navigò fino alla costa francese: a La Ciotat, di notte, per non essere
scoperti, salirono a bordo 1300 passeggeri. “Erano persone,
oserei dire miserabili, pieni di sacchi, borse, tante donne,
vecchi, bambini. Il viaggio andò tranquillo, aiutato dal tempo e dalla
nebbia. Parlare si parlava con le persone che venivano sopracoperta la
sera, ma non ci dicevano molto, erano restie a raccontare”.
“Di
notte arrivammo davanti a una piccola spiaggia con le dune, vicino a
Tel Aviv, si vedevano solo le luci. Ci arenammo con la prua e sbarcammo
le persone: chi si buttava a mare, chi si trascinava con le corde
lanciate da terra, donne e bambini venivano portati con i battelli. Mi
ricordo i pianti, ricordo che piangevano tanto; erano arrivati a casa
loro, dopo tutto quello che era successo”.
Il viaggio era finito:
il “Giovanni Maria” ripartì subito verso l’Italia. Dopo molte
disavventure ci fu un secondo viaggio: questa volta l’imbarco dei
passeggeri fu sulla spiaggia corsa della Girolata. A poche miglia dalla
Palestina furono intercettati da un cacciatorpediniere, curiosamente
avvolto da reti metalliche. “Gli ebrei cominciarono a tirare ogni
ben di Dio, scatolame e tutto quello che capitava a tiro; tutto
rimbalzava sulle reti e cadeva in mare. Ricordo che gli inglesi
ridevano di questo, e sghignazzavano”. “Poi gli ebrei spalmarono
il ponte con olio e grasso” racconta compiaciuto Giacometti, “e col
rollio gli inglesi che salivano a bordo prendevano bastonate dagli
ebrei e venivano ributtati a mare dall’altra parte” . Sugli alberi
della nave sventolavano tre bandiere bianche e azzurre con la stella di
David: “fummo io e Carlino a metterle lassù: per ordine di Amnon
facemmo in modo che non si riuscisse a levarle, tagliando tutte le
corde e le scalette”. Ormai era finita: passeggeri e marinai furono
presi in consegna dagli inglesi. Sbarcati nel porto di Haifa, radunati
in capannoni, toccò loro una doccia e una visita medica. I sette
marinai italiani, senza documenti, complici di un’attività illegale,
correvano seri rischi. “La paura era tanta: se scoprivano che
eravamo cristiani, italiani, erano cinque anni di prigione in
Inghilterra”. Finirono invece nei campi profughi sull’isola di Cipro.
“Lì abbiamo vissuto due mesi: noi sette avevamo una tenda per conto
nostro, ma poi si viveva tutti insieme, si giocava a pallone,
facevamo un po’ di ricreazione, ma il cibo non era buono, la solita
brodaglia inglese. Noi eravamo dei privilegiati, gli ebrei stessi ci
davano di più, si toglievano il pane di bocca, perché sapevano chi
eravamo. Non avevamo possibilità di fuga, c’era una doppia rete di
recinzione, garitte in ogni angolo, la notte era illuminata dai
proiettori. Naturalmente gli ebrei erano riconoscenti, anche se secondo
me non ce lo meritavamo, avevamo fatto quello che ci eravamo sentiti di
fare. Ci hanno aiutato a passare da un campo all’altro, facendoci
raggiungere prima la libertà”. Entrati in Palestina i sette italiani
trascorsero due mesi in kibbutz, quasi una vacanza. Poi un
bel giorno, continua Giacometti “arriva Amnon, e ci dice che è arrivato
il momento di tornare a casa”. “Arrivato a casa mia madre mi rifilò uno
schiaffo. Io non capii, e lei mi disse: sei un bel mascalzone, dove sei
andato a finire tutti questi mesi!” ricorda oggi divertito l’ingloriosa
fine dell’avventura. E poi con semplice schiettezza azzarda un
bilancio: “naturalmente, stando a contatto con quelle persone ci siamo
resi conto che era una cosa grande: non che davamo tanta importanza, ma
era qualcosa di bello. A distanza di tutti questi anni, con tutto
quello che sta ancora succedendo, penso che rifarei senz’altro
una cosa del genere, non mi tirerei indietro: però – conclude
Giacometti con il suo colore dialettale - penso anche che abbiamo
contribuito a tutto questo ravoglio che c’è nel mondo”.
Piera Di Segni
Per vedere questo e altri servizi di Sorgente di Vita clicca qui. |
|
| |
|
|
torna su |
| pilpul |
|
|
| |
| |
Rotschild Boulevard - "Wir sind allein",
dalla hit parade alla polemica sull'uso della lingua tedesca
 Saranno anche “solo canzonette”, ma la ultima hit europea Allein Allein rischia di trasformarsi in un caso politico in Israele. Il motivo della controversia? Il testo della canzone, del gruppo Polarkreis 18 (nell'immagine), contiene un verso in tedesco: “Wir sind allein, allein allein”, siamo soli, è il ritornello del pezzo, che per il resto è cantato in inglese e che viene trasmesso dalle radio israeliane. Saranno anche “solo canzonette”, ma la ultima hit europea Allein Allein rischia di trasformarsi in un caso politico in Israele. Il motivo della controversia? Il testo della canzone, del gruppo Polarkreis 18 (nell'immagine), contiene un verso in tedesco: “Wir sind allein, allein allein”, siamo soli, è il ritornello del pezzo, che per il resto è cantato in inglese e che viene trasmesso dalle radio israeliane.
I Polarkreis 18, basati a Dresda, sono una band di “pop sintetico”: il loro ultimo album The Colour of Snow, da cui è tratto il singolo Allein Allein,
ha scalato le hit parade di alcune nazioni europee, incluse Svizzera,
Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, oltre alla stessa Germania. In Israele
ha ora raggiunto l'ottava posizione della classifica nazionale. Il
singolo di successo è stato trasmesso, tra le altre radio, anche da
Galgalatz, l'emittente giovane dell'esercito, un punto di riferimento
per il pubblico sotto i 30.
La faccenda non è piaciuta però
al parlamentare conservatore Arieh Eldad, che ha chiesto a Galgalatz di
togliere la hit dalla programmazione perché rischierebbe di offendere
la memoria della Shoà: “Non esistono norme che proibiscono di
trasmettere canzoni in tedesco, ma c'è un limite a ogni cosa”, ha detto
Eldad, che fa capo al partito Unione Nazionale. Il quale però ha poi
riconosciuto che si tratta tutto sommato di una bella canzone, il cui
significato ben si adatta allo spirito israeliano: “Dovremmo tradurla
in ebraico”.
Anna Momigliano
Wir sind allein
he's living in a universe
a heart away
inside of him there's no one else
just a heart away
the time will come to be blessed
a heart away
to celebrate his loneliness
wir sind allein
allein allein
allein allein
allein allein
allein allein
we look into faces
wait for a sign
wir sind allein
allein allein
allein allein
a prisoner behind the walls
a heart away
wants to lead his universe
just a heart away
the time has come for us to love
a heart away
to celebrate our loneliness
wir sind allein
allein allein
allein allein
We look into faces
wait for a sign
wir sind allein... |
|
| |
|
|
torna su |
| rassegna stampa |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
Periodo
di consultazioni e verifiche, quello che sta contrassegnando queste
ultime settimane, precedenti il discorso che Obama terrà in Egitto, nei
primi giorni di giugno, quando dovrà rivelare qualche carta,
lanciandola sul tavolo da gioco, nel merito della sua futura politica
per il Medio Oriente. Alcune indiscrezioni già si sono colte, per la
verità, ma è difficile dire se corrispondano per davvero alle
intenzioni che l’amministrazione statunitense esprimerà a chiara voce.
A tale riguardo, la lettura che ne viene data da parte palestinese ci è
offerta dall’intervento di Ali Rashid su il Manifesto
di oggi. Al di là di congetture e ipotesi quel che pare invece di poter
registrare da subito è una notevole sfasatura tra le iniziali aperture
statunitensi nei confronti di tutti gli attori presenti sulla scena e
gli effettivi spazi di mediazione. La diplomazia della mano aperta,
insomma, sembrerebbe trovare all’atto concreto non troppi entusiasti
sostenitori. È senz’altro presto per potere dire che cosa
l’Amministrazione americana potrà concretamente fare. Al momento si
registrano più che altro le prese di posizione dei singoli soggetti, si
tratti degli Stati dell’area così come dei movimenti politici che sono
parte del gioco medesimo. Così va quindi intesa l’affermazione di
Netanyahu su «Gerusalemme unita e capitale d’Israele», richiamata da l’Unità e affrontata da Nadav Shragai, Ora Cohen e Mazal Mualem su Haaretz.
Quel che prevale, ma è un fatto in sé prevedibile, è più che altro un
atteggiamento che potremmo definire come “identitario”, laddove ognuno
disegna i perimetri dei propri interessi, ribadendo quel che considera
come inderogabile. Altro discorso sarà, poi, nell’eventualità di una
trattativa, la concreta disponibilità nel fare qualche concessione. Al
momento Obama si deve quindi confrontare con le dichiarazioni di
principio. Sta di fatto che in questa vicenda l’ombra che sembra pesare
più di altre è quella del nucleare iraniano (senz’altro per Israele,
come ci ricorda Ofri Iani su Haaretz di oggi), sul quale Pierre Chiartiano descrive per Liberal,
sia pure su un piano puramente teorico, ovvero ricorrendo ad un modello
di simulazione d’attacco da parte israeliana, una ipotesi di scenario
di guerra in divenire. Sempre su Liberal
un’intervista di Etienne Pramotton all’ex generale Fabio Mini corrobora
sul piano tecnico la natura e i modi dell’eventuale ricorso all’opzione
militare contro l’Iran. Fantasie e ipotesi a parte, di mezzo ci sono le
elezioni presidenziali a Teheran e la candidatura, per un secondo
mandato, di Mahomud Ahmadinejad. Il 12 giugno il responso delle urne ci
dirà chi avrà avuto il consenso dagli elettori. È però già da adesso
certo che il leader conservatore (più opportuno sarebbe definirlo come
esponente dell’area radicale dello spettro politico iraniano, essendo
espressione di un blocco sociale ipernazionalista che coltiva le sue
fortune caldeggiando posizioni di enfatica esaltazione della centralità
iraniana nel quadro degli equilibri regionali mediorientali) con il
recente lancio di un nuovo modello di missile, il Sejil 2, in grado di
raggiungere Israele, parrebbe oramai essere in grado di riuscire a
mettere una seria ipoteca sia sull’esito della tornata elettorale che,
in prospettiva, sui rapporti internazionali. Nei giorni scorsi il
ministro degli Esteri Frattini, come ci ricorda ancora l’Avvenire
di oggi, non si era recato in visita nella Repubblica iraniana proprio
per evitare insostenibili commistioni e manipolazioni da parte del
regime islamista. Peraltro la logica dell’escalation è consustanziale
al premier iraniano, che gioca la credibilità dinanzi al suo elettorato
cercando di alzare la posta. Plausibile che una delle ragioni delle
diverse sensibilità, che separano Netanyahu da Obama, sia la
valutazione nel merito dell’effettiva pericolosità da attribuire ai
bellicosi atteggiamenti di Ahmadinejad. Se ci sofferma sull’aspetto,
che pure ha un suo fondamento, della ricerca di consenso interno - così
come di una smarcatura dalla oligopolistica lobby energetica degli
ayatollah -, lì si intenderà essenzialmente come un puntello rispetto
alla sua altrimenti fragile candidatura, che pure può contare sulla
debolezza di quel che resta dei riformisti, divisi al loro interno da
insanabili contrasti. Se invece si vuole attribuire ad essi la natura
di un vero e proprio disegno politico, volto a utilizzare le difficoltà
del dopo-Bush per lanciare il progetto di un “nuovo Medio Oriente“ in
salsa iraniana, allora il significato del quadro generale muta di
indirizzo. A quest’ordine di riflessioni affianchiamo le considerazioni
di Paul Salem su l’Espresso
nel merito delle prossime elezioni legislative libanesi, previste per
il 7 giugno. La possibilità di una secca vittoria di Hezbollah
(corposamente presente in un cartello elettorale denominato «Alleanza
dell’8 marzo») che, rammentiamo, insieme al Foglio,
è prima di tutto un partito politico con un buon numero di consensi e,
quindi, di voti, avrebbe conseguenze problematiche per i già precari
equilibri interni al Paese dei cedri. Se oggi il «Partito di Dio» siede
all’esecutivo con ben 11 titolari di dicasteri, rappresentando tutta la
parte meridionale del Libano non meno che i quartieri musulmani di
Beirut, il rischio, in prospettiva, è che la sua presenza diventi
determinante in tutti gli assetti amministrativi di qui in avanti. Nel
qual caso sarebbero gli stessi paesi arabi a isolare il Libano,
condannandolo così ad un destino di precarietà politica e consegnandolo
definitivamente all’asse siro-iraniano che, malgrado gli sforzi della
diplomazia, è ben lungi dall’esserci sfilacciato, potendo contare sulla
longa manus cinese e russa. Sul piano della cronaca, in questi giorni
per la verità un po’ fiacca, i resoconti dei giornali registrano
l’episodio della comparsa in giudizio, dinanzi ad un tribunale
americano, di quattro imputati di terrorismo. L’accusa è quella di
avere voluto far esplodere un centro ebraico, una sinagoga oltre ad
avere in animo ulteriori eclatanti azioni. Ne parlano molti quotidiani
tra i quali citiamo il Messaggero, l’Avvenire, Arturo Zampaglioni per la Repubblica, Nicola Scevola per il Riformista e Marco Valsania per il Sole 24 Ore.
L’evento di per sé non avrebbe nulla di clamoroso se non fosse per il
fatto che i quattro apprendisti terroristi (per fortuna solo tali
poiché, all’atto concreto, hanno fallito nei loro intenti) sono stati
letteralmente beffati dal Federal Bureau of Investigations che, intuite
le loro intenzioni omicide attraverso un informatore, aveva provveduto
a fornirli sì di bombe ma “inerti”, ovvero del tutto prive di
esplosivo. I quattro cavalieri dell’apocalisse, tutti provvisti di
cittadinanza americana, convertitisi in carcere alla religione
musulmana e animati da un radicale antisemitismo, appartengono con
tutta probabilità a quell’inquietante milieu, composto da una ampia
platea di rancorosi giustizieri, che potrebbe ben presto dare vita a
una sorta di terrorismo autoctono, «made in Usa». Un nuovo fronte,
insomma, distante anni luce da quello di Al Qaeda, organizzazione della
quale, tuttavia, condivide finalità politiche, approccio ideologico e
modalità operative. Cani sciolti, per usare il gergo della vecchia
politica, ma in grado oltre che di abbaiare anche di mordere. Da
ultimo, segnaliamo per la penna di Marino Freschi l’ampio ritratto che
fa dello scrittore Joseph Roth su il Mattino,
cantore quest’ultimo del declino del sogno mitteleuropeo. Sempre
nell’ambito della cultura, ma con un segno in questo caso opposto, da
leggere l’articolo di Matteo Persivale su il Corriere della Sera
nel merito di che è già stato definito il «caso Littell», dal nome
dell’autore di un fortunato ancorché discusso romanzo sulla Shoah,
osservata e vissuta con gli occhi di uno dei carnefici. «Le benevole»,
questo è il titolo della voluminosa opera di fantasia che ha dato avvio
ad una saga familiare di cui ci è reso conto, sempre di più parrebbe
assumere la natura di operazione editoriale tanto spregiudicata quanto
priva di un costrutto culturale di ampio respiro. Laddove il narcisismo
degli autori – in questo caso padre e figlio – si camufferebbe dietro
l’eclatanza dell’estro artistico. Non ci pronunciamo nel merito, anche
se ci è chiaro quanto il tema del passato nazista sia per non pochi il
territorio per esercitare disinvolte scorribande, sospese tra libero
esercizio intellettuale e imbarazzante vocazione all’affermazione del
proprio ego.
Claudio Vercelli |
|
| |
|
|
torna su |
| notizieflash |
|
|
| |
| |
Milano,
il centenario della fondazione di Tel Aviv
e la preoccupazione di Bernard-Henry Lèvy per Israele
Milano 22 mag -
Si
è svolto ieri sera a Milano un incontro per il centenario della
fondazione di Tel Aviv. Fra le personalità intervenute il filosofo
francese Bernard-Henry Lèvy, che ha ricevuto in questa occasione
il premio “Uomo dell'anno 2009” del Museo d'Arte della città israeliana.
“Per uscire dalla sua condizione di crescente solitudine e far fronte a
un nuovo antisemitismo – ha affermato il filosofo nel corso del suo
intervento - Israele dovrebbe stringere delle alleanze: in primis
rinnovando il suo legame con il mondo cattolico europeo e poi con i
segmenti più illuminati dell'Islam e della società palestinese” e ha
aggiunto di non essere stato mai così preoccupato per le sorti di
Israele come in questo momento, ha spiegato che oggi Israele “affronta
minacce senza precedenti nella sua storia, nemici come Hamas, Hezbollah
e Iran mossi da un odio irragionevole, e quest'ultimo con la concreta
eventualità dell'arma nucleare". "Mai la malafede e la disinformazione
verso Israele - ha proseguito - hanno assunto proporzioni tali come in
questo momento: una macchina di delegittimazione e di satanizzazione
che sta sfociando in un nuovo antisemitismo". |
| |
|
|
| |
|
torna su |
| |
L'Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane sviluppa mezzi di comunicazione che
incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche.
Gli
articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente
indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di
posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone
che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili.
Gli
utenti che fossero interessati a partecipare alla sperimentazione
offrendo un proprio contributo, possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it per concordare le modalità di intervento.
Il servizio Notizieflash è realizzato dall'Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane in collaborazione con la Comunità Ebraica di Trieste,
in redazione Daniela Gross.
Avete
ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei
l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere
ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo
e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio “cancella” o “modifica”. |
|
|