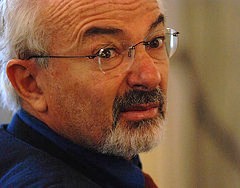David
Bidussa,
storico sociale delle idee
|
 |
La recente legge approvata in
Francia contro la negazione del genocidio armeno, ha fatto riaprire la
discussione, anche in Italia, sull’efficacia, e sulla necessità di una
legge sul negazionismo. Non sono favorevole, ma questo potrebbe essere
considerato un fatto privato. Io invece lo ritengo parte di una
deontologia professionale. Una convinzione che non è una prurigine da
“politicamente corretto” contrapposta a una “sana” politica muscolare.
Considero l’eventualità di una legge contro il negazionismo, prima
ancora che inefficace, un palliativo. In breve inutile e alla fine
segno ed effetto di una pigrizia. E mi spiego. L’obiettivo di chi si
preoccupa dell’insorgenza e della diffusione di convinzioni
negazioniste è quello che non si costruisca una convinzione basata sul
falso. E’ un obiettivo che condivido. Io penso che non lo si
raggiunge né lo si consolida con una legge, bensì con una
didattica e una pedagogia che aiuta a distinguere e porre le differenze
tra vero, falso e finto. E distinguerli implica sviluppare una risposta
al negazionismo che almeno per ciò che compete agli storici non si
limita a fare il giudice “super partes”, ma a scendere in campo e fare
il loro mestiere, ovvero, per esempio, definire e costruire una
didattica della riconoscibilità del falso. La costruzione del falso,
come le bugie, o ancora meglio quella dell’inganno, ha delle regole;
risponde a logiche; si serve di retoriche interpretative e di documenti
che sceglie e mette in ordine; spesso li crea; adotta retoriche
costruttive di narrazioni. Penso che noi storici, una volta ribadita la
libertà della ricerca storica, non possiamo sottrarci dal misurarci
con il tema del falso e della sua diffusione, delle retoriche
che i suoi diffusori adottano. Con la consapevolezza, di tutti, che una
volta aperta la partita sulla verità dei fatti, si avvia una
discussione su ciò che diamo per certo e per vero che non è né
tranquilla né pacifica, ma anzi presume rimettere in discussione molte
cose intorno a ciò che diamo “per scontato”.
|
|
|
|
 |
Davar acher - La nostra
differenza
|
 |
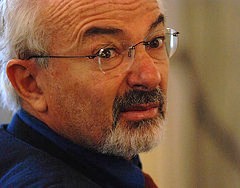 In genere il funzionamento
della memoria culturale è poco compreso, soprattutto se la si tratta
come se fosse equivalente alla storia o alla coscienza politica. Greci
e Romani hanno avuto una grande storiografia; Tacito ed Erodoto, Livio
e Tucidide hanno contribuito certamente a perpetuare per i secoli il
mito di Roma ed Atene; ma non certo a mantenere in vita le loro civiltà
una volta che le condizioni materiali, sociali ed economiche della
sopravvivenza dei loro stati si conclusero, come ha fatto la nostra
memoria, storicamente più discutibile. Essere consapevoli di una
somiglianza del nostro tempo con gli Anni Trenta, oppure con la crisi
della Belle Epoque, con la decadenza dell'Impero Romano o con
l'ellenismo, come alcuni opinano, non significa davvero aver memoria di
quei periodi, ma conoscerne intellettualmente degli aspetti che si
ritengono a torto o a ragione congruenti con i nostri anni. In genere il funzionamento
della memoria culturale è poco compreso, soprattutto se la si tratta
come se fosse equivalente alla storia o alla coscienza politica. Greci
e Romani hanno avuto una grande storiografia; Tacito ed Erodoto, Livio
e Tucidide hanno contribuito certamente a perpetuare per i secoli il
mito di Roma ed Atene; ma non certo a mantenere in vita le loro civiltà
una volta che le condizioni materiali, sociali ed economiche della
sopravvivenza dei loro stati si conclusero, come ha fatto la nostra
memoria, storicamente più discutibile. Essere consapevoli di una
somiglianza del nostro tempo con gli Anni Trenta, oppure con la crisi
della Belle Epoque, con la decadenza dell'Impero Romano o con
l'ellenismo, come alcuni opinano, non significa davvero aver memoria di
quei periodi, ma conoscerne intellettualmente degli aspetti che si
ritengono a torto o a ragione congruenti con i nostri anni.
Nella letteratura specializzata sul tema da Halbwachs a Smith ad Assman
ai recenti lavori italiani del gruppo diretto da Patrizia Violi, la
memoria culturale è la consapevolezza che un gruppo sociale mantiene
della propria identità, spesso usando dispositivi complessi come feste,
libri, giorni di celebrazione, luoghi allestiti a museo o monumento,
rituali. In queste pratiche si trova il carattere volontario della
memoria, che peraltro quando funziona è invece prevalentemente
involontaria, essendo vissuta come un dato, il depositato
dell'esperienza comune di un gruppo e della continuità delle
generazioni: tradizione nel senso pieno del termine. La memoria
collettiva ha un carattere esistenziale, è dunque ben diversa dal
ricordo (sia esso storico o mitico) o dalla comune narrazione (le
"narrative" che secondo la terminologia americana giustificherebbero
senza bisogno di fondamento reale le scelte politiche); in essa è
implicita l'identità, vi sono sviluppati dei valori, vi è indicato il
compito del gruppo, la sua origine, la sua collocazione nel mondo. Per
questa ragione la memoria è sempre fortemente identitaria e vive fino a
che lo rimane. Può essere diffusa, aperta, oggettivata, ma non è
davvero condivisa al di fuori del "noi" che la conserva come l'anima
del gruppo.
Vi possono essere fatti che rientrano in più memorie, come gli eventi di
storia sacra condivisi da più religioni, altri come le guerre e le
crisi religiose possono essere preservati in maniera opposta; ma le
memorie collettive vive sono distinte e mescolarle serve al massimo a
produrne una nuova sincretica, se vi è un gruppo che la fa propria.
Naturalmente una persona può far parte di diversi gruppi, per esempio
essere allo stesso tempo ebreo, italiano, medico, tifoso di calcio.
Queste differenti identità, diversamente profonde ed essenziali per la
persona, chiedono la conservazione individuali di memorie diverse, che
non si confondono. Il solo vero multiculturalismo è nella mente della
persona, prima che nella società.
L'ebraismo ha una memoria particolarmente forte e ben strutturata, viva
da millenni. L'Esodo, per esempio, è spesso preso a prototipo negli
studi recenti di quel lavoro teologico-politico che porta alla
formazione e - con la sua memoria - alla perpetuazione della nazione.
Tutta la Torà è memoria: memoria di regole, costumi, credenze, persone,
cose eventi. Non storia, ma vivo insegnamento, che stabilisce delle
barriere, ammonisce a non fare "come gli Egizi o i Cananei".
Peraltro uno dei rimproveri costanti che gli ebrei subiscono è di
mantenersi attaccati alla loro memoria, di non diluirsi grazie ad essa
nelle popolazioni fra cui vivono. Così ragiona il Faraone prima di
imporre i lavori forzati, così Haman racconta al re di "un popolo
separato e disperso in mezzo agli altri" "che rispetta le sue leggi"
per indurlo allo sterminio, così Tacito e Seneca parlano di un popolo
nemico dell'humanitas (cioè del politically correct dell'impero
romano), così poi la Rivoluzione francese, la Chiesa e l'internazionale
comunista. Tutti combattono contro la separatezza ebraica della memoria
e dell'identità, tutti ci hanno sempre richiamato all'universalismo,
cioè all'accettazione del ricordo, dei valori e delle pratiche della
maggioranza, a scambiare il nostro aspro "egoismo", la nostra grettezza
nemica dell'umanità (cioè ben decisa a non fondersi in essa) nel nome
della dolcezza di essere politeisti come tutti, persiani come tutti,
francesi come tutti, cristiani come tutti (non a caso questo è il
significato del nome "cattolico", katà olos, verso tutto il corpo
sociale), soprattutto laici, comunisti, progressisti come tutti, o
tutti i boni cives, interessati solo al buon andamento dello Stato o
della rivoluzione.
E' successo anche con la Shoà, in cui il tentativo di costruire una
immagine condivisa si è spesso risolto in una distruzione del suo
senso. Ad Auschwitz per Giovanni Paolo II c'era il nuovo Golgota, un
sacrificio o olocausto da accettare cristianamente come fece Edith
Stein; per lo stato polacco vi occorse la distruzione di un milione e
mezzo di polacchi (di varia provenienza religiosa, ma questo occorre
dirlo); per la sinistra che concepì il padiglione italiano, di
deportati, la cui appartenenza religiosa era altrettanto poco
significativa; per i comunisti di comunisti e altri antinazisti; per il
politically correct di varie minoranze (rom, gay, malati mentali,
handicappati, antinazisti e... anche ebrei). Per molti oggi la Shoà è
una delle infinite stragi della storia e va de-etnicizzata. Senza
negare che il nazismo si accanì contro molti nemici, è nostro dovere
ricordare la peculiarità del suo odio antiebraico e della Shoà, come
ricordare fra i crimini dei "re cristianissmi di Spagna" la nostra
cacciata, oltre al colonialismo in Sudamerica e la repressione dei
moriscos e degli eretici.
Questo non significa rifiutare di compiangere altri genocidi (quello
degli armeni, per esempio) o non essere solidali con tutte le vittime
dell'ingiustizia. Ma capire che lo dobbiamo fare in quanto ebrei,
attaccati alla nostra memoria, alla nostra tradizione, ala nostra
identità, sfuggendo ala sirena universalistica che porta
all'autodistruzione culturale. C'è oggi una larga tendenza
politico-culturale che considera dannose e pericolose le identità e le
nazioni, cerca di dimostrarne l'inesistenza o il carattere abusivo - è
l'ultima eredità dell'internazionalismo marxista e l'impropria
attribuzione di tutti i mali del passato all'esistenza di gruppi
identitari, nazionali, religiosi, di popolo. Questa guerra alle
differenze è l'equivalente culturale della globalizzazione. E' una
tendenza fortemente distruttiva di culture, che cerca di applicare a
tutta la vita l'ideale di burocrazie sradicate come quelle europee o
dell'Onu, o l'estetica uniforme e squallida dello stile internazionale
in architettura. Anche senza pensare al nostro ebraismo bisogna
opporvisi. Ogni cultura uniformata è una cultura uccisa, ogni lingua
soppiantata dall'inglese o dal cinese è una lingua morta, ogni cucina
industrializzata è un gusto sparito.
Come ebrei oggi abbiamo sì la missione di diffondere i nostri valori
universali (non universalistici, che è un'altra cosa). Ma abbiamo anche
il compito opposto, quello di difendere e amare la nostra differenza,
la nostra identità, cioè la nostra memoria. E di fare di tale
resistenza all'universalismo o alla globalizzazione culturale un
modello per gli altri popoli. Possiamo essere depositari della
coscienza universali solo se teniamo viva in noi la nostra memoria,
senza barattarla con alcuna ideologia.
Ugo
Volli
|
|
 |
 |
|
|
 |
| notizieflash |
|
rassegna
stampa |
Israele
- Twitter in tribunale
se non oscura i siti terroristici |
|
Leggi la rassegna |
|
Shurat HaDin, un centro legale israeliano, ha dato al social network Twitter,
pochi giorni prima di portare in
Tribunale i vertici dell’azienda se questi non cancellano tutti gli
account riconducibili alle organizzazioni terroristiche. Con il rischio
che, se il giudice dovesse dare ragione agli israeliani, i capi del
social network potrebbero finire alla sbarra per aver offerto supporto
logistico ai terroristi. Secondo gli avvocati di Tel Aviv Twitter
starebbe violando la legge perché ha permesso l’apertura di account
come quello degli Al Shabaab, gli affiliati di Al Qaeda nel Corno
d’Africa, e di «Al Manar», la tv dei miliziani libanesi di Hezbollah. E
così, il direttore del centro legale, Nitsana Darshan-Leitner, ha
scritto ai vertici di Twitter. Il dibattito, tra chi difende Twitter e
chi chiede maggiore controllo della Rete è aperto.
|
|
|
|
 |
| L'Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane sviluppa mezzi di comunicazione che
incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche. Gli
articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente
indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di
posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone
che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili. Gli utenti
che fossero interessati a offrire un proprio contributo possono
rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it
Avete ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei
l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere
ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo
e-mail, scrivete a: desk@ucei.it
indicando nell'oggetto del messaggio “cancella” o “modifica”. © UCEI -
Tutti i diritti riservati - I testi possono essere riprodotti solo dopo
aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Direzione. l'Unione
informa - notiziario quotidiano dell'ebraismo italiano - Reg. Tribunale
di Roma 199/2009 - direttore responsabile: Guido Vitale.
|
|
|








 Il primo giorno di
gennaio è tradizionalmente un momento di quiete per i giornali
quotidiani italiani, che sono assenti dalle edicole solo in cinque
giornate del calendario. La redazione del Portale dell'ebraismo
italiano www.moked.it (che realizza fra l'altro questo notiziario
quotidiano, la Rassegna stampa, il giornale dell'ebraismo italiano
Pagine Ebraiche, il giornale di cronache comunitarie Italia Ebraica e
il giornale ebraico per bambini DafDaf) segue invece il ritmo del
calendario ebraico e non ha mai rinunciato al proprio appuntamento
quotidiano con il lettore.
Il primo giorno di
gennaio è tradizionalmente un momento di quiete per i giornali
quotidiani italiani, che sono assenti dalle edicole solo in cinque
giornate del calendario. La redazione del Portale dell'ebraismo
italiano www.moked.it (che realizza fra l'altro questo notiziario
quotidiano, la Rassegna stampa, il giornale dell'ebraismo italiano
Pagine Ebraiche, il giornale di cronache comunitarie Italia Ebraica e
il giornale ebraico per bambini DafDaf) segue invece il ritmo del
calendario ebraico e non ha mai rinunciato al proprio appuntamento
quotidiano con il lettore.  Così la serata di ieri e la
mattinata di oggi sono state utili fra l'altro per mettere a punto la
prima novità del 2012 che la redazione offre al lettore. Grazie
all'applicazione lanciata poche ore fa, Pagine Ebraiche, Italia Ebraica
e DadDaf sono ora sfogliabili direttamente all'interno della propria
posizione Facebook.
Così la serata di ieri e la
mattinata di oggi sono state utili fra l'altro per mettere a punto la
prima novità del 2012 che la redazione offre al lettore. Grazie
all'applicazione lanciata poche ore fa, Pagine Ebraiche, Italia Ebraica
e DadDaf sono ora sfogliabili direttamente all'interno della propria
posizione Facebook.  distanza e senza avere a
portata di mano la carta stampata. L'applicazione completa la presenza
dei tre giornali su tablet e smartphone (Apple e Android, come iPhone,
iPad e molti altri) lanciata lo scorso agosto. Non solo l'ultimo
numero, quello di questo gennaio 2012 attualmente in distribuzione, ma
anche tutti gli arretrati sono da subito disponibili per consultazione.
Per raggiungere l'applicazione è sufficiente cercare le parole “pagine
ebraiche” nella casella di ricerca di www.facebook.com l'applicazione
con il pulsante del simbolo di Pagine Ebraiche si colloca
automaticamente all'interno dei comandi della propria posizione
Facebook e resta sempre disponibile.
distanza e senza avere a
portata di mano la carta stampata. L'applicazione completa la presenza
dei tre giornali su tablet e smartphone (Apple e Android, come iPhone,
iPad e molti altri) lanciata lo scorso agosto. Non solo l'ultimo
numero, quello di questo gennaio 2012 attualmente in distribuzione, ma
anche tutti gli arretrati sono da subito disponibili per consultazione.
Per raggiungere l'applicazione è sufficiente cercare le parole “pagine
ebraiche” nella casella di ricerca di www.facebook.com l'applicazione
con il pulsante del simbolo di Pagine Ebraiche si colloca
automaticamente all'interno dei comandi della propria posizione
Facebook e resta sempre disponibile. L'universo dei social
network contiene talvolta messaggi insignificanti e frammentari, ma
anche di straordinarie occasioni di informazione e conoscenza, è
popolato da insidie e da minacce per gli spazi di cui cercano di
approfittare coloro che cercano di seminare odio attraverso la rete, e
proprio per questo rappresenta una realtà in cui è necessaria una
presenza ebraica matura e consapevole, ma anche attenta a tenere aperto
il dialogo con la società circostante e non perdere il contatto con le
giovani generazioni. Facebook in particolare conta in Italia su 21
milioni di utenti attivi almeno una volta al mese e 13 milioni di
utenti attivi almeno una volta al giorno e in genere si calcola che
oltre la metà del tempo speso online dalla popolazione italiana sia
dedicato a questo social network.
L'universo dei social
network contiene talvolta messaggi insignificanti e frammentari, ma
anche di straordinarie occasioni di informazione e conoscenza, è
popolato da insidie e da minacce per gli spazi di cui cercano di
approfittare coloro che cercano di seminare odio attraverso la rete, e
proprio per questo rappresenta una realtà in cui è necessaria una
presenza ebraica matura e consapevole, ma anche attenta a tenere aperto
il dialogo con la società circostante e non perdere il contatto con le
giovani generazioni. Facebook in particolare conta in Italia su 21
milioni di utenti attivi almeno una volta al mese e 13 milioni di
utenti attivi almeno una volta al giorno e in genere si calcola che
oltre la metà del tempo speso online dalla popolazione italiana sia
dedicato a questo social network.
 Il presidente della
Comunità ebraica di Milano Roberto Jarach ha diffuso, anche a nome del
gruppo di maggioranza che governa la seconda realtà ebraica italiana,
la seguente nota:
Il presidente della
Comunità ebraica di Milano Roberto Jarach ha diffuso, anche a nome del
gruppo di maggioranza che governa la seconda realtà ebraica italiana,
la seguente nota: