L’ultimo giorno di Yitzhak Rabin
e il grande dramma di Israele
 Ai primi di novembre saranno vent’anni. Vent’anni senza Rabin, per chi in questo protagonista della storia di Israele ha visto un punto di riferimento, ma soprattutto vent’anni di un’Israele diversa da quello che avevano sognato i padri fondatori, un’Israele che ha conosciuto la macchia della sedizione e della violenza, della politica praticata attraverso l’eliminazione brutale dell’avversario, dell’omicidio finalizzato al rovesciamento delle istituzioni.
Ai primi di novembre saranno vent’anni. Vent’anni senza Rabin, per chi in questo protagonista della storia di Israele ha visto un punto di riferimento, ma soprattutto vent’anni di un’Israele diversa da quello che avevano sognato i padri fondatori, un’Israele che ha conosciuto la macchia della sedizione e della violenza, della politica praticata attraverso l’eliminazione brutale dell’avversario, dell’omicidio finalizzato al rovesciamento delle istituzioni.
Era il 4 novembre del 1995 e vent’anni dopo, il prossimo 4 novembre, nella maggiore sala cinematografica di Tel Aviv, a pochi metri dalla piazza dove fu assassinato Yitzhak Rabin e in contemporanea nelle sale cinematografiche di mezzo mondo, il regista israeliano Amos Gitai ha deciso di proiettare il suo film dedicato a L’ultimo giorno di Rabin.
Presentato in anteprima ai giornalisti che partecipano alla settantaduesima Mostra del cinema della Biennale di Venezia, il film lascia subito comprendere che si tratta di un’operazione destinata a lasciare il segno.
Lascerà il segno perché Gitai è certo un personaggio ingombrante e talvolta anche assai irritante ma resta, comunque lo si voglia considerare, un grandissimo regista, e di fronte a questa prova impartisce a tutti una lezione di tecnica e di impegno civile magistrale.
Lascerà il segno perché il regista nel realizzare una meticolosa ricostruzione dell’assassinio del primo ministro ad opera di uno squilibrato cresciuto negli ambienti dell’estremismo religioso israeliano ha potuto avere accesso a materiali e documenti fino ad ora inediti, o comunque poco conosciuti. E mettendo in campo la sua professionalità fuori dal comune ci conduce nella rivisitazione di un momento fondamentale della dolorosa storia recente di Israele. È un’operazione capace di mettere bene in equilibrio documenti e documentari e lavoro di attori formidabili, chiamati in particolare a rivivere le sedute della Commissione d’inchiesta affidata al giudice della Corte suprema Meir Shamgar e incaricata di stabilire quali falle nei sistemi di sicurezza avessero consentito a un terrorista di infiltrarsi fino a raggiungere Rabin e a colpirlo con tre colpi di pistola.
Gitai evita accuratamente di mettere al centro della scena la stessa figura del leader laburista israeliano, che appare sullo schermo solo nei fotogrammi del materiale documentario. Quello che va cercando, e che riesce impietosamente a trovare, è una definizione, un ritratto della società israeliana di quei giorni, delle sue ferite e dei suoi problemi.
Chi poteva legittimamente temere che il film si abbandonasse alle teorie cospirative, alla denuncia di un cancro interno al mondo politico israeliano, a una corruzione capace di compromettere le istituzioni e di cui in realtà non è mai emerso alcun elemento di prova resterà così deluso, perché Gitai evita abilmente il tranello del semplicismo.
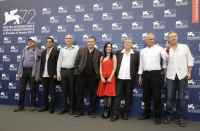 Il film punta invece sul clima di odio e di propaganda che pervase ampi strati della società israeliana all’indomani degli accordi di Oslo. Parole, gesti, cerimonie religiose, comizi in cui grondavano i segni di morte e che videro protagonista anche l’attuale primo ministro Netanyahu, allora leader dell’opposizione, aprirono secondo Gitai la strada all’odio e armarono ideologicamente la mano dell’assassino. Non si tratta della rivelazione di fatti nuovi, perché si tratta di situazioni già più o meno note, ma di un’abile ricostruzione cinematografica che restituisce allo spettatore un’emozione molto forte. Oggi, dopo vent’anni di una politica dell’odio e dell’esclusione che ammorba purtroppo anche il mondo ebraico e dopo un utilizzo infame e cinico delle potenzialità dei social network per diffondere frammenti avvelenati di esclusione, di sospetto, di calunnia, di intolleranza e di odio possiamo guardare, in Israele e nell’intero mondo ebraico, ai vent’anni che che ci stanno alle spalle come ai vent’anni della frattura e del tradimento dagli ideali dei padri fondatori.
Il film punta invece sul clima di odio e di propaganda che pervase ampi strati della società israeliana all’indomani degli accordi di Oslo. Parole, gesti, cerimonie religiose, comizi in cui grondavano i segni di morte e che videro protagonista anche l’attuale primo ministro Netanyahu, allora leader dell’opposizione, aprirono secondo Gitai la strada all’odio e armarono ideologicamente la mano dell’assassino. Non si tratta della rivelazione di fatti nuovi, perché si tratta di situazioni già più o meno note, ma di un’abile ricostruzione cinematografica che restituisce allo spettatore un’emozione molto forte. Oggi, dopo vent’anni di una politica dell’odio e dell’esclusione che ammorba purtroppo anche il mondo ebraico e dopo un utilizzo infame e cinico delle potenzialità dei social network per diffondere frammenti avvelenati di esclusione, di sospetto, di calunnia, di intolleranza e di odio possiamo guardare, in Israele e nell’intero mondo ebraico, ai vent’anni che che ci stanno alle spalle come ai vent’anni della frattura e del tradimento dagli ideali dei padri fondatori.
Israele, afferma Gitai, da allora non è guarita dalle sue ferite e non ha recuperato l’unica energia capace di garantirne l’effettiva sicurezza: la speranza. Molto abilmente, con un colpo di teatro che ha riportato lo spettacolo in primo piano, il regista è apparso al Lido in conferenza stampa chiedendo ai giornalisti di alzarsi per rispettare un minuto di silenzio in memoria della palestinese Reham Dewabsheh, morta solo poche ore prima, di suo marito e del figlio di 18 mesi arsi vivi in una mostruosa azione che la stessa Presidenza della Repubblica di Israele ha attribuito proprio a quel mondo di estremisti nazionalisti ultrareligiosi che costituiscono oggi una delle più gravi minacce all’integrità e alla sicurezza dello Stato ebraico.
La critica internazionale rende oggi omaggio al coraggio del registra israeliano e afferma in coro che Gitai non fa sconti a nessuno. Questo è vero solo in parte. Certamente il regista firma un film solido, rigoroso e per molti aspetti inattaccabile. Ma di qualche sconto, o almeno di qualche omissione, la pellicola porta il segno. Quello che Gitai dimentica di analizzare, e soprattutto quello che al lettore non avvertito rischia di sfuggire, è la grandezza di Israele e l’immensa moralità del suo sistema politico. Non è possibile per capire quegli anni sottacere che gli accordi di Oslo sortirono, come ha ricordato molto efficacemente anche l’ideologo della destra nazionalista israeliana Israel Harel, un effetto oggettivamente disastroso. Gli sforzi di pace, quando non incontrano la disponibilità sincera di una controparte che fu capace di reagire agli sforzi diplomatici solo con una recrudescenza del terrorismo contro la popolazione civile, possono tramutarsi in Medio Oriente in una carneficina. E ovviamente, a meno di non voler cedere a interpretazioni di comodo che possono piacere solo a chi non si sente pronto ad assumersi le proprie responsabilità di fronte a un disastro diplomatico di vaste proporzioni come fu quello rappresentato da Oslo, non tutti gli oppositori della politica di Rabin possono essere collocati in quell’area oscura che armò ideologicamente la mano dei terroristi.
Il lavoro della Commissione Shamgar, inoltre, appare a chi osserva una dimostrazione di enorme attenzione e dignità delle istituzioni. E i finanziamenti pubblici israeliani che hanno consentito la realizzazione di questo film testimoniano di un Paese alle prese con gravi difficoltà che non è solo l’unica democrazia del Medio Oriente, ma che ha a disposizione un tale patrimonio di libertà e di democrazia da potersi permettere, nel perdurare di un governo di segno opposto a quello che Rabin intendeva rappresentare, di fare onore e di dare voce a un regista certo grande, ma terribilmente scomodo, e a una rappresentazione cruda e straziante, ma tutto sommato ancorata alla sincera ricerca della verità e al dolore di Israele.
gv
(8 settembre 2015)
