| se non visualizzi correttamente questo messaggio, fai click qui |
| |
| |
 |
|
L'Unione informa |
|
| |
|
30 ottobre 2009-12 Cheshwan 5770 |
|
 |
|
| |

|
| alef/tav |
|
|
 |
| |
 |
Roberto Colombo,
rabbino |
Dio disse al primo ebreo: “Conta le stelle. Puoi forse contarle? Così saranno i tuoi figli” (lekh lekhà).
Significa forse che non sarà possibile contare gli ebrei? Eppure spesso
nella Torà essi vengono contati e il loro numero definito. Il versetto
in realtà significa: anche se
le stelle non si possono contare tu Avraham dovrai provarci ugualmente.
Se lo farai allora da te nasceranno dei figli che impareranno a non
fermarsi di fronte a ciò che sembra impossibile. Questa è la
caratteristica che ha reso grande Israele (rav ‘Zolty)
|
 |
Abbiamo
fatto l'abitudine a molti orrori, ma a questo proprio non riesco ad
abituarmi: la terribile, spietata indifferenza della gente ai morti, ai
corpi
abbandonati davanti a loro. Quella persona che scavalca il
corpo del morto ammazzato dalla camorra ieri a Napoli non è diversa da
chi ha sparato. La differenza è che possiamo arrestare e mettere in
galera gli esecutori dell'assassinio, ma non chi continua indifferente
a camminare, fare spese, nuotare in piscina vicino a corpi morti che
solo poco prima erano vivi, come loro. Contro questo possiamo fare
pochissimo, nulla forse. La pietà è ormai morta, e nessuno ci fa caso.
|
Anna Foa,
storica |
 |
|
|
 |
|
|
torna su |
| davar |
|
|
| |
| |
 Hitler e la campionessa ebrea Hitler e la campionessa ebrea
Durante gli ultimi Mondiali di atletica leggera a Berlino, è
giunta la notizia di un caso sportivo a sfondo sessuale. Caster
Semenya, la 18enne sudafricana medaglia d’oro negli 800 metri, è uomo,
donna o ermafrodita? Mistero scottante ma allo stesso tempo curioso.
Perché Berlino non è nuova a vicende che cavalcano l’androgino confine
tra uomo e donna. Così “Berlin 36”, il nuovo film del regista tedesco Kaspar Heidelbach,
racconta proprio l’assurda vicenda che, alle Olimpiadi naziste del
1936, ebbe come protagoniste una brillante atleta ebrea tedesca e una
compagna di squadra dalle coordinate sessuali indefinite.
Il film,
che ha fatto il suo esordio nelle sale tedesche il 10 settembre e che
in Germania ha già ricevuto critiche positive - “emozionante” per lo
“Spiegel”, “commovente” per la “Zeit” -, ha come interpreti, oltre a
Sebastian Urzendowsky e Axel Prahl, la berlinese Karoline Herfurth.
Recentemente vista in “The Reader” con Kate Winslet, interpreta la
(struggente) storia vera dell’ebrea tedesca Gretel Bergmann.
 Un
prodigio del salto in alto che però, subito dopo l’avvento di Hitler,
viene costretta ad abbandonare la natale Germania. È il 1933 e la
diciannovenne Gretel si rifugia in Inghilterra. Dove continua a
raggranellare record nazionali nel salto in alto. Un
prodigio del salto in alto che però, subito dopo l’avvento di Hitler,
viene costretta ad abbandonare la natale Germania. È il 1933 e la
diciannovenne Gretel si rifugia in Inghilterra. Dove continua a
raggranellare record nazionali nel salto in alto.
Ma ecco che
gli americani fanno pressione sui tedeschi. Alle Olimpiadi di Berlino
1936, vetrina della superiorità fisica ariana secondo i piani di
Hitler, gli Stati Uniti chiedono espressamente ai tedeschi di inserire
nelle loro squadre atleti di origine ebraica. Pena il boicottaggio dei
Giochi. Il Führer allora decide di non rischiare. Anche perché nelle
precedenti Olimpiadi di Los Angeles gli americani hanno stravinto con
103 medaglie – contro le sole 20 dei tedeschi. Dimostrare la
“superiorità ariana” senza gli Usa sarebbe patetico. E così nel 1935 la
Bergmann viene reintegrata nella squadra nazista. Gretel si allena
strenuamente e nell’ultimo mese eguaglia anche il record tedesco nel
salto in alto (1,60 m). Una medaglia alle Olimpiadi sembra assicurata.
Il
mendace meccanismo si inceppa però sul più bello. I tedeschi, dopo aver
illuso gli americani, danno un clamoroso benservito alla Bergmann,
perché “non soddisfatti” delle potenzialità mostrate in allenamento. Il
tutto a due settimane dall’inizio dei Giochi. Gretel emigra, stavolta
per sempre, a New York.
La sua sostituta sarà la compagna di
stanza Dora Ratjen. Un’atleta dagli atteggiamenti spesso insoliti.
“Quando facevamo la doccia tutte assieme non si faceva vedere mai
nuda”, ricorda proprio la 95enne Bergmann in un’intervista recentemente
concessa allo “Spiegel”. “C’era una porticina con un bagnetto, dove
solo Dora poteva entrare. 'Che strano' pensavamo tutte. Ma non avrei
mai immaginato quello che poi ho scoperto dopo molti anni”.
E cioè
che Dora, che a Berlino 1936 arriverà quarta, è in realtà un uomo.
Molte atlete lo sospettavano. Ma la conferma definitiva arriverà solo
due anni dopo. Quando alla stazione di Magdeburgo, di ritorno dagli
Europei di Vienna del 1938 – dove ha appena infranto il record mondiale
del salto in alto – la Ratjen viene notata da due donne. “Dora”, vero
nome Hermann, ha sì la gonna, ma anche quell’accenno di barbetta
incolta che gli inglesi chiamano “delle 5 del pomeriggio”. Arrivano
medico e polizia e la carriera sportiva di Hermann “Dora” termina
miseramente, costituendo l’unico caso accertato di frode sessuale alle
Olimpiadi moderne.
“Io invece l’ho scoperto solo nel 1966, dal
dentista, mentre leggevo il Time”, dichiara la defraudata Bergmann.
Dora-Hermann verrà allo scoperto nel 1957, dichiarando alla stampa come
fu “costretto” dai nazisti a travestirsi da donna. Da quel momento, si
sa che ha fatto il cameriere ad Amburgo e Brema. Poi quasi più nulla,
sino alla morte il 22 aprile 2008.
La Bergmann invece farà di
tutto per dimenticare la Germania. Non vi tornerà più sino al 1999
quando, quasi controvoglia, sarà nella città natale di Laupheim per
presenziare alla cerimonia di uno stadio locale, a lei intitolato. Ma
Gretel avrà dimenticato la sua madrelingua. E per parlare con i suoi
(ex) connazionali chiederà un interprete.
Antonello Guerrera
Qui Roma - Musica, canti yiddish e tanti amici
nella serata in ricordo di Alberto Nirenstein
 Un invito a conoscere e a studiare la Resistenza ebraica è stato
lanciato dal Presidente della Comunità Ebraica di Roma Riccardo
Pacifici in occasione della serata dedicata alla memoria di Alberto
Nirenstein, giornalista, scrittore, combattente per la libertà, un uomo
che seppe non soltanto credere in un ideale, ma anche combattere per
questo e per le proprie idee.
Un invito a conoscere e a studiare la Resistenza ebraica è stato
lanciato dal Presidente della Comunità Ebraica di Roma Riccardo
Pacifici in occasione della serata dedicata alla memoria di Alberto
Nirenstein, giornalista, scrittore, combattente per la libertà, un uomo
che seppe non soltanto credere in un ideale, ma anche combattere per
questo e per le proprie idee.
Alla
serata dedicata ad Alberto Nirenstein, hanno preso parte lo psicologo e
direttore del Master in didattica della Shoah David Meghnagi, Ernesto
Galli della Loggia editorialista del Corriere della Sera e professore
Ordinario di Storia Contemporanea e il giornalista Luciano Tas.
Fra
il pubblico seduto in sala era presente ovviamente la famiglia di
Alberto Nirestein, le figlie Fiamma (giornalista e deputata del Pdl),
Susanna (giornalista per La Repubblica), Simona musicista e
musicoterapeuta, e la moglie Wanda Lattes oltre che Olga D’Antona
(deputata del Pd).
La serata organizzata dal Master internazionale
di didattica sulla Shoah,che ha raccolto studenti arrivati da ogni
parte di Italia, e dal Centro di Cultura Ebraica, ha ripercorso non
soltanto la storia personale avventurosa e appassionante di Alberto
Nirenstein, ma anche, attraverso musiche e letture, la sua carriera di
scrittore e le sue passioni. I canti in yiddish eseguiti da Miriam
Meghnagi, hanno rievocato la lingua natale di Alberto Nirenstein oltre
che la cultura di un mondo scomparso, quella dello shetl polacco in cui
era nato a Baranow nel 1915, con il quale l’unico legame possibile a
seguito della distruzione nazista era quello nostalgico.
Come
sottolineato da David Meghnagi, Alberto Nirestein fu uno storico
antesignano della ricerca sulla Shoah, ma di una ricerca condotta sul
campo, caratterizzata da un forte pathos. Basti ricordare il più
importante degli scritti storiografici di Alberto Nirestein “Ricorda cosa ti ha fatto Amalek” in cui la ricostruzione storiografica si fonde con l’imperativo 'ricorda' della tradizione ebraica,divenendo un dovere morale.
Della
sua prosa Meghnagi ha sottolineato la capacità semantica, la ricchezza
apportata nel linguaggio dalla contaminazione linguistica, dalla
sovrapposizione fra la lingua polacca natia, lo yiddish e la la lungua
italiana ospitante. Tutto ciò conferiva alla sua prosa una
inconfondibile polisemia.
Ed effettivamente ascoltando la lettura
di brani tratti dai suoi libri si resta sorpresi dalla capacità di
descrivere l’atrocità mischiando la durezza realista dell’orrore e la
compassione.
La moglie Wanda Lattes, che conobbe Alberto
Nirenstein a Firenze quando quest'ultimo si arruolò nella Brigata
Ebraica risalendo l’Italia per combattere i nazisti dopo lo sbarco
avvenuto a Salerno, ha sottolineato la sua capacità di storico della
Shoah, mai abbastanza riconosciuta. Ricordando di come negli anni '60,
tutto ciò che oggi sembra acquisito nella didattica del ricordo e
del racconto della Shoah, in realtà fu allora il frutto di una
ricerca pionieristica, fra l’altro condotta sulle fonti direttamente a
Varsavia, dove Alberto Nirenstein fu tenuto prigioniero per 4 anni
dopo la fine della guerra, quando vi tornò per raccogliere documenti.
Proprio a Varsavia, Alberto Nirestein potè guardare in faccia la
catastrofe nelle rovine del ghetto e ricercare piani di trasporto
Hitleriani, i documenti della resistenza ebraica e delle cariche
politiche cittadine che collaborarono con i nazisti.
Sia
Ernesto Galli della Loggia che Luciano Tas hanno sottolineato
tratti del carattere di questo studioso fuori dalle convenzioni,
ricordandone la vita avventurosa, la fuga dalla Polonia occupata dai
nazisti e l’arrivo nella Palestina del Mandato britannico fino
all’arruolamento alla Brigata Ebraica.
Daniele Ascarelli
|
|
| |
|
|
torna su |
| pilpul |
|
|
| |
| |
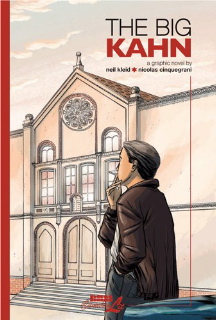 Fumetto - The big Kahn di Neil Kleid Fumetto - The big Kahn di Neil Kleid
e Nicholas Cinquegrani
Nuova graphic novel per Neil Kleid un autore statunitense molto prolifico, come si può ben leggere nel suo sito web, con collaborazioni con Marvel, Dark Horse, Image Comics.
The
big Kahn è una storia particolarmente drammatica e triste. Durante il
funerale di un Rabbino, un uomo si presenta e rivela che il defunto non
è ebreo. Fu un inganno ideato decenni prima, doveva essere una truffa,
ma l’uomo si innamora di una ragazza ebrea ed ecco il pasticcio fatto.
Si sposano, lui studia e diventa il Rabbino della comunità.
Tutto
ciò che il padre ha insegnato ai tre figli viene messo in dubbio, uno
dei quali è anche un giovane Rabbino. Ognuno di loro si confronta con
il suo mondo. La figlia è una ribelle, che rifiuta in qualche modo le
sue origini ebraiche, ma nello stesso tempo ha i ricordi più dolci e
belli del padre. L’uomo appare sempre presente, vicino alla figlia,
insegnandole le parole del Signore.
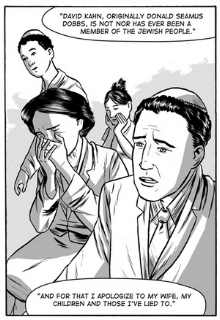 Il
figlio più piccolo eredita dal padre una scatola dove sono conservati
tutti i segreti dell’inganno, giochi di carte, trucchi da
prestigiatore. Il ragazzo cerca di applicare quei trucchi, ma gli manca
l’esperienza. Il
figlio più piccolo eredita dal padre una scatola dove sono conservati
tutti i segreti dell’inganno, giochi di carte, trucchi da
prestigiatore. Il ragazzo cerca di applicare quei trucchi, ma gli manca
l’esperienza.
Il primogenito si trova nel panico, commette i
peccati classici in queste situazioni di sbandamento: dubita del
Signore, si ubriaca e pratica sesso prima del matrimonio. Il giovane
uomo è sconvolto, il fatto che il padre abbia mentito va a scuotere le
fondamenta della sua educazione religiosa, del suo ruolo di figlio,
fratello e uomo.
La parola che Kleid ripete più
frequentemente è “mentire”, il figlio dice che mentre insegnava la
verità, il padre mentiva. Il giovane Eli scioglierà il suo nodo, i suoi
dubbi? Riuscirà a risolvere il dilemma del confine tra la menzogna del
padre e le fondamenta della sua formazione religiosa? Può la figura di
un padre essere così importante da scuotere anche i pilastri formativi
della propria fede?
Sembra di si, ci dice Kleid. Questo fumetto ci
scuote per i suoi temi drammatici, ci stimola alla riflessione su quali
basi si fondano i nostri valori e quanto sia importante la figura dei
genitori, non solo nella formazione di uomini e donne, ma nel
sorreggere le strade su cui percorriamo la nostra vita.
Per ora pubblicato negli Stati Uniti da ComicsLit della NBM di New York, lo trovate su www.amazon.com
Andrea Grilli
|
|
| |
|
|
torna su |
| rassegna stampa |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
Più
che notizie la rassegna stampa di oggi ha a che fare con ritagli di
notizie, fatterelli e eventi minori che non si impongono al lettore per
una qualche priorità o prevalenza. Facendo un piccolo esercizio di
orgoglio nazionale (che non vuole però essere campanilismo, sia ben
chiaro) ed evitando di assumere ancora una volta lo stereotipo
offertoci dal cinismo, del quale non facciamo mai difetto, nutrendo un
bassissimo grado di autoconsiderazione, rimandiamo invece a quegli
articoli che raccontano del capitale di credibilità che la nostra
missione militare presso l’Unifil nel Libano meridionale, ha costruito
e quindi raccolto, soprattutto in Israele, dove i complimenti non sono
certo difettati nei confronti dei nostri 2.400 militari, attualmente
ancora impegnati in quell’area. Così Gianandrea Gaiani per il Foglio, Fausto Biloslavo sempre sulla medesima testata, ma anche Fabrizio Battistelli per il Corriere della Sera, Alberto Stabile per la Repubblica, Carlo Marroni per il Sole 24 Ore, Andrea Colombo per Libero, Umberto De Giovannangeli per l’Unità, ma anche il Giornale così come il Messaggero.
Possiamo andarne legittimamente fieri, insomma. La questione
dell’altrui stima è emersa, non a caso, in tempi di avvicendamento,
quando al comando italiano dovrebbe presto succedere quello spagnolo.
Una telefonata del premier israeliano Benjamin Netanyahu a quello
italiano Berlusconi, nel corso della quale il primo pare abbia chiesto
al secondo di prolungare di sei mesi la presenza italiana ai vertici
Unifil, ha creato tensioni a Madrid ma ha rivelato l’importanza
decisiva di una saggia gestione di quel territorio, quando posto sotto
la propria giurisdizione. L’azione dei nostri militari ha puntato a una
mediazione ragionata e non a un perdente scontro frontale. D’altro
canto, se così non fosse stato, in tutta probabilità, oggi dovremmo
piangere i nostri morti anche su quel teatro conflittuale. Il
comandante, il generale Claudio Graziani, sa sommare alle doti che sono
richieste ad un professionista in campo militare l’intelligenza e
l’equilibrio di chi ha piena coscienza del fatto che le armi sono
senz’altro una importante risorsa ma solo l’ultima e la più estrema
alla quale fare ricorso. Più in generale, noi e i contingenti degli
altri paesi che partecipano alle attività di «peace keeping» e «peace
enforcing», svolta in luoghi martoriati da decenni di guerra civile,
abbiamo il fondamentale ruolo di esportare un modello di convivenza
possibile. Non si tratta, sia ben chiaro, dell’ennesimo esercizio
retorico sui buoni sentimenti, che da sé nulla ottiene né – tanto meno
- riesce a garantire sul lungo periodo, ma la necessaria
attenzione per tutti quei passi politici (e di intelligence) che
dovrebbero accompagnare ogni missione militare all’esterno. Per gli
italiani, che hanno oramai una quasi trentennale esperienza nel paese
dei cedri, si tratta ancora di una conferma nei confronti di una linea
di condotta che si è quasi sempre ispirata a questi presupposti. Non è
questione di cautela bensì di intelligenza. Voltiamo pagina, anche se i
temi rimangono quelli legati al Medio Oriente. Si evidenzia, tra i
diversi articoli, l’intervista che Lally Weymouth ha fatto al premier
israeliano Benjamin Netanyahu, pubblicata in Italia su l’Espresso
ma ripresa da Newsweek. I temi dell’agenda del primo ministro sono
tutto fuorché inediti: la minaccia nucleare iraniana, sulla quale si
soffermano oggi Tatiana Boutourline per il Foglio, Anna Momigliano su il Riformista, e con giudizi molto diversi, Maurizio Stefanini per Libero e Tiziana Barrucci su Gli Altri,
non meno della creazione di uno Stato palestinese, costituiscono
l’orizzonte di Gerusalemme, al quale deve necessariamente volgere lo
sguardo, domandandosi quali possano essere le migliori mosse dinanzi
all’incertezza del divenire. In realtà, tra le pieghe del discorso del
primo ministro, si coglie la difficoltà che l’attuale esecutivo
israeliano ha di intrattenere rapporti profittevoli con
l’amministrazione americana. Se fino al tardo autunno dell’anno scorso,
quando ancora era in carica George W. Bush, le vedute del primo era
quasi pienamente collimanti con quelle della seconda, traducendosi in
una unione di intenti che aveva permesso ad Israele di far valere le
sue ragioni, oggi il margine di perplessità, che si è fatto sempre più
corposo, pare dominare la scena. Diplomaticamente Netanyahu si chiama
fuori dall’inevitabile tentativo della giornalista di raccogliere un
qualche chiaro malumore ma è certo, se si intende leggere tra le righe
delle altrui affermazioni, che la cautela lessicale indichi un
mutamento nei rapporti. Peraltro, una «dottrina Obama» per il Medio
Oriente fatica ad affermarsi. Al momento sembra prevalere, quanto meno
sul piano delle relazioni diplomatiche, una sorta di standby, in attesa
che il tempo si incarichi di definire le reali priorità. L’affettuosa
intesa degli anni trascorsi è venuta meno, subentrando una sorta di
reciprocità fredda, dettata anche dall’apparente stallo dell’iniziativa
politica in tutta la regione. Il quale non è dettato tanto dalla
volontà (o dall’assenza di volontà) degli americani ma, tra le altre
cose, dalla obiettiva difficoltà ad identificare degli interlocutori
credibili sia in caso palestinese che in quello iraniano. Dai tempi
della diplomazia kissingeriana, quella dello «step-by-step», ad oggi il
riuscire ad incidere politicamente sul Medio Oriente è stato per
Washington un elemento peraltro premiante, ancorché problematico. Fino
agli anni precedenti a Nixon la realtà regionale era stata trascurata,
essendo altri i nodi maggiormente critici e le emergenze, a partire dal
sud-est asiatico. L’attenzione per quel che avveniva nel Mediterraneo
orientale è poi andata lievitando soprattutto con la guerra dello Yom
Kippur, nel 1973, e il conseguente «shock petrolifero». Da allora, sia
pure con fasi alterne, i conflitti in corso nell’area, a partire da
quello israelo-palestinese, hanno assunto una centralità
precedentemente inesistente. Per la verità una lettura frettolosa – e
meramente ideologica - del legame tra Gerusalemme e Washington ha
indotto certuni, soprattutto i detrattori dell’uno come dell’altro
paese, ad affermare che esso fosse fondato sulla dipendenza totale,
quasi una soggezione permanente, di un soggetto dall’altro. Per quanti
si riconoscono nell’”interpretazione” che vede Israele come il prodotto
del “neocolonialismo americano”, massima è quindi l’enfatizzazione del
nesso che legherebbe lo Stato degli ebrei agli Stati Uniti, essendone
una sorta di lunga mano, istituita alla bisogna, per garantire la
tutela degli interessi americani in una regione petrolifera, ovvero
strategica per la produzione e il commercio dell’energia. Per coloro
che invece ribaltano il rapporto, sarebbero gli statunitensi a
dipendere dagli israeliani, i quali letteralmente manipolerebbero la
politica estera della superopotenza a proprio diretto benefico,
riuscendo ad influenzare direttamente le scelte di Washington. In
realtà né l’una né l’altra ipotesi hanno una qualche grado di
fondamento, se lette come in sé esaustive dello spettro variegato di
ruoli e condotte. La politica americana verso Gerusalemme, e in Medio
Oriente, pur vantando anche momenti di«special relationship», che è
andata confermandosi dagli anni di Ronald Reagan in poi, è sempre stata
il prodotto di posizioni articolate se non contrapposte. La
tradizionale diarchia in politica estera tra presidenza (in genere più
sensibile a Israele) e Dipartimento di Stato (proclive ad accogliere le
istanze provenienti dal mondo arabo), spesso trascesa in conflitto di
interessi e interpretazioni, rimane quindi la nota dominate nella
formulazione della politica mediterranea di Washington. Anche da come
verrà risolta da Obama questa differenza competitiva tra due
fondamentali istituzioni della politica americana dipendono – quindi -
gli indirizzi di fondo degli Stati Uniti verso uno scenario complesso,
nel quale l’apparente inerzialità dell’azione politica non implica che,
carsicamente, qualcosa non stia trasformandosi.
Claudio Vercelli |
|
| |
|
|
torna su |
| notizieflash |
|
|
| |
| |
Per Cossiga mani libere a Israele nei confronti dell'Iran
Tel Aviv, 30 ott -
Il
presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, in una
intervista pubblicata dal giornale Yediot Ahronot di Tel Aviv, sostiene
che Israele dovrebbe avere le mani libere sullo spinoso dossier
nucleare di Teheran e poter decidere da solo un eventuale attacco
preventivo contro obiettivi iraniani. "Le grandi potenze possono
continuare il loro dialogo con l'Iran, ma non devono intralciare
Israele nella progettazione di un intervento militare", ha detto
Cossiga. "Se io fossi il premier israeliano attaccherei, certo", ha poi
aggiunto rispondendo a una domanda precisa di Nahum Barnea, una delle
maggiori firme di Yediot Ahronot. A giudizio dell'ex presidente, del
resto, "consentire a Israele di distruggere fino alla fondamenta le
installazioni nucleari iraniane sarebbe il modo per prevenire un grande
conflitto in Medio Oriente".
|
| |
|
|
| |
|
torna su |
| |
L'Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane sviluppa mezzi di comunicazione che
incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche.
Gli
articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente
indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di
posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone
che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili.
Gli
utenti che fossero interessati a partecipare alla sperimentazione
offrendo un proprio contributo, possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it per concordare le modalità di intervento.
Il servizio Notizieflash è realizzato dall'Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane in collaborazione con la Comunità Ebraica di Trieste,
in redazione Daniela Gross.
Avete
ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei
l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere
ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo
e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio “cancella” o “modifica”. |
|
|