| se
non visualizzi correttamente questo messaggio, fai click qui
|
| |
| |
 |
|
L'Unione informa
|
|
| |
|
20 agosto 2010 - 10 Elul 5770 |
|
 |
|
|
|

|
| alef/tav |
|
|
 |
| |
 |
Roberto
Colombo,
rabbino |
Dopo
aver consegnato la Torah al popolo ebraico riunito accanto al
Sinai Dio comandò: Shuvu le-aholechèm, tornate nelle vostre
case. “Che in pubblico dimostriate rispetto e amore per la
Torah non è poi così strano. Ora voglio vedere se riuscite a farlo
anche nel segreto della vostra abitazione, quando non dovete dimostrare
nulla a nessuno. (Rabbì Tzadok haKohen) |
 |
“Il
numero tatuato sul braccio e i forni crematori erano i simboli di un
passato al quale guardavo con rispetto e timore. Simboli che nella mia
adolescenza non conoscevano la 'convinzione di sapere' così diffusa e
sostenuta dall’esposizione mediatica attuale. Simboli che trascinavano
con sé la paura di sapere ma al tempo stesso chiedevano di
definire meglio i contorni della parola persecuzione". Questa, insieme
alle risposte che abbiamo ricevuto, è forse la differenza sostanziale
tra te e me spiegava Fanny, un’ebrea quasi cinquantenne, a sua nipote
in una calda serata toscana.
|
Sonia
Brunetti Luzzati,
pedagogista |
 |
|
|
 |
|
|
torna su |
| davar |
|
|
| |
| |
Bill Millin (1922-2010) - Il piper della libertà
 Sei
giugno 1944, il “giorno più lungo”. Sulle spiagge della Normandia ha
inizio lo sbarco delle truppe alleate per aprire in Europa il fronte
occidentale. L'operazione che avrebbe segnato la fine delle dittature
che devastavano l'Europa. Le esplosioni di granate, i fischi dei
proiettili, le urla dei soldati: il rumore della guerra. In questo
frastuono infernale irrompeva il suono aspro e antico di una cornamusa.
Un piper di 21 anni imbracciava sicuro lo strumento, il kilt a scacchi
immerso nella gelida acqua marina. Mentre i suoi commilitoni si
lanciavano all’attacco dei tedeschi, Bill Millin, scomparso a 88 anni,
suonava a pieni polmoni Hieland Laddie sulla spiaggia di Sword.
Nonostante le bombe, i proiettili e i corpi dei compagni che cadevano,
Millin dava voce alla sua cornamusa. I soldati inglesi che faticavano
nell’avanzata, salutarono con gioia la musica tanto famigliare, quel
suono lontano di casa. “Non dimenticherò mai la melodia della cornamusa
di Bill - dirà molti anni dopo il veterano Tom Duncan – E’ difficile da
descrivere l’effetto che faceva. Ci tirava su il morale e aumentava la
nostra determinazione. Ne eravamo orgogliosi e ci ricordava la patria e
i motivi per i quali stavamo combattendo, per le nostre vite e per
quelle dei nostri cari”. Non tutti, durante quelle interminabili ore di
combattimento, apprezzarono la cornamusa di Millin; qualcuno si
avvicinò, intimandogli a denti stretti “stai giù maledetto pazzo”. Ma
Lord Lovat in persona, comandante dei commandos britannici e
discendente di una lunga dinastia di combattenti scozzesi, aveva voluto
la cornamusa di Millin al suo fianco. Decisione che violava l’ordine
del ministero della Guerra che vietò, dopo le terribili perdite della
Prima guerra mondiale, ai suonatori di cornamuse di partecipare alle
battaglie. “Quello è il ministro della Guerra inglese - disse Lord
Lovat a Millin per liquidare la questione - tu e io siamo scozzesi, per
noi non vale”. Sei
giugno 1944, il “giorno più lungo”. Sulle spiagge della Normandia ha
inizio lo sbarco delle truppe alleate per aprire in Europa il fronte
occidentale. L'operazione che avrebbe segnato la fine delle dittature
che devastavano l'Europa. Le esplosioni di granate, i fischi dei
proiettili, le urla dei soldati: il rumore della guerra. In questo
frastuono infernale irrompeva il suono aspro e antico di una cornamusa.
Un piper di 21 anni imbracciava sicuro lo strumento, il kilt a scacchi
immerso nella gelida acqua marina. Mentre i suoi commilitoni si
lanciavano all’attacco dei tedeschi, Bill Millin, scomparso a 88 anni,
suonava a pieni polmoni Hieland Laddie sulla spiaggia di Sword.
Nonostante le bombe, i proiettili e i corpi dei compagni che cadevano,
Millin dava voce alla sua cornamusa. I soldati inglesi che faticavano
nell’avanzata, salutarono con gioia la musica tanto famigliare, quel
suono lontano di casa. “Non dimenticherò mai la melodia della cornamusa
di Bill - dirà molti anni dopo il veterano Tom Duncan – E’ difficile da
descrivere l’effetto che faceva. Ci tirava su il morale e aumentava la
nostra determinazione. Ne eravamo orgogliosi e ci ricordava la patria e
i motivi per i quali stavamo combattendo, per le nostre vite e per
quelle dei nostri cari”. Non tutti, durante quelle interminabili ore di
combattimento, apprezzarono la cornamusa di Millin; qualcuno si
avvicinò, intimandogli a denti stretti “stai giù maledetto pazzo”. Ma
Lord Lovat in persona, comandante dei commandos britannici e
discendente di una lunga dinastia di combattenti scozzesi, aveva voluto
la cornamusa di Millin al suo fianco. Decisione che violava l’ordine
del ministero della Guerra che vietò, dopo le terribili perdite della
Prima guerra mondiale, ai suonatori di cornamuse di partecipare alle
battaglie. “Quello è il ministro della Guerra inglese - disse Lord
Lovat a Millin per liquidare la questione - tu e io siamo scozzesi, per
noi non vale”.
Le melodie di The Road to the Isles, tradizionale
canzone scozzese, accompagnarono l’attacco britannico alla cittadina di
Ouistreham. La cornamusa di Bill si interruppe quando un cecchino aprì
il fuoco sul suo battaglione. Tutti i soldati si appiattirono a terra.
Tutti tranne Lord Lovat, appoggiato su un ginocchio con la pistola in
mano. Di colpo da un albero scese un soldato tedesco, uno sparo e la
cornamusa tornò a farsi sentire. “Quando ci avvicinammo a Bénouville -
ricorderà in un’intervista Millin - un comandante mi chiese di suonare
lungo la strada principale però correndo. Risposi che avrei sì suonato
ma camminando, come sempre”. Così Millin intonò la famosa “Blue Bonnets
Over the Border” (Berretti blu oltre la frontiera, canzone che Millin
interpreterà anche nel famoso film sullo sbarco in Normandia, Il giorno
più lungo). Su ordine di Lovat, il suonatore di cornamusa continuò a
dare fiato al suo strumento anche sul celebre e strategico ponte
Pegasus. “Dall’altra parte del ponte” rammentava Mill “i nostri
commilitoni si sbracciavano perché eravamo sotto il facile mirino dei
cecchini. Ma noi continuammo ad avanzare. Quel ponte sembrava
infinito”. Migliaia di colpi ma Bill rimase indenne, la cornamusa ne
uscì malconcia ma il suo suonatore non aveva quasi un graffio. Lui
stesso non capì il motivo di tanta fortuna, essendo peraltro un
bersaglio facile. Così Bill chiese ad alcuni prigionieri tedeschi
perché nessuno gli avesse sparato e questi gli risposero che
semplicemente non avevano trovato il coraggio di sparare addosso a un
pazzo.
Nato a Glasgow nel 1922, Bill Millin, dopo lo sbarco in
Normandia, partecipò alla campagna militare britannica in Olanda.
Terminata la guerra, depose la cornamusa per lavorare in una delle
tenute di Lord Lovat. La vita monotona però non gli si addiceva e così
divenne membro di una compagnia teatrale, calcando le scene dei teatri
di Londra, Stockton-on-Tees e Belfast. Negli anni Cinquanta e fino al
suo ritiro nel 1988 lavorò in diversi ospedali scozzesi come infermiere.
Le
ultime note della sua cornamusa, Millin le dedicò all’amico e capo Lord
Lovat, suonando il lamento funebre al funerale dell’ex-comandante
britannico nel 1995. Oggi la cornamusa di Bill è custodita nel Museo
nazionale della Guerra di Edimburgo.
Il suo suono, che lacerò
per primo il fronte delle dittature e annunciò la riscossa della
libertà, non potè impedire ancora lunghi mesi di indicibili sofferenze
al fronte e nei campi di concentramento. Ma lasciò intendere a tutti
che la guerra a chi prevarica, perseguita e nega i diritti umani vale
sempre la pena di essere combattuta.
Daniel Reichel
Calcio - Esulta per il gol indossando la Kippah, ammonito
 Recita il sito
dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) che “ai giocatori è consentito
esprimere la propria gioia dopo la segnatura di una rete, ma tale
manifestazione non deve essere eccessiva. Le manifestazioni di gioia
non eccessive sono consentite, ma la pratica di celebrazioni
coreografiche non deve essere incoraggiata quando causa eccessiva
perdita di tempo (...).Un calciatore deve essere ammonito se (...)a
giudizio dell’arbitro, fa gesti che sono provocatori o derisori (…),
copre la propria testa o il proprio volto con una maschera o un altro
oggetto similare (…)”. Recita il sito
dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) che “ai giocatori è consentito
esprimere la propria gioia dopo la segnatura di una rete, ma tale
manifestazione non deve essere eccessiva. Le manifestazioni di gioia
non eccessive sono consentite, ma la pratica di celebrazioni
coreografiche non deve essere incoraggiata quando causa eccessiva
perdita di tempo (...).Un calciatore deve essere ammonito se (...)a
giudizio dell’arbitro, fa gesti che sono provocatori o derisori (…),
copre la propria testa o il proprio volto con una maschera o un altro
oggetto similare (…)”.
Insomma, nel leggere le note al regolamento pare proprio che indossare
una kippah (il copricapo ebraico anche detto "papalina"), evidentemente
per un momento di personale religiosità, che richiama altri gesti
assimilabili di diverse religioni, non sia certo da sanzionare.
Peraltro, sulle esultanze da dopo rete vi è una vasta, controversa e
contraddittoria casistica che lascia pensare che, anche nel calcio, c'è
chi può e chi non può...
Itay Shechter, giocatore dell'Hapoel Tel Aviv sanzionato appunto per
quello che un sito definisce ironicamente "yarmulke goal" ("rete della
papalina"), evidentemente non può: accantonate ipotesi di pregiudizio
visto che all'Hapoel è stato concesso un rigore. Viene da chiedersi
cosa abbia indotto l'arbitro a questa assurda e dannosa (per le
conseguenze) decisione. Forse una malintesa e perversa interpretazione
dell’invece assai sano concetto di laicità?! In questo caso sarà bene
che i calciatori comunque credenti stiano all’erta. Direi però che la
risposta migliore la fornisce sempre il sito dell'AIA che chiosa: “Ci
si aspetta che gli arbitri utilizzino il buon senso in occasione dei
festeggiamenti di una rete”.
Gadi Polacco, Consigliere
dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Guarda il
video dell'accaduto sul Portale dell'ebraismo italiano moked.it
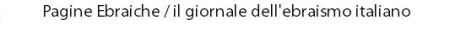

Qui Livorno - L’uomo che regalò
un mulino a Gerusalemme
 Ricchezza, fama, onore, un
matrimonio felice, una vita longeva, un cuore generoso. Moses
Montefiore ebbe tutto ciò che un uomo può desiderare. Nato a Livorno
nel 1784 da una famiglia sefardita, si trasferì molto giovane a Londra.
Nonostante conducesse un’esistenza internazionale, viaggiando
costantemente e mantenendo contatti di varia natura ai quattro angoli
del globo, rimase sempre molto legato alla città toscana e alla sua
Comunità ebraica. Vi fece spesso ritorno ed elargì cospicue donazioni.
Montefiore è ricordato come uno dei più grandi filantropi e
benefattori. Iniziata la carriera a Londra, non impiegò molto tempo a
mostrare le sue notevoli capacità. Si rivelò un uomo d’affari
coraggioso e innovativo: fu uno dei primi, per esempio, a investire
massicciamente nell’illuminazione a gas delle città europee, fondando
l’Imperial Gas Association. All’inizio dell’Ottocento una legge inglese
stabiliva a dodici il numero massimo di ebrei tra gli operatori della
borsa della City londinese, uno dei massimi centri della finanza
mondiale. Montefiore divenne uno di loro. Nel 1812 sposò Judith Cohen,
figlia di uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra. Divenuto cognato
di Nathan Mayer Rothschild e assistito dalla fortuna oltre che dalla
sua proverbiale abilità negli affari, mise in piedi un vero e proprio
impero finanziario, divenendo uno degli uomini più facoltosi del
secolo. Fondò e diresse grandi compagnie assicurative, intrattenne
rapporti commerciali con tutto il mondo, fu a capo della Banca
Provinciale d’Irlanda, delle compagnie imperiali di estrazione in
Brasile, Cile, Perù e della Compagnia coloniale della seta. Ottenne
riconoscimenti ovunque e fu insignito delle massime onorificenze
dell’impero britannico: Sceriffo di Londra, Cavaliere della Regina e
Baronetto. A quarant’anni decise di mollare tutto. Smise di lavorare e
si dedicò a opere sociali e filantropiche. Moses Montefiore non aveva
ricevuto un’educazione religiosa, ma dalla sua prima visita in Eretz
Israel nel 1827 - ci tornò almeno altre sei volte - divenne
strettamente osservante. Si fece costruire una piccola sinagoga in
stile italiano nel parco della sua tenuta a Ramsgate. Volle sempre al
suo fianco uno shochet, un macellaio personale che gli garantisse di
poter mangiare sempre carne kasher. Si racconta che, quando partecipava
ai banchetti, si portava dietro i piatti e il cibo, senza preoccuparsi
affatto di suscitare lo stupore dei nobiluomini inglesi. Ricoprì per
quasi quarant’anni la carica di presidente del Consiglio dei deputati
degli ebrei britannici, organo di rappresentanza nazionale delle
comunità ebraiche del Regno Unito, ma il suo impegno filantropico fu
diretto soprattutto verso gli ebrei in condizioni di miseria ed
emarginazione. Intraprese numerose missioni all’estero: con i suoi 191
centimetri d’altezza e la sfarzosa veste da diplomatico della regina,
incuteva soggezione - figura carismatica e autorevole. Consapevole di
ciò, chiedeva udienza alle massime autorità e intercedeva per le sorti
della comunità ebraica. Si recò dal sultano di Turchia, dallo zar
Nicola I, in Romania, in Marocco e al Vaticano. Ricchezza, fama, onore, un
matrimonio felice, una vita longeva, un cuore generoso. Moses
Montefiore ebbe tutto ciò che un uomo può desiderare. Nato a Livorno
nel 1784 da una famiglia sefardita, si trasferì molto giovane a Londra.
Nonostante conducesse un’esistenza internazionale, viaggiando
costantemente e mantenendo contatti di varia natura ai quattro angoli
del globo, rimase sempre molto legato alla città toscana e alla sua
Comunità ebraica. Vi fece spesso ritorno ed elargì cospicue donazioni.
Montefiore è ricordato come uno dei più grandi filantropi e
benefattori. Iniziata la carriera a Londra, non impiegò molto tempo a
mostrare le sue notevoli capacità. Si rivelò un uomo d’affari
coraggioso e innovativo: fu uno dei primi, per esempio, a investire
massicciamente nell’illuminazione a gas delle città europee, fondando
l’Imperial Gas Association. All’inizio dell’Ottocento una legge inglese
stabiliva a dodici il numero massimo di ebrei tra gli operatori della
borsa della City londinese, uno dei massimi centri della finanza
mondiale. Montefiore divenne uno di loro. Nel 1812 sposò Judith Cohen,
figlia di uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra. Divenuto cognato
di Nathan Mayer Rothschild e assistito dalla fortuna oltre che dalla
sua proverbiale abilità negli affari, mise in piedi un vero e proprio
impero finanziario, divenendo uno degli uomini più facoltosi del
secolo. Fondò e diresse grandi compagnie assicurative, intrattenne
rapporti commerciali con tutto il mondo, fu a capo della Banca
Provinciale d’Irlanda, delle compagnie imperiali di estrazione in
Brasile, Cile, Perù e della Compagnia coloniale della seta. Ottenne
riconoscimenti ovunque e fu insignito delle massime onorificenze
dell’impero britannico: Sceriffo di Londra, Cavaliere della Regina e
Baronetto. A quarant’anni decise di mollare tutto. Smise di lavorare e
si dedicò a opere sociali e filantropiche. Moses Montefiore non aveva
ricevuto un’educazione religiosa, ma dalla sua prima visita in Eretz
Israel nel 1827 - ci tornò almeno altre sei volte - divenne
strettamente osservante. Si fece costruire una piccola sinagoga in
stile italiano nel parco della sua tenuta a Ramsgate. Volle sempre al
suo fianco uno shochet, un macellaio personale che gli garantisse di
poter mangiare sempre carne kasher. Si racconta che, quando partecipava
ai banchetti, si portava dietro i piatti e il cibo, senza preoccuparsi
affatto di suscitare lo stupore dei nobiluomini inglesi. Ricoprì per
quasi quarant’anni la carica di presidente del Consiglio dei deputati
degli ebrei britannici, organo di rappresentanza nazionale delle
comunità ebraiche del Regno Unito, ma il suo impegno filantropico fu
diretto soprattutto verso gli ebrei in condizioni di miseria ed
emarginazione. Intraprese numerose missioni all’estero: con i suoi 191
centimetri d’altezza e la sfarzosa veste da diplomatico della regina,
incuteva soggezione - figura carismatica e autorevole. Consapevole di
ciò, chiedeva udienza alle massime autorità e intercedeva per le sorti
della comunità ebraica. Si recò dal sultano di Turchia, dallo zar
Nicola I, in Romania, in Marocco e al Vaticano.

Le opere più importanti le compì in Palestina. Innamorato di questa
terra, volle favorire lo sviluppo della comunità ebraica a Gerusalemme.
Acquistò un terreno poco fuori della cerchia delle mura della città
vecchia e vi fece costruire un mulino che, al centro del quartiere
Yemin Moshè, è uno dei simboli più amati della città.
Manuel
Disegni, Pagine Ebraiche, agosto 2010 |
|
| |
|
|
torna su |
| pilpul |
|
|
| |
| |
Come siamo giudicati
 La similitudine “scolastica”
che ho proposto la settimana scorsa (Kippur come un esame a settembre)
mi è venuta da una discussione sorta spontaneamente durante l’ultimo
incontro del bet midrash delle donne di Torino. Trattando di giustizia
e misericordia divina alcune di noi, insegnanti, hanno pensato
istintivamente agli allievi. (Spero non si tratti di delirio di
onnipotenza da parte nostra, ma semplicemente della necessità di
inquadrare il discorso in un ambito più quotidiano e familiare per
dargli maggiore concretezza). In particolare, io sostenevo che per un
allievo è frustrante l’eccessiva indulgenza, perché implica sfiducia,
come a dire “da te non pretendo di più perché tanto so che non ci
arrivi”. Invece è lusinghiero quando l’insegnante ci dice “so che puoi
fare di meglio”, anche se poi il giudizio è più severo, perché sentiamo
la fiducia nelle nostre potenzialità. La similitudine “scolastica”
che ho proposto la settimana scorsa (Kippur come un esame a settembre)
mi è venuta da una discussione sorta spontaneamente durante l’ultimo
incontro del bet midrash delle donne di Torino. Trattando di giustizia
e misericordia divina alcune di noi, insegnanti, hanno pensato
istintivamente agli allievi. (Spero non si tratti di delirio di
onnipotenza da parte nostra, ma semplicemente della necessità di
inquadrare il discorso in un ambito più quotidiano e familiare per
dargli maggiore concretezza). In particolare, io sostenevo che per un
allievo è frustrante l’eccessiva indulgenza, perché implica sfiducia,
come a dire “da te non pretendo di più perché tanto so che non ci
arrivi”. Invece è lusinghiero quando l’insegnante ci dice “so che puoi
fare di meglio”, anche se poi il giudizio è più severo, perché sentiamo
la fiducia nelle nostre potenzialità.
Lo stesso si può dire, secondo me, a proposito della concezione ebraica
della giustizia divina. Altre religioni sembrano in apparenza più
indulgenti verso l’uomo, ma questa facilità presuppone una grave
sfiducia: l’uomo è peccatore per natura e non può farci niente. Mi
sembra molto più ottimista, invece, l’idea che l’uomo, pur con tutti i
suoi difetti, sia comunque in grado di fare un po’ di più di quel che
fa, e quindi dovrebbe cercare di sforzarsi perché il suo sforzo non è
inutile. L’insoddisfazione per il nostro comportamento presuppone
fiducia nelle nostre possibilità di migliorare, che non è una cosa da
poco.
Anna
Segre, insegnante
Comix - Anna Frank a fumetti
 Sono molti anni che il fumetto
viene considerato un utile strumento per comunicare con i giovani,
spesso con un atteggiamento a priori, nel senso che “basta che sia un
fumetto”, ma in realtà bisogna sempre realizzare un prodotto di
qualità, con la cifra stilistica e sintattica in grado di essere
compresa correttamente dal lettore. Sono molti anni che il fumetto
viene considerato un utile strumento per comunicare con i giovani,
spesso con un atteggiamento a priori, nel senso che “basta che sia un
fumetto”, ma in realtà bisogna sempre realizzare un prodotto di
qualità, con la cifra stilistica e sintattica in grado di essere
compresa correttamente dal lettore.
Il museo dedicato ad Anna Frank prosegue nella produzione di fumetti al
fine di aiutare i giovani a comprendere e conoscere la Shoah. La nuova
produzione, dopo “A family secret” e “La stella di Esther”, è “Anne
Frank, the graphic biography”, realizzato dallo sceneggiatore Sid
Jacobson e il disegnatore Ernie Colòn, per 160 pagine.
Il fumetto è già uscito in Olanda l’8 luglio e presto sarà disponibile
in altri paesi, compreso l’Italia, grazie all’editore Rizzoli-Lizard.
Premessa l’encomiabile operazione di divulgazione di questo diario,
viva testimonianza di uno dei più brutti periodi della Storia europea,
è però doveroso sottolineare che l’editore italiano non è certamente
conosciuto dal pubblico dei giovani, pubblicando principalmente opere
per lettori over 40, come Corto Maltese di Hugo Pratt, in secondo luogo
lo stile franco-belga della linea chiara, potrebbe non essere efficace
presso un pubblico abituato a stili giapponesi o statunitensi.
In pratica c’è il serio pericolo che se non saranno le istituzioni a
diffonderlo presso le scuole, rischierà di rimanere un bel prodotto per
pochi già sensibilizzati.
Andrea
Grilli
|
|
| |
|
|
torna su |
| rassegna stampa |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
Di quale pasta sarà fatta la transizione irachena,
quando gli americani avranno concluso definitivamente il
«ridispiegamento» delle loro truppe e l’esercito locale dovrà
sostituirsi ad esse nella totalità delle funzioni di controllo del
territorio? I tempi stringono e la risposta non è così ovvia, anche
perché molto del futuro del paese dipende dagli equilibri che andranno
definendosi, nel corso del tempo a venire, tra le diverse fazioni in
campo. Non di meno, se l’Iraq conoscerà un periodo di relativa
prosperità economica allora il dividendo della crescita potrà
consolidare gli sforzi di mediazione. Altrimenti, è facile immaginare
che la conflittualità non solo abbia modo di persistere ma addirittura
di amplificarsi. La precarietà e la delicatezza della situazione sono
riassunte da Gianandrea Gaiani per il Sole 24 Ore di oggi. Ma già nella
giornata di ieri molti quotidiani riferivano puntigliosamente delle
operazioni in corso per il ritiro di quel che residua delle unità
combattenti a stelle e strisce. Al loro posto rimarrà un nutrito
contingente, circa cinquantamila uomini, destinato tuttavia a compiti
di “retroguardia”, ovvero di addestramento di un esercito, quello
iracheno, che peraltro da tempo lamenta l’incapacità di controllare il
terreno. Lorenzo Cremonesi, su il Corriere della Sera di giovedì 19
agosto, fa una ricostruzione dei fatti non solo di cronaca ma anche di
taglio storico, rimandando l’origine della decisione - per gli
americani oggi tanto più necessaria e inderogabile, dal momento che la
situazione in Afghanistan è estremamente complessa - agli accordi
intercorsi due anni fa tra l’allora presidente George Bush e il premier
iracheno Nouri al Maliki. Per tornare ai giornali di oggi ne offrono
invece il resoconto, con accenti diversi, tra gli altri, Barbara
Schiavulli per il Messaggero, Claudio Gatti per il Sole 24 Ore, un severo Giampiero
Gramaglia su il Fatto Quotidiano, dove si parla di
«bilancio fallimentare» tout court, Carlo Nicolato su Libero, per il quale ciò che sta
avvenendo è una sorta di “privatizzazione” di fatto della guerra (via
le truppe dell’esercito, sostituite dai contractors, gli operatori al
servizio delle compagnie private), Marino Collacciani per il Tempo ma anche Giuliana Sgrena su
il Manifesto come Matteo Bosco Bertolaso sulla
medesima testata. I giudizi sulla conclusione dei sette anni di impegno
americano sono frequentemente divergenti, ma molti si soffermano sui
tanti punti interrogativi che si accompagnano al ritiro, così come fa
Cristiano Tinazzi in un reportage per il Riformista. Sullo stesso giornale Luigi Spinola si chiede quanto sia
da considerarsi una «Mission Accomplished» l’insieme degli eventi ai
quali stiamo assistendo, ricostruendone in parte anche la storia, dal
2003 ad oggi. Non è un mistero per nessuno che le oltre 4.400 «body
bags», così come vengono chiamati i contenitori dei cadaveri dei
soldati americani, abbiano la loro potenza, di contro alla richiesta di
rimanere rivolta agli Usa dall’esercito iracheno, così come ancora fa
oggi il Capo di stato maggiore Babakir Zebari, intervistato da Tinazzi
sempre per il Riformista. Peraltro il quadro
delle alleanze in quella terra è ben lontano dall’essersi delineato
chiaramente. Non di meno, gli indirizzi politici delle forze presenti.
Sono queste, tra le altre, le considerazioni che emergono dalla lettura
dell’intervista di Lorenzo Biondi a Rosemary Hollis, su Europa di mercoledì 18 agosto. La
quale, nell’invitare ad una ragionale cautela sul giudizio da
formulare, evitando le facili ma fuorvianti semplificazioni, ci dice
anche che l’Iraq «è come il Libano degli anni Ottanta: tutte le fazioni
cercano un sostegno all’estero». Sunniti e sciiti non sono due entità
omogenee, non almeno nella misura in cui all’interno di ognuno dei due
grandi gruppi si sommano rivalità locali. Per meglio far pesare la
propria presenza non è quindi infrequente che i gruppi in campo si
avvalgano di un aiuto esterno, che sia quello iraniano, saudita o dei
medesimi Stati Uniti. Dopo di che pare plausibile l’affermazione per la
quale «dopo l’invasione americana dell’Iraq, non è rimasta nell’area
nessuna forza che sia in grado di imporre da sola il proprio volere
sulle altre». Il segno di questa incertezza geopolitica marcherà i mesi
a venire. Una risposta potrebbe derivare solo con l’ingresso di nuovi
partner o play-rulers, come ad esempio la Cina. Questione di tempo, in
tutta probabilità, se quest’ultima nazione dovesse superare gli Stati
Uniti sul piano economico in tempi relativamente stretti (c’è chi dice
entro il 2015, chi rinvia a cinque o dieci anni dopo). Lucio
Caracciolo, intervistato da Umberto De Giovannangeli su l’Unità del medesimo giorno, parla
di «impotenza americana», rilevando l’aumento di influenza di cui
l’Iran ha goduto in questi ultimi anni nonché l’inconsistenza della
strategia di Obama. (A patto che l’attuale presidente, che pure ha
ereditato una situazione indiscutibilmente difficile, abbia una qualche
idea di come muoversi sul piano strategico.) Sulla Stampa di oggi Vittorio Emanuele
Parsi rileva che «ciò che accomuna sempre di più i diversi attori è che
tutti sembrano in grado di impedire il successo altrui, ma nessuno
appare credibilmente nelle condizioni di far trionfare il proprio».
Sempre su Europa del 18 agosto Lorenzo
Trombetta registra uno dei maggiori mutamenti prodotti dall’intervento
americano del 2003, ossia il tramonto della mediazione baathista
(esercitata con la persuasione così come con il ricorso alla
coercizione, ossia tra clientele e canna dei fucili), e le analogie,
almeno per alcuni aspetti, con il Libano. In queste giorni, infatti, la
realtà irachena, che sta conoscendo gli effetti del mutamento di
equilibri ingenerato dal ritiro del contingente combattente americano,
viene spesso accostata a quella libanese. Entrambi i paesi sono
polveriere, sempre sul punto di esplodere; o forse, tralasciando le
facili suggestioni, sarebbe meglio dire che rischiano di implodere,
poiché due sono i fattori che incidono più pesantemente: i precari
equilibri confessionali ed etnici interni (che sono la proiezione del
sistema di organizzazione politica per affiliazione di gruppo, l’unico
effettivamente riconosciuto come efficace dalle comunità locali) e,
dall’altro, il continuo coinvolgimento interno causato dall’influenza
di attori stranieri. Il Libano, da questo punto di vista, ha purtroppo
maturato lo stigma di una consolidata e poco invidiabile proverbialità
in tal senso. Ma in realtà, per il fatto stesso che parliamo di
precarie entità statuali, nate in virtù del ridisegno strategico della
regione operato dalle potenze coloniali, a cavallo tra la fine
dell’Impero ottomano e la conclusione della Seconda guerra mondiale,
non deve sorprendere la fragilità delle loro costituzioni politiche. In
tal senso può allora essere letto un altro articolo di Trombetta,
sempre su Europa, questa volta però di
giovedì 19 agosto nel quale, dando un quadro della situazione
beirutina, l’autore riferisce dell’atteggiamento di Hezbollah nei
confronti del Tribunale speciale per il Libano dove, in un tentativo di
capovolgere la propria scomoda posizione di imputabile, il movimento
sciita cerca di addossare le colpe ad Israele. Tralasciando qualsiasi
considerazione di merito, rimane il fatto che il «Partito di Dio» da
quando è nato, nell’oramai lontano 1982, sta cercando di assurgere a
rappresentanza dei diseredati, praticando una linea politica che cerca
in tutti i modi di saldare gruppi etnico-culturali diversi, accomunati
però da una condizione di marginalità economica e sociale, che nel
Libano è particolarmente pronunciata, soprattutto tra i palestinesi,
esclusi per legge dall’accesso ai diritti politici e a buona parte di
quelli sociali. Volendo in ciò dare ragione a quanto Michele Giorgio
sul Manifesto e Annalena Di Giovanni
su Terra di giovedì 19 agosto
raccontano parlando dei medesimi nella scomoda posizione di chi da
sempre si è trovato «ospite indesiderato». A fronte di uno scenario di
penuria si contrappone, invece, la crescita dell’economia israeliana,
raccontata da Benjamin Barthe su le Monde di ieri. Elemento spesso
sottovalutato, soprattutto nel computo dei fattori del conflitto
israelo-palestinese (dove l’economia è considerata come aspetto
ancillare, mentre invece ha da sempre un ruolo primario), il «vantaggio
competitivo» di cui gode Israele si conferma soprattutto nel settore
della ricerca e dello sviluppo. Come lo stesso sito di informazioni
Globes conferma, la crescita del prodotti interno lordo, che dovrebbe
assestarsi per quest’anno intorno al 3.6 per cento (secondo le stime
della Banca d’Israele), si gioca sulle esportazioni di high-tech. Ad
essa si aggiunge la lievitazione del mercato immobiliare e degli
investimenti in beni e mezzi di produzione. Il rischio di un
surriscaldamento è tale da avere già indotto le autorità finanziarie ad
intervenire, alla fine di luglio, con un aumento del tasso d’interesse,
per evitare di trasformare l’incremento dei prezzi degli immobili in
una vera e propria bolla speculativa (laddove una parte d’essi sono
aumentati anche di un quinto in un solo anno). Rimane tuttavia il
fatto, irrisolto, della forte polarizzazione sociale nelle
distribuzione della ricchezza prodotta: un quinto della popolazione
israeliana, infatti, ha standard di vista estremamente modesti se non
decisamente poveri. Un aspetto che caratterizza un po’ tutte le grandi
economie nell’età della globalizzazione.
Claudio
Vercelli
|
|
| |
|
|
torna su |
| notizieflash
|
|
|
| |
| |
Europa League - Sconfitta
parigina per il Maccabi Tel Aviv
Non è sempre
domenica. Anzi, non è sempre mercoledì: il Maccabi Tel Aviv, impegnato
nell’andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League in casa del
PSG, non ripete l’exploit esterno che ventiquattro ore prima ha
consegnato le chiavi della qualificazione Champions ai cugini
dell’Hapoel (3 a 2 in casa del Salisburgo) e perde in modo netto (2 a
0) sul campo di una delle sorelle nobili del calcio francese. Dopo aver
fatto fuori l’Olimpiacos, gli israeliani sognavano il bis. Luyindula in
avvio e Hoarau al sessantesimo minuto li riportano sulla terra. Adesso
si fa dura: per rimediare al ko parigino servirà un’impresa. Anche se
Avi Nimni, general manager del Maccabi, butta il cuore oltre l’ostacolo
e tiene accesa la fiammella della speranza: “Ce la possiamo fare”.
PSG 2 – 0 MACCABI TEL AVIV
Luyindula (P), Hoarau (P)
|
| |
|
|
| |
|
torna su |
| |
L'Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane sviluppa mezzi di comunicazione che
incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche.
Gli
articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente
indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di
posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone
che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili.
Gli
utenti che fossero interessati a partecipare alla sperimentazione
offrendo un proprio contributo, possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it per
concordare le modalità di intervento.
Il servizio Notizieflash è realizzato dall'Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane in collaborazione con la Comunità Ebraica di Trieste,
in redazione Daniela Gross.
Avete
ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei
l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere
ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo
e-mail, scrivete a: desk@ucei.it
indicando nell'oggetto del messaggio “cancella” o “modifica”. |
|
|