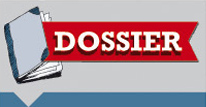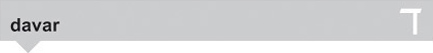Paolo Sciunnach, Paolo Sciunnach,
insegnante
|
Il
muro del pianto è il luogo di preghiera più importante per tutti gli
ebrei. Fede, cultura e storia si ritrovano tutte nel Muro Occidentale,
in quella mescolanza che rende la terra d’Israele così unica.
Visitatori di ogni tipo (religiosi e laici) avvertono, in questo luogo,
un legame speciale.
|
| |
Leggi
|
 Gadi Gadi
Luzzatto
Voghera,
storico
|
Sono
passati quarant’anni dalla guerra del Kippur. Il mondo è cambiato,
molto, ma le ferite rimangono aperte. In quello stesso Sinai dove oggi
l’esercito egiziano va a caccia delle bande di qaedisti e di islamisti
con la bonaria approvazione e collaborazione dell’Occidente e di
Israele, tanti anni fa si combatteva una guerra diversa, con la quale
forse è ancora presto per poter fare veramente i conti (in termini di
responsabilità, inadeguatezze, superficialità politica). Per me,
bambino, gli egiziani del tempo erano i nemici che forse avevano
catturato mio zio Marco, sorpreso con i suoi compagni nel fortino di
Firdan a difesa del Canale di Suez. Guardavo ossessivamente i
telegiornali in bianco e nero, le cronache di Marcello Alessandri che
trasmettevano le immagini delle schiere di soldati israeliani
prigionieri, nella speranza/certezza che avrei riconosciuto il volto di
quel mio caro, che avevo visitato solo pochi giorni prima nella sua
casa di Ramat Hasharon e che mi cantava con voce allegra “Garibaldi fu
ferito, fu ferito ad una gamba…”. Ma il suo volto non c’era, e il suo
corpo giaceva da tempo fra le dune del deserto. Marco ha combattuto a
ha perso la vita nonostante le sue ferme convinzioni di opposizione
alla guerra. Come ricordava l’amico Franco Sabatello in un suo breve
scritto su Ha-tikwah nel ‘74, “Marco aveva attivamente aderito al
gruppo della Lista della Pace (Reshimath Shalom), e (…) sottolineava
l’esigenza di approntare un piano di pace israeliano che tenesse in
conto il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi e respingeva la
politica dello status quo. (…) Se per tutti gli israeliani l’attacco
siro-egiziano del 6 ottobre giunse improvviso e inatteso, per Marco ed
i suoi compagni di pensiero esso fu forse solo imprevisto”. Due decenni
dopo la madre di Marco, mia nonna, scriveva queste parole di ricordo:
“C’è in casa una cassetta colma di lettere che negli oltre dieci anni
della tua assenza arrivavano regolarmente a portare tra noi il soffio
della tua vita con le notizie sempre attese con ansia. Dal Kippur del
1973 sono passati vent’anni, e ogni anno io apro quella cassetta e
tocco sempre alcuni di quei fogli ancora ben conservati e leggo
cercando di rivivere tanti avvenimenti famigliari, ma soprattutto di
riascoltare le parole di amore del mio Marco. Nel grande, fiorito,
ridente cimitero di Kiriath Shaul migliaia di giovani vite sono
diventate altrettante lapidi con un nome e un numero: sulla tua c’è il
31. Gli anni che il Signore ci ha concesso di vivere con te”.
|
| |
 |
Un anno per la libertà
|
Gli auguri del presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Renzo Gattegna in occasione dell'inizio del nuovo anno ebraico.
|
| |
Leggi
|
 |
Voci a confronto
|
“Vent’anni
fa era impensabile che qualcuno si dichiarasse deliberatamente
antisemita, oggi invece sembra normale”. Nelle parole di Betti Guetta
(Corriere della Sera Sette), ricercatrice del Centro di Documentazione
Ebraica di Milano, la preoccupazione per il rischio di derive
antisemite nel nostro paese, alla luce dei risultati di uno studio
qualitativo sull’immagine degli ebrei in Italia.
|
| |
Leggi
|
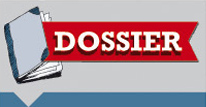 |
Risorse e bilanci
|
Un approfondimento sull’ultimo Bilancio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
|
| |
Leggi
|
|
|
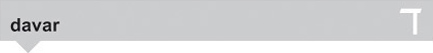
yom kippur
Né a destra, né a sinistra
 Uno
dei momenti più alti della poesia religiosa ebraica è rappresentato
dalle Selichot (poesie penitenziali) e dalle Selichot di Ne’ilah in
particolare. È il momento più saliente del Giorno di Kippur, quello che
ci dà la Kapparah (espiazione). Possiamo dire il momento della verità,
in cui emergono i messaggi definitivi che ci accompagneranno nel corso
dell’anno entrante. La seconda Selichah di Ne’ilah (nel rito italiano
seguito a Milano, Torino e Padova) è stata scritta da Moshe Ibn ‘Ezrà,
lo stesso autore del Piyut (inno) con cui l’ultima Tefillah di Kippur
esordisce: E-l norà ‘alilah. L’ultima strofa della Selichah Eloqim dàr
meromèkha (“Dio che abiti nei cieli”) è significativa: qui la
riportiamo nella pregevole versione rimata di Massimo Foa. “Chiudon del
cielo le porte ed il sol tramonta già: / annunzia la nostra sorte, o
Dio, con la Tua bontà. / Dovete, o porte, alzare le Vostre cime sante /
al fin che possa entrare il popol mio trionfante. / Acque purificanti
sul popol prediletto / per riscattare quanti loro Dio ti hanno eletto.
/ Questa è la strada da fare. Guidaci e sta’ a noi vicino” (Le Selichot
in rima, Morashà 2008, p. 73). Il monito: “questa è la strada da fare”
è tratto, come molte espressioni delle Selichot, da versetti del Tanakh
avulsi dal loro contesto. In questo caso si tratta di Yesha’yahu
30,20-21. Il profeta preannuncia il regno fedele di Chizqiyahu con le
parole: “I tuoi occhi guarderanno in viso i tuoi Maestri... Questa è la
strada da fare, che vogliate andare a destra o a sinistra”. L’ultima
parte contiene certamente allusioni politiche, ma non nel senso moderno
dei termini. La sinistra era in antico il nord e allude alla potenza
assira che in quegli anni, complice un giro di alleanze, dava filo da
torcere ai re di Eretz Israel. La destra, d’altronde, era il sud e
allude alla potenza egiziana, cui essi si erano rivolti per aiuto. Il
profeta Yesha’yahu ammonisce dunque il regime a trascurare vane
alleanze politico-militari e a guardare soltanto davanti a sé.
Rav Alberto Moshe Somekh Uno
dei momenti più alti della poesia religiosa ebraica è rappresentato
dalle Selichot (poesie penitenziali) e dalle Selichot di Ne’ilah in
particolare. È il momento più saliente del Giorno di Kippur, quello che
ci dà la Kapparah (espiazione). Possiamo dire il momento della verità,
in cui emergono i messaggi definitivi che ci accompagneranno nel corso
dell’anno entrante. La seconda Selichah di Ne’ilah (nel rito italiano
seguito a Milano, Torino e Padova) è stata scritta da Moshe Ibn ‘Ezrà,
lo stesso autore del Piyut (inno) con cui l’ultima Tefillah di Kippur
esordisce: E-l norà ‘alilah. L’ultima strofa della Selichah Eloqim dàr
meromèkha (“Dio che abiti nei cieli”) è significativa: qui la
riportiamo nella pregevole versione rimata di Massimo Foa. “Chiudon del
cielo le porte ed il sol tramonta già: / annunzia la nostra sorte, o
Dio, con la Tua bontà. / Dovete, o porte, alzare le Vostre cime sante /
al fin che possa entrare il popol mio trionfante. / Acque purificanti
sul popol prediletto / per riscattare quanti loro Dio ti hanno eletto.
/ Questa è la strada da fare. Guidaci e sta’ a noi vicino” (Le Selichot
in rima, Morashà 2008, p. 73). Il monito: “questa è la strada da fare”
è tratto, come molte espressioni delle Selichot, da versetti del Tanakh
avulsi dal loro contesto. In questo caso si tratta di Yesha’yahu
30,20-21. Il profeta preannuncia il regno fedele di Chizqiyahu con le
parole: “I tuoi occhi guarderanno in viso i tuoi Maestri... Questa è la
strada da fare, che vogliate andare a destra o a sinistra”. L’ultima
parte contiene certamente allusioni politiche, ma non nel senso moderno
dei termini. La sinistra era in antico il nord e allude alla potenza
assira che in quegli anni, complice un giro di alleanze, dava filo da
torcere ai re di Eretz Israel. La destra, d’altronde, era il sud e
allude alla potenza egiziana, cui essi si erano rivolti per aiuto. Il
profeta Yesha’yahu ammonisce dunque il regime a trascurare vane
alleanze politico-militari e a guardare soltanto davanti a sé.
Rav Alberto Moshe Somekh
Leggi
|

La teshuvà di un leader
 Ogni
anno a Kippur leggiamo il libro di Giona e ogni volta può capitare,
anche grazie ai commenti, di scoprire qualcosa di interessante che
finora ci era sfuggito. Per esempio, è curioso notare che quando il
profeta Giona arriva ad annunciare che la città di Ninive sarà
distrutta (ma la parola può anche significare “rovesciata” e prevedere
quindi correttamente il radicale capovolgimento nei comportamenti che
di lì a poco si verificherà), il movimento di presa di coscienza e di
ravvedimento parte dal basso, dal popolo in tutte le sue classi
sociali, e raggiunge il re solo in un secondo tempo (“E gli abitanti di
Ninive ebbero fede nel Signore e proclamarono il digiuno e si vestirono
di sacchi dal più grande al più piccolo. E giunse la notizia al re di
Ninive…”). Senza una presa di coscienza delle proprie responsabilità da
parte dell’intera popolazione è difficile che si possa sperare in una
leadership onesta. Il re di Ninive, che si decide alla teshuvà solo
quando gli viene riferito cosa stava facendo il suo popolo, era
certamente un personaggio ben poco raccomandabile (è stato identificato
con vari re malvagi e addirittura con lo stesso Faraone dell’uscita
dall’Egitto), e anche l’ordine di pentirsi e digiunare (cosa che
peraltro i sudditi stavano già facendo) suona un po’ ambiguo, sembra
più un capriccio personale che una vera assunzione di responsabilità
(con un curioso gioco di parole che suona più o meno: “è gusto del re
che uomini e animali non gustino nulla”). Però di una cosa gli va dato
atto: non solo è subito pronto a condividere la medesima penitenza del
suo popolo vestendosi di sacco e sedendo sulla cenere come tutti gli
altri cittadini di Ninive, ma, soprattutto, le sue prime azioni sono
alzarsi dal trono e togliersi il mantello regale: gesti che indicano
simbolicamente la disponibilità a mettere in discussione la sua stessa
carica. Per sottolineare questa simbolica rinuncia al potere qualcuno
traduce “discese dal trono”, ma forse l’originale ebraico “si alzò”
focalizza la nostra attenzione non tanto sull’umiliazione personale
quanto sul seggio che è stato lasciato libero. E se la sua leadership
era stata una discesa, il suo gesto è l’inizio di una risalita, per lui
e per il suo popolo. Ogni
anno a Kippur leggiamo il libro di Giona e ogni volta può capitare,
anche grazie ai commenti, di scoprire qualcosa di interessante che
finora ci era sfuggito. Per esempio, è curioso notare che quando il
profeta Giona arriva ad annunciare che la città di Ninive sarà
distrutta (ma la parola può anche significare “rovesciata” e prevedere
quindi correttamente il radicale capovolgimento nei comportamenti che
di lì a poco si verificherà), il movimento di presa di coscienza e di
ravvedimento parte dal basso, dal popolo in tutte le sue classi
sociali, e raggiunge il re solo in un secondo tempo (“E gli abitanti di
Ninive ebbero fede nel Signore e proclamarono il digiuno e si vestirono
di sacchi dal più grande al più piccolo. E giunse la notizia al re di
Ninive…”). Senza una presa di coscienza delle proprie responsabilità da
parte dell’intera popolazione è difficile che si possa sperare in una
leadership onesta. Il re di Ninive, che si decide alla teshuvà solo
quando gli viene riferito cosa stava facendo il suo popolo, era
certamente un personaggio ben poco raccomandabile (è stato identificato
con vari re malvagi e addirittura con lo stesso Faraone dell’uscita
dall’Egitto), e anche l’ordine di pentirsi e digiunare (cosa che
peraltro i sudditi stavano già facendo) suona un po’ ambiguo, sembra
più un capriccio personale che una vera assunzione di responsabilità
(con un curioso gioco di parole che suona più o meno: “è gusto del re
che uomini e animali non gustino nulla”). Però di una cosa gli va dato
atto: non solo è subito pronto a condividere la medesima penitenza del
suo popolo vestendosi di sacco e sedendo sulla cenere come tutti gli
altri cittadini di Ninive, ma, soprattutto, le sue prime azioni sono
alzarsi dal trono e togliersi il mantello regale: gesti che indicano
simbolicamente la disponibilità a mettere in discussione la sua stessa
carica. Per sottolineare questa simbolica rinuncia al potere qualcuno
traduce “discese dal trono”, ma forse l’originale ebraico “si alzò”
focalizza la nostra attenzione non tanto sull’umiliazione personale
quanto sul seggio che è stato lasciato libero. E se la sua leadership
era stata una discesa, il suo gesto è l’inizio di una risalita, per lui
e per il suo popolo.
Chatimà tovà a tutti
Anna Segre, insegnante
Leggi
Felicità
 Uno
dei traguardi psicologici più difficili dell’esistenza umana è
accettare la priorità della serenità sulla “felicità”. Quando
s’invecchia pare sempre più chiaro in cosa consista la differenza e
quanto vantaggioso sia comprenderlo, ma spiegarlo resta comunque
difficile. C’è una frase di Liana Millu che, pur in parole semplici, mi
pare una buona sintesi: “Perché esiste una sola serenità mentre vi
possono essere numerose felicità. E anche infelici felicità. Perché la
serenità è qualità propria delle cose e dello spirito, cioè dipendente
direttamente da noi, mentre la felicità è in dipendenza quasi sempre
dagli altri (da Tagebuch)". Uno
dei traguardi psicologici più difficili dell’esistenza umana è
accettare la priorità della serenità sulla “felicità”. Quando
s’invecchia pare sempre più chiaro in cosa consista la differenza e
quanto vantaggioso sia comprenderlo, ma spiegarlo resta comunque
difficile. C’è una frase di Liana Millu che, pur in parole semplici, mi
pare una buona sintesi: “Perché esiste una sola serenità mentre vi
possono essere numerose felicità. E anche infelici felicità. Perché la
serenità è qualità propria delle cose e dello spirito, cioè dipendente
direttamente da noi, mentre la felicità è in dipendenza quasi sempre
dagli altri (da Tagebuch)".
Laura Salmon, slavista
Leggi
|
|





 Paolo Sciunnach,
Paolo Sciunnach,  Gadi
Gadi