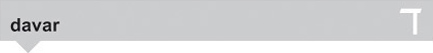Roberto Roberto
Della Rocca,
rabbino
|
“Queste parole disse l’Eterno…con voce potente e non continuò più a parlare…” (Devarìm, 5; 19).
In ragione dell’impossibilità del popolo di ascoltare la voce divina e
in anticipazione della storia futura in cui la Parola divina sarà solo
letta e non sentita ” …l’Eterno scrisse (ciò che aveva detto) su due
tavole di pietra…”.
|
| |
Leggi
|
 Dario Dario
Calimani,
Università di Venezia
|
È
curioso come talora la nostra ragione accecata si lasci guidare
dall’ideologia. Ora abbiamo paura del burkini. Forse è il caso di
guardarsi dal burka, non dal burkini. È il volto che si deve avere il
coraggio di non nascondere, non il resto del corpo. Quella di
nascondere il resto del corpo è una scelta su cui si può discutere, ma
è una scelta lecita e incontestabile – se è libera scelta. Lo mostrano
le suore, lo mostrano le donne ebree ortodosse che si coprono il capo e
le braccia e non vanno certo in minigonna. È un diritto che può anche
non piacere, ma è un diritto, e non mette a rischio la sicurezza dello
stato. Ciò di cui forse la nostra società ha paura è invece il doversi
confrontare con il crescendo apparentemente inarrestabile della
diversità nelle nostre contrade. Conviene allora concentrarsi su questo
punto, piuttosto che deviare l’attenzione con arzigogoli del pensiero
logico.
Fa certo impressione imbattersi in una quantità inusitata di donne
velate, talora plurime e al seguito di un solo uomo. Ci si dovrà
abituare. E dovremo, invece, non tanto proibire la diversità, ma
interrogarci su quali siano i modi migliori per non rinunciare alla
nostra stessa diversa identità, e per confermarla e rafforzarla, se
possibile. Se ne saremo capaci, e se sapremo fare le scelte giuste.
|
| |
Leggi
|
|
|
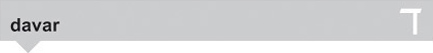
IL RITORNO DI SAFRAN FOER - pagine ebraiche
Eccomi, ogni cosa è sfrontata
  Grande
spazio oggi, sui principali quotidiani italiani, per il ritorno nelle
librerie di Jonathan Safran Foer. Grande l'attesa per Eccomi,
il suo nuovo lavoro pubblicato da Guanda che sarà in libreria il
prossimo lunedì 29 agosto e di cui Pagine Ebraiche di questo mese ha
già anticipato i temi e i principali spunti di riflessione. Grande
spazio oggi, sui principali quotidiani italiani, per il ritorno nelle
librerie di Jonathan Safran Foer. Grande l'attesa per Eccomi,
il suo nuovo lavoro pubblicato da Guanda che sarà in libreria il
prossimo lunedì 29 agosto e di cui Pagine Ebraiche di questo mese ha
già anticipato i temi e i principali spunti di riflessione.
Il
nostro orizzonte è lontano, talvolta incerto. Eppure è anche
terribilmente vicino, lo possiamo raggiungere con le mani. E a volte ci
opprime. Perché l’orizzonte ebraico non è mai la prospettiva
dell’isolamento volontario, ma prende il nome della prima aggregazione
sociale, la famiglia. E ci parla di famiglia, ancora di famiglia, forse
sempre di quella a lui vicina, forse di quella di tutti noi, forse
della grande famiglia allargata in cui sono immersi insieme i destini
di tutti coloro che con l’identità ebraica coltivano un legame, il
nuovo grande romanzo di Jonathan Safran Foer che attende il lettore
italiano al rientro dalle vacanze.
Tutto lascia pensare che quando entrerà nelle librerie italiane il
prossimo 29 agosto, gli italiani reduci dall’ultimo fine settimana del
grande esodo dalle città e ancora desiderosi di quel ristoro che solo
la letteratura è capace di donare si troveranno a un avvenimento.
Jonathan Safran Foer, il giovanissimo enfant prodige che aveva fatto
sognare la generazione di un mondo intero con il suo memorabile Ogni
cosa è illuminata, poi ancora con la felice riduzione cinematografica
della sua stessa opera prima, poi ancora per il suo impegno civile e
sociale nel raccontare i dilemmi del mondo occidentale di fronte al
terrorismo e allo sfacelo ambientale dell’alimentazione massificata e
alla crudeltà dei mattatoi, ha atteso dieci lunghi anni di silenzio
prima di riprendere la parola. Un divario temporale enorme, per un
giovane, geniale scrittore. Proprio il tempo per domandarsi se alle
prime straordinarie opere uscite di getto dalla prima età consapevole
sarebbe seguito qualcosa di proporzionato, oppure, come talvolta
avviene, se il genio di una volta non si sarebbe stemperato, dissolto
nella banalità della riproduzione di se stessi e delle proprie maniere
narrative, ridotto al solo desiderio frustrato di mantenersi
all’altezza della propria fama. Con il suo Eccomi, che l’editore Guanda
ha il privilegio di mandare in libreria, nella sensibile versione
italiana di Irene Abigail Piccinini, prima ancora della grande
passerella nelle librerie anglosassoni e sui mercati di tutto il mondo,
Safran Foer riesce nel piccolo miracolo di non raccontarci niente di
nuovo e di sovvertire, di risvegliare in un diverso formato, di donare
una dimensione ulteriore a tutto quello che già sapevamo.
C’è l’idea di essere ebrei. Lo stesso titolo non è altro che una
citazione biblica e rende in una sola parola di tre sillabe tutto il
dramma della risposta di Abramo chiamato dal Cielo e sconvolto nel suo
ruolo di padre, lacerato, infine travolto e abbandonato nell’assumersi
una responsabilità in ogni caso più grande di lui: quella del figlio,
di Isacco che per primo dona al primo ebreo il primo significato di una
discendenza ebraica.
C’è la famiglia, nelle vicende di famiglie a noi terribilmente vicine,
divise fra un Israele perpetuamente minacciato dalla guerra e dalle
catastrofi (nel romanzo l’ambientazione fantastica si spinge a
prefigurare guai molto grandi in Medio Oriente) e una quotidianità nel
mondo occidentale perpetuamente minacciata dall’inconsapevolezza e
dalla superficialità.
C’è il passaggio obbligato, inevitabile, necessario e al tempo stesso
insopportabile attraverso i legami della famiglia e del clan.
C’è il sesso, la morte, la passione, il disgusto, l’esasperazione, il
riso, la speranza. E più di tutto c’è quello che forse ci aiuta a
sopravvivere, ad assumerci con una certa leggerezza responsabilità
schiaccianti, ad accettare il nostro destino: quel senso dello spirito,
quella capacità di vedere i fatti e le situazioni dall’esterno e al
tempo stesso dall’interno, di ironizzare, di ridere, che secondo resta
la pietra angolare del senso dello spirito, della capacità di ridere
anche delle tragedie, di tollerare le infinite differenze, le
situazioni e le persone che non ci è dato comprendere con l’intelletto.
Forse è proprio il nostro senso dello spirito quello che ci fa
sopportare la nostra sofferenze e che ci fa sopportare la nostra
capacità di far soffrire, consapevolmente o inconsapevolmente, gli
altri. Non è necessario svelare molto di più di un romanzo poderoso
(oltre 660 pagine, che i curatori italiani hanno dotato di un opportuno
e ricco glossario delle terminologie ebraiche e yiddish trascinate nel
fiume del racconto). Basti dire che ci attende un libro comunque
importante, sul quale sarà necessario tornare ancora più volte e a più
voci, e anche controverso. Forse il libro di una nuova generazione che
attendeva l’arrivo del proprio turno per prendere il posto di quella
classe di lettori inevitabilmente segnata dal Lamento di Portnoy di
Philip Roth. Proprio di Roth, Safran Foer ricorda a suo modo e senza
mai piegarsi agli stereotipi di un identitarismo ebraico americano
manierato, non solo la vivacità, l’oscuro lato di sofferenza che si
nasconde dietro un senso dell’umorismo incontenibile, ma anche e
soprattutto la sfrontatezza, l’impudicizia di dire al lettore: adesso
parliamo di noi e di quello che è vero per noi. E ridiamoci sopra per
poter andare avanti. Proprio come Roth, Safran Foer pretende a suo modo
di chiamare ogni cosa con il proprio nome senza spiegare nulla. Perché
l’identità e la memoria, in definitiva, così come la letteratura, sono
solo un sistema per rimettere le idee in ordine.
Guido Vitale, Pagine Ebraiche agosto 2016
Leggi
|
il ritorno di safran foer - pagine ebraiche
Ogni cosa è ancora illuminata
 Piccoli
occhiali tondi sul naso, una ricca collezione di camicie a quadri e
quadretti, sguardo meditabondo, battaglie ecologiste, una discreta
spocchia. Jonathan Safran Foer, giovane e schiva star della letteratura
contemporanea, incarna in modo ineccepibile l’esempio massimo di
hipster newyorkese – pardon, di Brooklyn. Autore nel 2002 del best
seller Ogni cosa è illuminata all’età di soli 25 anni, seguito tre anni
dopo dall’altrettanto acclamato Molto forte, incredibilmente vicino, e
poi per 11 anni più di nessun romanzo ma solo di Se niente importa, un
saggio sulla realtà degli allevamenti americani che ha fatto diventare
vegetariano mezzo mondo, e qualche altra stravagante opera, sulla sua
carriera le idee dei critici e del pubblico sono generalmente molto
chiare, molto in positivo o molto in negativo. Qualcuno vede in lui una
figura geniale, faro di una nuova generazione di giovani letterati che
si affranca dagli standard del secolo scorso e trova nuovi strumenti
espressivi innovativi e post-moderni. Qualcuno invece pensa che al
contrario sia un abbaglio, uno che si crede il nuovo Philip Roth senza
essere Philip Roth, nettamente sopravvalutato. Quanto alla sua persona,
quello che invece in pochi apparentemente si sono chiesti è se questa
sua figura di quasi quarantenne dalla vita in modo tanto perfettamente
e ostentatamente radical chic da sembrare quasi irreale sia autentica o
un personaggio raffinatamente costruito. Piccoli
occhiali tondi sul naso, una ricca collezione di camicie a quadri e
quadretti, sguardo meditabondo, battaglie ecologiste, una discreta
spocchia. Jonathan Safran Foer, giovane e schiva star della letteratura
contemporanea, incarna in modo ineccepibile l’esempio massimo di
hipster newyorkese – pardon, di Brooklyn. Autore nel 2002 del best
seller Ogni cosa è illuminata all’età di soli 25 anni, seguito tre anni
dopo dall’altrettanto acclamato Molto forte, incredibilmente vicino, e
poi per 11 anni più di nessun romanzo ma solo di Se niente importa, un
saggio sulla realtà degli allevamenti americani che ha fatto diventare
vegetariano mezzo mondo, e qualche altra stravagante opera, sulla sua
carriera le idee dei critici e del pubblico sono generalmente molto
chiare, molto in positivo o molto in negativo. Qualcuno vede in lui una
figura geniale, faro di una nuova generazione di giovani letterati che
si affranca dagli standard del secolo scorso e trova nuovi strumenti
espressivi innovativi e post-moderni. Qualcuno invece pensa che al
contrario sia un abbaglio, uno che si crede il nuovo Philip Roth senza
essere Philip Roth, nettamente sopravvalutato. Quanto alla sua persona,
quello che invece in pochi apparentemente si sono chiesti è se questa
sua figura di quasi quarantenne dalla vita in modo tanto perfettamente
e ostentatamente radical chic da sembrare quasi irreale sia autentica o
un personaggio raffinatamente costruito.
Francesca Matalon, Pagine Ebraiche agosto 2016
Leggi
|
L'OMAGGIO DI ISRAELE A UN GRANDE FIORENTINO
Renato Fantoni tra i Giusti
  Intellettuale,
partigiano, esponente di spicco del partito liberale che rappresentò
nella prima giunta comunale nella Firenze del dopoguerra. E, da qualche
ora, anche eroe del popolo ebraico e dello Stato di Israele con il
titolo di “Giusto tra le nazioni”. Lieto fine per la pratica avviata
nel dicembre 2014 allo Yad Vashem per rendere omaggio a una figura un
po’ dimenticata della politica toscana e nazionale: Renato Fantoni
(1894-1954). Una vicenda in cui significativo è stato il ruolo del
giornale dell’ebraismo italiano Pagine Ebraiche nel recuperare e
ricomporre i diversi tasselli, oggi messo in evidenza sulle pagine
fiorentine del Corriere. Intellettuale,
partigiano, esponente di spicco del partito liberale che rappresentò
nella prima giunta comunale nella Firenze del dopoguerra. E, da qualche
ora, anche eroe del popolo ebraico e dello Stato di Israele con il
titolo di “Giusto tra le nazioni”. Lieto fine per la pratica avviata
nel dicembre 2014 allo Yad Vashem per rendere omaggio a una figura un
po’ dimenticata della politica toscana e nazionale: Renato Fantoni
(1894-1954). Una vicenda in cui significativo è stato il ruolo del
giornale dell’ebraismo italiano Pagine Ebraiche nel recuperare e
ricomporre i diversi tasselli, oggi messo in evidenza sulle pagine
fiorentine del Corriere.
Noto
fino a due anni fa era l’impegno di Fantoni, cui è intitolata la via
della stazione ferroviaria di Rifredi, nella Resistenza e nella
costruzione di una nuova coscienza democratica dopo l’incubo
nazifascista, sconosciuta invece l’azione di salvataggio intrapresa, in
piena occupazione tedesca, nei confronti di un illustre collega di
partito che disperatamente cercava di sfuggire agli aguzzini: l’ebreo
Eugenio Artom, che Fantoni nascose per alcuni giorni a Pian del Mugnone
insieme alla moglie, Giuliana Treves, e al maggiordomo Amedeo.
(Nelle immagini le prime ricostruzioni inedite apparse sul nostro mensile nel 2014, un primo piano di Renato Fantoni)
Leggi
|
dafdaf agosto 2016
Coro, rivoluzione a Venezia
 Continua
a Venezia la ricchissima programmazione di incontri, convegni e mostre,
occasione di studio e approfondimento per ricordare il cinquecentenario
dall’istituzione del ghetto e sullo stesso tema il giornale ebraico dei
bambini DafDaf propone – nel numero di agosto – una riflessione in
chiave musicale. Maria Teresa Milano, ebraista e musicologa, nella sua
rubrica mensile “musica, Maestra!” presenta ai giovani lettori la
figura di Leone Modena, “vero portento della musica”. Continua
a Venezia la ricchissima programmazione di incontri, convegni e mostre,
occasione di studio e approfondimento per ricordare il cinquecentenario
dall’istituzione del ghetto e sullo stesso tema il giornale ebraico dei
bambini DafDaf propone – nel numero di agosto – una riflessione in
chiave musicale. Maria Teresa Milano, ebraista e musicologa, nella sua
rubrica mensile “musica, Maestra!” presenta ai giovani lettori la
figura di Leone Modena, “vero portento della musica”.
"Egregi
rabbini, siamo qui riuniti per discutere una questione della massima
importanza. Sono giunte lamentele in merito all’istituzione di un coro
nella sinagoga di Ferrara a opera dell’illustre rabbino Yehuda Arieh
Leon Modena e spetta a codesta assemblea rabbinica di Venezia decidere
se tale coro continuerà a vivere o se dovrà essere sciolto”.
Quello sì che fu un giorno difficile, segnato da discussioni animate e
io, Leone Modena, nato nel ghetto di Venezia il 23 aprile 1571, un
bambino prodigio che aveva trascorso anni e anni chino sui libri in
compagnia dei più grandi maestri, un uomo di fede che aveva dedicato
una parte importante della propria vita a scrivere saggi, trattati e
testi profani, io Leone Modena, un vero portento della musica, con una
bella voce da tenore e capacità nella danza… proprio io, me ne stavo lì
con timore reverenziale ad attendere il verdetto dell’Assemblea
Rabbinica.
Ma quanto clamore per un coro! E sì che per molti secoli la musica
ebraica era stata monodica, ovvero a una sola voce, ma io ero convinto
che i tempi fossero ormai maturi per nuove espressioni e così nel 1605
avevo fondato un coro che cantava a sei e a otto voci. A parer mio se
un individuo possiede una bella voce ha il diritto di esercitarla nel
miglior modo possibile per la gloria di Dio. E poi ero affascinato
dalla musica rinascimentale, dalla magia della polifonia e non ero
certo l’unico. A Praga proprio in quegli anni la bella sinagoga Maisel
si era dotata di un organo e di una piccola orchestra che ogni venerdì
sera accoglieva l’arrivo dello shabbat e ogni comunità nella bella
città ceca aveva il proprio coro, con cui spesso si esibivano anche
cantanti professionisti.
Io vivevo nel ghetto di Venezia, un recinto chiuso in cui l’arte e la
musica riuscivano a dare vita a infiniti spazi di creatività; c’erano
un teatro di cui io stesso incoraggiai l’apertura e, cosa per me più
importante, nel 1628, nacque l’Accademia di musica, in cui si cantava
due volte alla settimana, la sera. Io ero quel che all’epoca veniva
definito Maestro di Cappella. Purtroppo la peste due anni dopo si portò
via molti membri dell’Accademia e come potete immaginare il mio bel
progetto subì un duro colpo. I primi anni del 1600 furono davvero anni
d’oro per gli ebrei musicisti: Abramo dell’Arpa e il nipote Abramino
erano strumentisti talentuosi, mentre Issachino Massarano suonava il
liuto, cantava da soprano e insegnava musica e danza. E poi c’era lui,
il grande Salomone Rossi, musicista di corte che aveva già composto
canzonette e madrigali e nel 1623 pubblicò a Venezia la sua raccolta di
trentatre brani per solisti e coro, comprendenti salmi, inni e
preghiere per le feste con il titolo di Hashirim Asher Lishlomo, i
canti di Salomone.
Insomma, la rivoluzione della musica sinagogale italiana era cominciata
e avrebbe poco alla volta toccato molte altre comunità ebraiche in
tutta Europa, che amavano molto questo modo di cantare “all’italiana”.
In ogni città si diffuse la febbre corale e devo dire con orgoglio, che
fummo proprio noi, Salomone e io, ebrei del ghetto, ad accendere questa
scintilla.
Maria Teresa Milano, DafDaf 71, agosto
Leggi
|

Noi, Ventotene e l'identità
|
 Fino
a che punto, e in che modo, è giusto associare l’origine di una persona
con la sua eredità intellettuale? Se io nasco ebreo, e magari vengo
sommariamente educato secondo i principi della tradizione, penserò
effettivamente da ebreo? Ci ho riflettuto nei giorni che hanno messo
Ventotene al centro della scena: Eugenio Colorni, sua moglie Ursula
Hirschman, e poi gli altri detenuti ebrei sull’isola di Santo Stefano,
tra i quali Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente.
Oppure i fratelli Carlo e Nello Rosselli, emigrati e poi trucidati in
Francia. Nel sogno federalista di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e
dello stesso Colorni, possiamo rintracciare una matrice culturale anche
ebraica oppure questa genesi deve prima essere certificata dalla
lettera del Manifesto? Fino
a che punto, e in che modo, è giusto associare l’origine di una persona
con la sua eredità intellettuale? Se io nasco ebreo, e magari vengo
sommariamente educato secondo i principi della tradizione, penserò
effettivamente da ebreo? Ci ho riflettuto nei giorni che hanno messo
Ventotene al centro della scena: Eugenio Colorni, sua moglie Ursula
Hirschman, e poi gli altri detenuti ebrei sull’isola di Santo Stefano,
tra i quali Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente.
Oppure i fratelli Carlo e Nello Rosselli, emigrati e poi trucidati in
Francia. Nel sogno federalista di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e
dello stesso Colorni, possiamo rintracciare una matrice culturale anche
ebraica oppure questa genesi deve prima essere certificata dalla
lettera del Manifesto?
Tobia Zevi, Associazione Hans Jonas
Leggi
|
|
|






 Roberto
Roberto
 Dario
Dario