
 |
 |
 |
 |
 Paolo Sciunnach, insegnante |
| Quale è il punto di vista della Torah in
merito al principio di maggioranza e alla considerazione della
minoranza? Che spazio ha questo sistema nella Halakhah? In epoca antica, il popolo ebraico era governato dal re. Figura ebraicamente ritenuta discutibile già ai tempi di Shemuel. Regno di Israele non significava però monarchia assoluta. Il re veniva scelto dal popolo anche se investito dal Profeta. Il potere del re d’Israele era vincolato alla Torah stessa che ne limitava i poteri. Il re era comunque sottoposto al controllo del potere giudiziario dei Maestri. |
| Leggi |
 Anna Anna Foa, storica |
| Una vita. Muoiono mille a mille. Non si alzano. Mai, mai più. Sono versi di una poetessa diciassettenne di Czernowitz morta nella Shoah, incisi nel bronzo nel Memoriale ebraico della città tedesca di Eisenach. Cugina di Paul Celan, era un'altra delle tante voci spente sul nascere che avrebbero potuto, se lasciate in vita, elevarsi alte nel panorama culturale del Novecento. E' una figura poco conosciuta questa della giovanissima Selma Meerbaum-Eisinger, che Francesca Paolino, la germanista che ne sta studiando l'opera, racconta in un libretto delle edizioni del Faro, Una vita. Selma morì in un campo di lavoro di Michailovka nel dicembre 1942 e di lei ci restano, oltre ai suoi versi e alle sue fotografie, il racconto che della sua morte fa un artista suo compagno di prigionia, Arnold Daghani, oltre a un disegno in cui questi raffigura il corpo morto della poetessa calato dalla cuccetta su cui era morta, conservato a Yad Vashem. |
 |
| MILANO – Alle ore 18.30 al Centro culturale
svizzero (Via Palestro 2), appuntamento con la presentazione del libro
“Nel caso non ci rivedessimo. Una famiglia tra deportazione e salvezza
1938-1945” (Edizioni Archinto). Parteciperanno insieme all’autore
Giorgio Sacerdoti, giurista e consigliere dell’Unione delle Comunità
Ebraiche italiane, Ulrico Hoepli, editore e Sandro Gerbi, giornalista. MILANO – Appuntamento al Cinema Anteo (via Milazzo 9) alle ore 20.30 per la proiezione del film “Il viaggio più lungo”, con la regia di Ruggero Gabbai (autori gli storici Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto, consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). TORINO – Domani alle 17.00, al Museo Diffuso della Resistenza di Torino, in Corso Valdocco 4/A, inizierà il seminario “Le politiche della memoria nel secondo dopoguerra: il caso Delbo”. Con Robert Gordon - autore del volume Scolpitelo nei cuori: l’Olocausto nella cultura italiana (1944-2010) - ed Elisabetta Ruffini - curatrice della mostra “Charlotte Delbo. La storia e la memoria” che aprirà il 27 nella stessa sede. - ne discutono Anna Bravo, Alberto Cavaglion, Diego Guzzi. |
 |
| Progetti Otto per Mille Presentazione domande |
| Scadrà il 28 febbraio il termine per la
presentazione dei progetti da realizzare con il contributo Otto per
Mille. Gli Enti o associazioni interessati dovranno compilare
l'apposita scheda dimostrando di aver presentato il modello EAS
all'Agenzia delle Entrate. La Commissione Bilancio e Otto per Mille
valuterà l'ammissibilità dei progetti e proporrà l'assegnazione del
contributo previa approvazione del Consiglio dell'Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane. |
| Leggi |
 |
| “Bergoglio vuole aprire gli Archivi su Pio XII” |
| Più vicina l’apertura degli Archivi vaticani
su Pio XII e il periodo della Shoah. È quanto afferma in un’intervista
al Sunday Times il rabbino conservative molto vicino a Bergoglio
Abraham Skorka dopo il suo ultimo incontro con il pontefice, spiegando
come quest’ultimo voglia arrivare alla verità prima della
canonizzazione. “La volontà di aprire gli archivi è sempre esistita” ha
ribadito il portavoce della Santa Sede padre Federico Lombardi (la
Stampa). Il Corriere della Sera) interpella monsignor Sergio Pagano,
prefetto dell’Archivio Segreto vaticano: “È un’operazione complessa, ci
lavoriamo da sei anni. Anche se, considerate le forze a disposizione,
non potrei fare ora una stima, dire se ci vorrà ancora un anno, un anno
e mezzo… Dopodiché deciderà il Papa”. “Un’analisi impietosa dell’assunto che sta a base di una iniziativa lodevole e nata con le migliori intenzioni: l’assunto secondo il quale il ricordo pubblico, mentre i sopravvissuti se ne vanno e svanisce fatalmente l’esperienza di una memoria diretta dello sterminio, possa fare da antidoto alla ricaduta nella barbarie”. Così sulla sua rubrica Particelle elementari del Corriere della Sera Pierluigi Battista definisce “Contro il Giorno della Memoria”, l’opera di Elena Loewenthal (Add editore) in questi giorni in libreria. Sul Fatto quotidiano intanto Furio Colombo ricorda “Quando, proponendo alla Camera la legge che istituisce il Giorno della Memoria, ho dovuto affrontare la forte spinta di varie parti politiche, ovvero ricordare insieme gli orrori della Storia (Shoah ma anche gulag ma anche foibe) non mi sono illuso di fare accettare l’immensa e tragica unicità dell’evento ma ho proposto un dato di esperienza e di realtà. In quell’aula e in ciascuno dei posti in cui noi deputati sedevamo, le leggi “per la difesa della razza italiana” erano state votate all’unanimità. Ho chiesto ai miei colleghi di riconoscere che la Shoah è un delitto italiano. È solo un simbolo, il Giorno della Memoria. Ma è il voto è stato unanime”. Sul Giorno-Carlino-Nazione si ricorda il grande concerto “I violini della speranza” organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane insieme all’Università Ebraica di Gerusalemme e l’Associazione BrainCircleltalia all’Auditorium Parco della Musica di Roma per il 27 gennaio. A Roma incontro in ricordo dell’ex primo ministro e generale israeliano Ariel Sharon nei locali del centro comunitario di via Balbo. Il Corriere Roma ritiene necessario segnalare che “la serata si è svolta senza incidenti”. Sulla Stampa Maurizio Molinari racconta “la partita a scacchi sulla Siria” a due giorni dall’inizio della conferenza di pace. |
| Leggi |
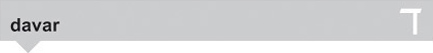
| 27
gennaio - la missione ucei-miur a cracovia Tutelare la Memoria viva Siglato un nuovo impegno  Una
circolare per consolidare il lavoro di Memoria svolto congiuntamente
dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Firmatari il ministro
Maria Chiara Carrozza e il presidente UCEI Renzo Gattegna, impegnati in
queste ore nel Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz Birkenau
assieme al presidente del Senato Pietro Grasso, ai Testimoni della
Shoah Sami Modiano e Andra e Tatiana Bucci, all'ambasciatore d'Italia
in Polonia Riccardo Guariglia, all'assessore UCEI alle scuole Raffaele
Turiel, al rav Alberto Funaro e a Marika Venezia, moglie dell'ex
sonderkommando Shlomo, e con il coinvolgimento di oltre un centinaio di
studenti italiani. Una
circolare per consolidare il lavoro di Memoria svolto congiuntamente
dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Firmatari il ministro
Maria Chiara Carrozza e il presidente UCEI Renzo Gattegna, impegnati in
queste ore nel Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz Birkenau
assieme al presidente del Senato Pietro Grasso, ai Testimoni della
Shoah Sami Modiano e Andra e Tatiana Bucci, all'ambasciatore d'Italia
in Polonia Riccardo Guariglia, all'assessore UCEI alle scuole Raffaele
Turiel, al rav Alberto Funaro e a Marika Venezia, moglie dell'ex
sonderkommando Shlomo, e con il coinvolgimento di oltre un centinaio di
studenti italiani.“Questa circolare, che segue il protocollo d'intesa siglato lo scorso anno, dà il senso di un impegno molto concreto che sta dando i suoi frutti” ha affermato il presidente dell'Unione nella sinagoga Temple di Cracovia al termine della visita al ghetto nazista e al quartiere ebraico di Kazimierz. Soddisfazione condivisa dal ministro Carrozza, che ha sottolineato “l'importanza di stare tutti assieme, Testimoni e autorità, insegnanti e studenti”, e dal presidente Grasso, la cui partecipazione al Viaggio arriva a compimento di un percorso di Memoria apertosi lo scorso 16 ottobre con le manifestazioni in ricordo della deportazione degli ebrei romani. Da tutti i partecipanti un ringraziamento per i Testimoni per la loro straordinaria dedizione affinché dal dramma della Shoah possa essere appresa una lezione per un futuro di pace e convivenza civile tra tutti i popoli. In queste ore sono proprio i Testimoni a guidare per mano la comitiva nell'orrore del lager e dell'inferno concentrazionario. I ricordi, le emozioni, il dolore si accavallano mentre il gruppo – guidato dallo storico Marcello Pezzetti e dai ricercatori della Fondazione Museo della Shoah di Roma – si muove tra la Bahnrampe, il Krematorium II, la Zentralsauna, il campo femminile, il Kinderblock. Davanti ai resti del crematorio rav Funaro recita il kaddish e suona lo shofar in ricordo di quanti persero la vita in nome dell'odio e della più bieca violenza. Alla “rampa della morte” Sami ricorda il trauma dell'arrivo dopo oltre un mese di viaggio da Rodi, mentre le sorelle Bucci – scambiate dai nazisti per gemelle – raccontano la loro miracolosa salvezza. Un momento di riflessione è inoltre dedicato allo sterminio dei popoli rom e sinti. Nel pomeriggio, dopo la visita ad Auschwitz 1 e al Museo, è prevista una cerimonia istituzionale in ricordo di tutte le vittime del campo nel cortile tra i Block 10 e 11. Adam Smulevich |
| ariel
sharon Il Leone che sapeva ascoltare  “Non aveva bisogno di chiedere lumi ad
altre persone per assumere le sue decisioni. Ma nel corso della
maturazione delle sue decisioni, amava consultarsi, era un avido
consumatore di informazione, attentissimo ai dettagli, gentile e
rispettoso con i suoi interlocutori”.
“Non aveva bisogno di chiedere lumi ad
altre persone per assumere le sue decisioni. Ma nel corso della
maturazione delle sue decisioni, amava consultarsi, era un avido
consumatore di informazione, attentissimo ai dettagli, gentile e
rispettoso con i suoi interlocutori”. Sul giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche di febbraio, presto in distribuzione, Sergio Della Pergola, l'ultimo consigliere strategico del grande leader israeliano Ariel Sharon, massimo esperto di demografia ebraica e docente di punta all’Università ebraica di Gerusalemme, traccia un ritratto inedito dello statista recentemente scomparso, ripercorrendo la sua carriera militare e politica. Un'occasione straordinaria di comprendere la realtà e la complessità di Israele al di là dei luoghi comuni. Ne anticipiamo i contenuti qui di seguito. Per ricordare Ariel Sharon si è svolta fra l'altro a Roma una serata nel centro comunitario di via Balbo, con molti interventi e la partecipazione dell’ambasciatore d’Israele Naor Gilon e del corrispondente della Stampa Maurizio Molinari. Alla fine del nostro ultimo incontro sui problemi della demografia ebraica in Israele, alle tre e mezza del pomeriggio del 18 dicembre 2005, Ariel Sharon, seduto di fronte a me al tavolo delle riunioni del governo di Israele, mi chiese: “Posso tenermi i fogli del tuo powerpoint?” Al che gli risposi: “Ma certo, Signor Primo Ministro, è tutto suo!”. La domanda rivoltami era stupefacente: l’uomo più potente di Israele, abituato a dare ordini centinaia di migliaia di soldati e a determinare i destini di milioni di civili, mi chiedeva con un ampio sorriso, quasi timido, se poteva tenersi i miei grafici e le mie tabelle per poterli studiare più attentamente in vista di una prossima ripresa della nostra conversazione. Che però non ci sarebbe stata: quella stessa sera Sharon subiva il suo primo ictus dal quale si sarebbe ripreso solo per subirne due settimane dopo un secondo, questa volta fatale e irreversibile. Poi, dopo otto anni, Ariel Sharon se n’è andato, il più grande soldato e l’ultimo dei grandi leader che hanno creato e guidato lo Stato ebraico, o – nelle parole dello Sceicco Nasrallah, capo di Hezbollah – l’ultimo re d’Israele. Nella storia di Israele, Sharon si è assicurato un posto certo come geniale e carismatico comandante militare – gravemente ferito a Latrun nella guerra d’indipendenza nel 1948, fondatore e stratega del commando dei paracadutisti nel 1950, autore del lancio al passo di Mitle nella la campagna del Sinai nel 1956, vincitore della decisiva battaglia di mezzi corazzati a Um Catef nella guerra dei Sei Giorni del 1967, autore contro gli ordini dei suoi superiori dello sfondamento del fronte egiziano sul Canale di Suez nella guerra del Kippur nel 1973. Il suo prestigio fu gravemente compromesso nella prima guerra libanese del 1982 per le eccessive perdite militari subite nella melma maronita-sciita-sunnita-drusa. Ma la caduta venne soprattutto per la strage di Sabra e Shatila, un tragico momento di annebbiamento del livello di giudizio generalmente lucido di Sharon che non impedì alle sanguinarie orde cristiane di compiere il massacro di centinaia di palestinesi. L’errore ingenuo e grave fu quello di avere fiducia nell’alleato maronita. Furono le Falangi cristiane a massacrare, e ancora oggi aspettiamo un’autorevole voce di presa di responsabilità e di condanna definitiva di quell’atto abominevole – dal pulpito di Roma o da altra apostolica sede. Invece la strage – esemplare atto di libello di sangue – fu accollata agli israeliani e costò a Sharon l’allontanamento dal posto di ministro della Difesa. Anche come politico Sharon ha lasciato un segno indelebile: fondatore del Likud e anni dopo di Kadima, grande architetto e costruttore di insediamenti nei territori palestinesi, ma anche protagonista dello sgombero della zona di Yamit nel 1982 e di Gush Katif nel 2005. Gli ingrati zeloti, oggi critici di Sharon, dovrebbero ricordarsi che senza di lui loro non sarebbero mai esistiti. Sharon fu anche protagonista della costruzione della prima casa per centinaia di migliaia di nuovi immigrati dall’Unione Sovietica. Divenuto primo ministro disse: “Da qui si vedono cose che da lì non si vedono”, e iniziò una drammatica stagione politica. Da un lato, una durissima repressione del terrorismo palestinese; dall’altro, l’inizio di un’inevitabile separazione fra israeliani e palestinesi con la costruzione della barriera di difesa che segnalava alle due parti l’esistenza di uno spazio territoriale e politico inevitabilmente da suddividere. L’obiettivo dichiarato era di assicurare a Israele uno stato permanentemente ebraico e democratico, non uno stato binazionale o uno stato di apartheid. Sharon, come Ben Gurion e come Begin, aveva ben presenti e spesso richiamava le necessità e il destino del popolo ebraico, in Israele e nella Diaspora. Avevo ascoltato per la prima volta Sharon alla cena conclusiva della conferenza di Herzliya il 4 dicembre 2002, seduto a pochi metri da lui. Assieme a una durissima requisitoria contro l’Autorità palestinese, Sharon pronunciò queste due storiche frasi: “Negoziati saranno aperti per determinare lo status finale dello Stato palestinese e per fissare i suoi confini permanenti. Israele è disposto a fare concessioni dolorose per una vera pace”. Quella sera pensai di avere bevuto troppo e di non aver ben capito, ma era l’annuncio di una scelta consapevole. Il 25 ottobre 2004 Sharon ribadì drammaticamente alla Knesset: “Noi non vogliamo governare in modo permanente su milioni di palestinesi che raddoppiano il loro numero ogni generazione”. Era la presa di coscienza di un problema demografico oltre che civile che nell’agosto del 2005 avrebbe portato alla hitnatkút, lo sgombero delle truppe e degli insediamenti da Gaza e dalla parte settentrionale della Samaria. Un ulteriore ritiro da altre parti della Cisgiordania sarebbe sicuramente seguito se non fosse intervenuta nel 2006 la vittoria di Hamas e del terrorismo negazionista alle elezioni di un’Autorità palestinese rinnovata fino al 2011 (e poi scaduta). E poi il grave ictus. La centralità della demografia nel pensiero di Sharon derivava certo dalle sue letture ma probabilmente anche dall’influenza di Ehud Olmert. Olmert, alle origini collocato a destra del Likud, era stato sindaco di Gerusalemme dal 1993 al 2003. Per lui avevo preparato le proiezioni demografiche per il piano di sviluppo fino al 2020 che indicavano la forte erosione fino alla quasi scomparsa della maggioranza ebraica in città. Nel rapporto finale scrissi che se si voleva mantenere la capitale come città ebraica, era necessaria la separazione dei quartieri arabi da quelli ebraici. Olmert mi disse che non era d’accordo ma che la mia voce era importante, e intanto era diventato il consigliere più vicino di Sharon. Forse fu lui a convincerlo che i tempi della demografia giocavano nettamente a sfavore della parte ebraica. Nel luglio del 2005, i ricercatori del Jewish People Policy Institute di cui allora facevo parte furono invitati alla seduta di governo in cui si parlò fra l’altro della demografia degli ebrei nel mondo e in Israele. Il più diligente attorno al tavolo era Sharon che prendeva appunti e alla fine sintetizzò bene la discussione. Convenimmo di rivederci per discutere più a fondo dei problemi. Ci trovammo nel suo ufficio con i suoi principali consiglieri, e sia all’inizio sia alla fine della seduta lui espresse la sua preoccupazione per la situazione del popolo ebraico, anche se non prese parte attiva al colloquio. Con Sharon e i suoi più alti funzionari ci rivedemmo ancora in dicembre per discutere più concretamente del rapporto maggioranza/minoranza in Israele e soprattutto dei livelli della natalità nel paese. Presentai un’analisi delle tendenze e delle politiche possibili a favore delle famiglie intese a sostenere quelle ebraiche senza discriminare quelle arabe. Col suo senso dell’umorismo un po’ cinico Sharon si rivolse al segretario generale del governo e gli chiese “Tu quanti figli hai?” E alla risposta “Due” gli replicò “Vai subito a casa e fai qualcosa”. Discutemmo soprattutto della necessità di provvedere sovvenzioni agli asili nido per permettere alle giovani coppie di lavorare e di poter raggiungere e mantenere il numero di figli desiderato che in Israele è in media 3-4. L’idea, che in seguito ebbi modo di discutere anche con gli uomini di Olmert divenuto primo ministro, sarebbe stata finalmente applicata dal governo Netanyahu dopo i movimenti di protesta dell’estate del 2011. Alla fine dell’ultima riunione con Sharon fui molto impressionato dalla franca e amichevole stretta di mano, dal gran sorriso dell’uomo che non era più seduto, e in piedi di fronte a me mi sembrava sorprendentemente basso e largo, ben più che non nelle immagini televisive. Sharon per prendere le grandi decisioni non aveva bisogno di chiedere lumi ad altre persone. Ma nel corso della maturazione delle sue decisioni, amava consultarsi, era un avido consumatore di informazione, attentissimo ai dettagli, gentile e rispettoso con i suoi interlocutori. Con lui è passato l’ultimo grande timoniere della politica in Israele – a meno che, chissà, l’attuale Premier non si decida ad assumere questo ruolo. Sergio Della Pergola, Università ebraica di Gerusalemme |

|
|




Pagine Ebraiche 24, l'Unione Informa e Bokertov sono pubblicazioni edite dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L'UCEI sviluppa mezzi di comunicazione che incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche. Gli articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili. Gli utenti che fossero interessati a offrire un proprio contributo possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it Avete ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio "cancella" o "modifica". © UCEI - Tutti i diritti riservati - I testi possono essere riprodotti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Direzione. l'Unione informa - notiziario quotidiano dell'ebraismo italiano - Reg. Tribunale di Roma 199/2009 - direttore responsabile: Guido Vitale.





