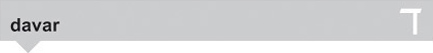Benedetto Carucci Viterbi, rabbino Benedetto Carucci Viterbi, rabbino
|
Con
l’inizio di Elul comincia il percorso d’introspezione orientato alla
consapevolezza di sé. È solamente da questa, come suggerisce Ramhal,
che può prendere avvio ogni elevazione spirituale..
|
| |
 David
Bidussa, David
Bidussa,
storico sociale
delle idee
|
Ci
sono monumenti che chiedono di essere ‘vissuti’ e non solo ‘visitati’.
È ciò che mi sembra di aver capito andando a Holocaust Mahnmal a
Berlino, un’occasione in cui si può imparare come confrontarsi con la
storia. Se fermarsi a osservare ciò che rimane e dunque dare un nome a
ognuna delle 2711 stele; se entrare nel sistema di distruzione e dunque
attraversare e percorrere quello spazio all’aperto osservando gli altri
e se stessi entrare, comparire e di nuovo farsi acchiappare e
scomparire in quel labirinto progressivamente senza più luce; se
chiedersi come sono andate le cose e dunque come l’orco delle fiabe
sentire l’odore della carne umana e cercare dov’era la vita, per
vederla com’era fino a un attimo prima, e allora decidere di scendere,
andando fisicamente sotto i fatti e i resti, oltre ciò che rimane,
oltre ciò che vediamo da fuori.
|
| |
|
|
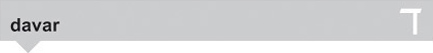
cinema - LOCARNO, IL FESTIVAL CHIUDE I BATTENTI
Il Pardo premia i film d'Israele
e la Memoria della Germania
 L’identità
ebraica attraverso l’estrema complessità nella vita degli ebrei
Haredim, Israele, il dovere di fare i conti con la Memoria. L’identità
ebraica attraverso l’estrema complessità nella vita degli ebrei
Haredim, Israele, il dovere di fare i conti con la Memoria.
Assegnando il premio speciale della giuria a “Tikkun”, il possente
racconto del giovane israeliano Avishai Sivan, e attribuendo a “Der
Staat gegen Fritz Bauer” (“Lo Stato contro Fritz Bauer”) di Lars Kraume
l’ambito premio del pubblico di piazza Grande, il sessantottesimo
Festival del film di Locarno fa calare il sipario su un’edizione
straordinaria con un marcato riconoscimento delle grandi tematiche
ebraiche contemporanee.
Il secondo lavoro di Sivan, di cui questo notiziario ha già riferito
diffusamente e di cui torneremo a parlare nelle prossime settimane,
travolge l’immaginario dello spettatore con i suoi bagliori in bianco e
nero e lo introduce nel mondo dell’ortodossia ebraica più estrema
proprio in una stagione in cui nell’universo ebraico tutte le ferite
sono aperte e tutte le sensibilità sono accese.
Il film costituisce un’esperienza drammatica che sarebbe assai
riduttivo ascrivere unicamente alla sfera dello spettacolo. La sua
apparizione nelle sale, durante la prossima stagione, promette di
rimettere la creatività di Israele, così come l’immenso valore del
caleidoscopio sociopolitico di Israele, al centro dell’attenzione.
Ma al di là dell’emozione e della suggestione fortissima, è la capacità
tecnica di Sivan e di tutto il suo staff ad essere messa in luce. Non a
caso la stessa Giuria ha voluto assegnare un’ulteriore menzione
speciale alla fotografia di Shai Goldman, l’operatore di “Tikkun", che
con la sua estrema sensibilità ha offerto una dimostrazione vivida di
quello che può ancora fare il cinema di qualità.
Ma la presenza di Sivan non è il solo segno di Israele al grande
festival cinematografico elvetico. Sugli schermi di Locarno è passato
fra gli applausi anche lo struggente “Haganenet” (“La maestra d’asilo”)
di Nadav Lapid e soprattutto, a porte chiuse, sei grandi film di
domani, il meglio che bolle in pentola nella cinematografica israeliana
e non è stato ancora compiuto perché a caccia di finanziamenti. Una
piattaforma di lancio sempre più importante per la cultura ebraica e
per la produzione culturale di Israele.
 Di
grande significato anche il riconoscimento del Festival al tedesco Lars
Kraume, che racconta per la prima volta al grande pubblico la vicenda
di Fritz Bauer, ebreo tedesco sopravvissuto alla Shoah, magistrato
supremo della nuova Germania, Procuratore generale dell’Assia, che
nell’immediato dopoguerra, in una Germania ancora pericolosamente
infestata nelle sue strutture dalla presenza di ex nazisti, è costretto
a tradire il suo paese per salvarne l’onore, e svolge un ruolo
determinante nell’arresto del criminale Adolph Eichmann spingendo il
Mossad ad agire là dove la magistratura tedesca sentiva ancora le mani
legate dal terribile retaggio del passato. Di
grande significato anche il riconoscimento del Festival al tedesco Lars
Kraume, che racconta per la prima volta al grande pubblico la vicenda
di Fritz Bauer, ebreo tedesco sopravvissuto alla Shoah, magistrato
supremo della nuova Germania, Procuratore generale dell’Assia, che
nell’immediato dopoguerra, in una Germania ancora pericolosamente
infestata nelle sue strutture dalla presenza di ex nazisti, è costretto
a tradire il suo paese per salvarne l’onore, e svolge un ruolo
determinante nell’arresto del criminale Adolph Eichmann spingendo il
Mossad ad agire là dove la magistratura tedesca sentiva ancora le mani
legate dal terribile retaggio del passato.
Kraume tiene il ritmo senza tradire la vera, drammatica realtà di
questa vicenda. Ma soprattutto mostra alle giovani generazioni il
momento del difficile passaggio, determinante nell’identità della
Germania contemporanea, fra il superamento del passato attraverso la
negazione e la cancellazione della memoria e una dolorosa maturazione
nazionale che proprio Fritz Bauer riuscì infine ad avviare con
l’istruzione dei processi di Francoforte e infine la messa a nudo della
pervasiva struttura criminale di Auschwitz.
Un confronto autentico con la Memoria viva e non con la ritualistica
della memoria, che come è noto nella Germania di oggi si può
considerare una conquista determinante e che in Italia dopo mille
elusioni deve purtroppo essere ancora intrapreso.
gv
(Nell’immagine in alto una scena del film “Tikkun”, in quella in basso una di “Der Staat gegen Fritz Bauer”)
|
CINEMA – protagonista a LOCARNO
Il fenomeno Amy Schumer
 Ha
trent’anni e qualcosa, lunghi capelli biondi e non ci sta. Non ci sta a
chi la definisce ‘una comica donna’, celando un certo maschilismo di
ritorno. Non ci sta a chi la vuole incasellare nella categoria ‘gli
ebrei sono sempre più divertenti’ e soprattutto non accetta
silenziosamente che nell’America del 2015 qualcuno possa entrare armato
nella sala di un cinema dove stano proiettando il suo film Trainwreck
per uccidere. Ha
trent’anni e qualcosa, lunghi capelli biondi e non ci sta. Non ci sta a
chi la definisce ‘una comica donna’, celando un certo maschilismo di
ritorno. Non ci sta a chi la vuole incasellare nella categoria ‘gli
ebrei sono sempre più divertenti’ e soprattutto non accetta
silenziosamente che nell’America del 2015 qualcuno possa entrare armato
nella sala di un cinema dove stano proiettando il suo film Trainwreck
per uccidere.
Amy
Schumer, protagonista dell’ultimo Festival del film di Locarno è la
star del momento. Incensata come la Bridget Jones della generazione
millenials, è stata apprezzata dal grande pubblico per la serie Inside
Amy Schumer trasmessa su Comedy Central a partire dal 2013. Ha poi
scritto il suo primo film, Trainwreck (in Italia tradotto con il titolo
Un disastro di ragazza), prodotto e diretto dal guru della comicità
Judd Apatow, nel quale interpreta Amy, una ragazza refrattaria alle
relazioni serie che si imbatte nel grande amore e innesca una serie di
situazioni surreali. “Il 70% delle cose che racconto – ammette
l’attrice – è accaduto davvero”. Ma, rassicura: “Il 30% non è reale”.
Nata
nel 1981 a New York dal padre Gordon, di origine ebraica, e la madre
Sandra Jones, Schumer è stata cresciuta come ebrea; un particolare sul
quale non si esime dall’ironizzare: “La mia esperienza con l’ebraismo è
stata la seguente: andavo al tempio ogni venerdì e alla scuola ebraica
la domenica. Poi ho celebrato il mio bat mitzvah, e penso che quella
sia stata l’ultima volta che sono entrata in una sinagoga. Non è stata
una decisione che ho preso con consapevolezza, è solo andata così. Non
è nemmeno stata una vera e propria scelta perché amo le tradizioni e i
rituali ebraici, specie l’accensione delle candele”.
Schumer
fa poi riferimento al suo bat mitzvah quando racconta gli entusiasmi
nati dalla presenza della superstar del basket LeBron James nel suo
film: “Da quando la gente l’ha saputo, tutti vogliono essere miei
amici. Mi ha ricordato il momento nel quale dovevo mandare gli inviti
per la festa del bat mitzvah e improvvisamente a scuola mi dicevano:
‘Hey mi piace il tuo look di oggi’ e io, piuttosto scettica, pensavo:
Hey perché mi rivolgi per la prima volta la parola proprio adesso?”.
Leggi
|
NUOVE RECENSIONI DOPO LA NOSTRA ANTICIPAZIONE
Almansi, il canto riscoperto
  "Restituire la voce a chi non ha più voce. Ridare il canto ai diseredati, agli esclusi, agli sconfitti, ai sommersi”. "Restituire la voce a chi non ha più voce. Ridare il canto ai diseredati, agli esclusi, agli sconfitti, ai sommersi”.
Questa la missione dello scrittore biellese Emilio Jona, il cui ultimo libro – “Il celeste scolaro” (ed. Neri Pozza)
– continua a far parlare di sé e a raccogliere l’interesse dei
protagonisti della cultura italiana. Ultimo in ordine di tempo il
germanista Claudio Magris, che gli ha riservato ieri un’ampia
recensione sul Corriere della sera.
Dedicata al giovane poeta Federico Almansi, il “celeste scolaro” di
Umberto Saba che ispirò alcune delle pagine più alte del Novecento,
l’opera era stata anticipata in giugno da Pagine Ebraiche.
Nell’occasione
si spiegava come ad emergere dal racconto dello scrittore non fosse
solo una vita travagliata ma, in un certo modo, anche l’intero secolo
visto dagli occhi degli ebrei italiani: la radice identitaria, l’amore
per gli ideali, la cultura, la poesia, la famiglia, l’avventura,
l’esclusione, la persecuzione, la Resistenza, la ricostruzione,
l’amicizia, la passione, l’amore, la psicanalisi, la psichiatria, la
disperazione.
“Le pagine de ‘Il celeste scolaro’ – sottolineava Guido Vitale,
direttore della redazione – sono anche un modo di restituire e di
rileggere l’opera di Saba”. Jona mette infatti in gioco, assieme alle
sue doti di narratore, la sua conoscenza dei fatti e di documenti
inediti di enorme interesse. Oltre a una cultura vastissima e a una
grande frequentazione dell’opera del poeta triestino.
Leggi
|

| Che cos'è la radicalizzazione/2 |
 L’eroe
negativo è una figura fondamentale del processo di radicalizzazione:
raccoglie su di sé la riprovazione sociale di quanti ne contestano la
condotta e, nel medesimo tempo, la solidarietà del gruppo, ossia di
coloro che si sentono a lui omologhi. Fondamentale, in questo percorso,
è la visibilità dettata dai mass media nonché l’amplificazione che essi
concorrono a garantire ad ogni gesto eclatante. È uno dei risultati di
quella logica globalizzante che agisce come una sorta di ‘infosfera’,
dove gli eventi diventano notizie e rimbalzano in tante direzioni,
moltiplicandone l’eco. La trasformazione dell’atto in evento mediatico
contribuisce quindi a rinforzare quella miscela di fascinazione e
repulsione, di seduzione e intimidazione, di identificazione e
inibizione che molti gesti violenti portano con sé. Dopo di che, esiste
anche un’altra questione di fondo, che si lega a quelle precedenti. Si
tratta delle conseguenze di lungo periodo dei processi di
de-istituzionalizzazione, ossia della riduzione dell’intervento
pubblico in molti ambiti del vivere civile e degli effetti che tali
dinamiche producono sugli individui come sulle comunità. Se i fattori
di integrazione sociale (lavoro, scuola, ma anche mobilità ascendente,
inter e multiculturalismo), vanno consumandosi, come avviene – ad
esempio – per gli immigrati di seconda e terza generazione, è
inevitabile che da ciò derivino comportamenti di minore disponibilità a
riconoscersi nell’ambiente di vita quotidiana, cercando semmai in un
qualche altra dimensione, spesso puramente idealizzata, ciò che
l’esistenza abituale in genere non offre. La frattura tra generazioni
è, in questo caso, molto pronunciata. L’eroe
negativo è una figura fondamentale del processo di radicalizzazione:
raccoglie su di sé la riprovazione sociale di quanti ne contestano la
condotta e, nel medesimo tempo, la solidarietà del gruppo, ossia di
coloro che si sentono a lui omologhi. Fondamentale, in questo percorso,
è la visibilità dettata dai mass media nonché l’amplificazione che essi
concorrono a garantire ad ogni gesto eclatante. È uno dei risultati di
quella logica globalizzante che agisce come una sorta di ‘infosfera’,
dove gli eventi diventano notizie e rimbalzano in tante direzioni,
moltiplicandone l’eco. La trasformazione dell’atto in evento mediatico
contribuisce quindi a rinforzare quella miscela di fascinazione e
repulsione, di seduzione e intimidazione, di identificazione e
inibizione che molti gesti violenti portano con sé. Dopo di che, esiste
anche un’altra questione di fondo, che si lega a quelle precedenti. Si
tratta delle conseguenze di lungo periodo dei processi di
de-istituzionalizzazione, ossia della riduzione dell’intervento
pubblico in molti ambiti del vivere civile e degli effetti che tali
dinamiche producono sugli individui come sulle comunità. Se i fattori
di integrazione sociale (lavoro, scuola, ma anche mobilità ascendente,
inter e multiculturalismo), vanno consumandosi, come avviene – ad
esempio – per gli immigrati di seconda e terza generazione, è
inevitabile che da ciò derivino comportamenti di minore disponibilità a
riconoscersi nell’ambiente di vita quotidiana, cercando semmai in un
qualche altra dimensione, spesso puramente idealizzata, ciò che
l’esistenza abituale in genere non offre. La frattura tra generazioni
è, in questo caso, molto pronunciata.
Claudio Vercelli
Leggi
|
|
| Le voci che mancano |
 Abbiamo
assistito con crescente orrore alle gesta delinquenziali degli
estremisti ebrei di Israele: l’uccisione di un infante arabo e quella
di una giovane dimostrante che si batteva perché i gay avessero la
libertà di vivere come vogliono e di farlo sapere all’esterno del loro
gruppo. I commenti inorriditi delle più alte autorità dello Stato non
si sono fatti attendere: ciascuno, a seconda del proprio ruolo, ha
manifestato il proprio sdegno e ha anche proposto misure repressive per
contenere con la forza il ripetersi di azioni indegne di tal fatta.
Anche i rabbini italiani con parole diverse, ma sentimenti unanimi
hanno stigmatizzato e deplorato questi fatti terribili. Ma una voce è
mancata, anzi due. Una parte del Rabbinato israeliano è rimasta
silente. Sarebbe stato logico ed auspicabile che si fosse levata,
pronta e sonora, la voce sia del Rabbinato ufficiale sia quella dei
rabbini che dalle varie yeshivot ispirano questi teppisti
delinquenziali che pretendono di parlare in nome della Torah e invece
la profanano con le parole e le azioni. Abbiamo
assistito con crescente orrore alle gesta delinquenziali degli
estremisti ebrei di Israele: l’uccisione di un infante arabo e quella
di una giovane dimostrante che si batteva perché i gay avessero la
libertà di vivere come vogliono e di farlo sapere all’esterno del loro
gruppo. I commenti inorriditi delle più alte autorità dello Stato non
si sono fatti attendere: ciascuno, a seconda del proprio ruolo, ha
manifestato il proprio sdegno e ha anche proposto misure repressive per
contenere con la forza il ripetersi di azioni indegne di tal fatta.
Anche i rabbini italiani con parole diverse, ma sentimenti unanimi
hanno stigmatizzato e deplorato questi fatti terribili. Ma una voce è
mancata, anzi due. Una parte del Rabbinato israeliano è rimasta
silente. Sarebbe stato logico ed auspicabile che si fosse levata,
pronta e sonora, la voce sia del Rabbinato ufficiale sia quella dei
rabbini che dalle varie yeshivot ispirano questi teppisti
delinquenziali che pretendono di parlare in nome della Torah e invece
la profanano con le parole e le azioni.
Roberto Jona, Università di Torino
Leggi
|
|
|





 David
Bidussa,
David
Bidussa,