

 |
 |
 |
 |
 Paolo Sciunnach, Paolo Sciunnach,insegnante |
| Entriamo nel mese della Teshuvah. Da dove cominciare? Che fare? È scritto nella Ghemarah: E disse Rav Yitzchack: quattro cose fanno strappare il decreto di giudizio di una persona, esse sono: fare Tzedakah, gridare verso D-o, cambiare nome, cambiare comportamento, e c’è chi dice cambiare posto. (Rosh Hashanah 16b) Cosa significa? |
| Leggi |
 Anna Anna Foa, storica |
| L’Austrian
Holocaust Memorial award è stato conferito quest’anno al sindaco di
Predappio per la sua opera nel tener viva la memoria dell’antifascismo
e della Shoah. Confesso di esserne rimasta molto colpita. Il
riconoscimento premia l’iniziativa del sindaco di Predappio volta a
creare nella città natale di Mussolini un museo del fascismo. Nelle
polemiche che hanno seguito mesi fa la proposta non mi sembra nemmeno
che sia stata sottolineata la volontà antifascista del sindaco, ma
semmai la necessità di uno sguardo storiograficamente solido (come se
gli storici finora si siano raccontati barzellette). Ora che il sindaco
decida di aprire accanto alle rivendite di gadgets frequentati da
schiere di nostalgici a braccio teso un museo volto a spiegare
storicamente il fascismo può anche essere un’iniziativa lodevole,
sempre che se ne tengano presenti le motivazioni turistiche. Ma che sia
premiato per la sua opera nel salvaguardare la memoria della Shoah, mi
sembra francamente eccessivo. Stiamo perdendo anche il senso del
ridicolo e finiremo per credere che Predappio sia l’ombelico del mondo. |
 |
| I musei e il futuro |
| Si
è conclusa ieri l’ultima edizione della Festa del Libro ebraico di
Ferrara, l’appuntamento dedicato alla letteratura e alla cultura
ebraica organizzato dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della
Shoah. Tra gli incontri più seguiti, quello che ha visto protagonisti
alcuni dei direttori dei più importanti musei ebraici europei e
israeliani. Al centro della tavola rotonda, come racconta Elena
Loewenthal su La Stampa, il ruolo del museo come luogo di conservazione
della memoria e allo stesso tempo come spazio didattico proiettato al
futuro. Nel pezzo della Stampa si fa poi riferimento alle parole di
Amos Oz, citate dalla presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane Noemi Di Segni nell’applaudito discorso inaugurale alla Festa
del Libro ebraico. Secondo Oz, “Non esistiamo solo e soltanto per
conservare: che si tratti di tradizione degli avi o meraviglie della
natura, ricordi di infanzia o arredi sacri. Se così fosse, la nostra
vita sarebbe soltanto un atto di culto”. |
| Leggi |
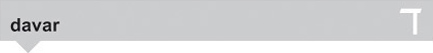
|
pagine ebraiche - il dossier di settembre Costruire cultura, dall'infanzia  Ambasciatori
di cultura, luoghi di formazione, apertura e incontro, i musei ebraici
hanno un ruolo sempre più importante in una società che si confronta
con le minoranze con fatica sempre maggiore. Non più contenitori di
oggetti pur preziosi e ricchi di storia, i grandi luoghi deputati a
raccontare le tradizioni e la cultura dell’ebraismo si trasformano in
vere e proprie istituzioni dedite alla formazione. Forti di principi
didattici e pedagogici, capaci di grandi investimenti sul futuro,
puntano sui giovani e soprattutto sui giovanissimi. Ambasciatori
di cultura, luoghi di formazione, apertura e incontro, i musei ebraici
hanno un ruolo sempre più importante in una società che si confronta
con le minoranze con fatica sempre maggiore. Non più contenitori di
oggetti pur preziosi e ricchi di storia, i grandi luoghi deputati a
raccontare le tradizioni e la cultura dell’ebraismo si trasformano in
vere e proprie istituzioni dedite alla formazione. Forti di principi
didattici e pedagogici, capaci di grandi investimenti sul futuro,
puntano sui giovani e soprattutto sui giovanissimi.Sono loro i protagonisti del dossier "Musei", curato da Ada Treves e pubblicato sul numero di settembre del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche in distribuzione. Sono di Anton Bruckner, compositore e musicista austriaco, le parole che il ministro tedesco per la Cultura e per i Media Monika Grütters ha scelto lo scorso gennaio per salutare e sostenere il bando per la progettazione del nuovo padiglione del Museo ebraico di Berlino, il Jüdisches Museum Berlin, noto come JMB. Un’avventura coraggiosa e volta al futuro, che porterà nel 2019 all’apertura di un grande Museo dei bambini. “Chiunque voglia costruire alte torri deve dedicare molto tempo alle loro fondamenta”, erano le parole di Bruckner. Grütters ha spiegato: “Sappiamo bene che si riferiva alle fondamenta dell’educazione alla cultura, che ha un effetto profondo sulla crescita personale. Instillare nei giovani un sincero entusiasmo per i tanti diversi campi del pensiero umano e per i risultati raggiunti non è solo compito di genitori, nonni e insegnanti. Anche le istituzioni culturali sono importanti centri di educazione alla cultura per i giovani, perché possono accendere la scintilla dell’interesse per la storia, la religione, la scienza e l’arte in maniera più vivida di qualsiasi libro di testo”. Leggi |
|
venezia 500 - L'INIZIATIVA La Fenice, musica dell'incontro  “Con
le parole della musica – per non dimenticare”. Questo il titolo del
prestigioso concerto offerto ieri al Teatro La Fenice di Venezia dal
Centro Tedesco di Studi Veneziani e dal Comune in occasione delle
iniziative per i 500 anni del Ghetto, che proprio alla Fenice avevano
preso avvio nel marzo scorso. Musiche di Giuseppe Tartini, Erwin
Schulhoff e Felix Mendelssohn Bartholdi, interpretate dagli artisti
Francesca Dego, violino; Silvia Chiesa, violoncello; Mariangela
Vacatello, pianoforte. “Con
le parole della musica – per non dimenticare”. Questo il titolo del
prestigioso concerto offerto ieri al Teatro La Fenice di Venezia dal
Centro Tedesco di Studi Veneziani e dal Comune in occasione delle
iniziative per i 500 anni del Ghetto, che proprio alla Fenice avevano
preso avvio nel marzo scorso. Musiche di Giuseppe Tartini, Erwin
Schulhoff e Felix Mendelssohn Bartholdi, interpretate dagli artisti
Francesca Dego, violino; Silvia Chiesa, violoncello; Mariangela
Vacatello, pianoforte.Numerosi i rappresentanti istituzionali presenti. A portare un saluto, tra gli altri, il il Maestro Alessandro Fantini per il Teatro la Fenice, il presidente Michael Matheus per il Centro Tedesco di Studi Veneziani, il presidente Paolo Gnignati per la Comunità ebraica, l’assessore al turismo Paola Mar per il Comune e infine Horst Claussen per l‘incaricata del Governo della Repubblica Federale di Germania per la Cultura e i Mass media. Leggi |
|
qui parigi - l'intervento del gran rabbino "Laicità, valore da difendere"  Al
termine di una lunga estate, il gran rabbino di Francia Haim Korsia
tira le somme dei mesi passati, in cui il dibattito sul rapporto tra
religione e Stato è stato il grande protagonista dell’attualità. Korsia
ha infatti rilasciato un’intervista al quotidiano Le Figaro in cui ha
ripercorso gli eventi che hanno segnato le ultime settimane, tra cui
l’infiammare della polemica sul burkini, la sconvolgente uccisione di
padre Hamel mentre officiava la messa a Saint-Etienne-du-Rouvray
nell’attentato terroristico del 26 luglio, seguito a quello di Nizza il
14 luglio nel giorno della Festa nazionale, e la delineazione sempre
più netta di una futura Fondazione per l’Islam di Francia. Per il rav
Korsia la risposta a tutti gli interrogativi risiede nella comprensione
del vero significato della laicità dello Stato, senza la quale “la
Francia non sarebbe più la Francia, dal momento che la laicità non è un
ateismo di Stato, ma la neutralità dello Stato per garantire la vita
dei vari culti”. In questo senso, aggiunge, una eccessiva legislazione
costituirebbe un passo falso: “La volontà di legiferare senza limiti
mostra che non si riesce più a trovare un consenso tra di noi dul modo
di vivere insieme. Dobbiamo diventare perpetuamente interpreti della
legge? Non credo – la sua risposta – in quanto rovinerebbe la
semplicità della vita in comune”. Al
termine di una lunga estate, il gran rabbino di Francia Haim Korsia
tira le somme dei mesi passati, in cui il dibattito sul rapporto tra
religione e Stato è stato il grande protagonista dell’attualità. Korsia
ha infatti rilasciato un’intervista al quotidiano Le Figaro in cui ha
ripercorso gli eventi che hanno segnato le ultime settimane, tra cui
l’infiammare della polemica sul burkini, la sconvolgente uccisione di
padre Hamel mentre officiava la messa a Saint-Etienne-du-Rouvray
nell’attentato terroristico del 26 luglio, seguito a quello di Nizza il
14 luglio nel giorno della Festa nazionale, e la delineazione sempre
più netta di una futura Fondazione per l’Islam di Francia. Per il rav
Korsia la risposta a tutti gli interrogativi risiede nella comprensione
del vero significato della laicità dello Stato, senza la quale “la
Francia non sarebbe più la Francia, dal momento che la laicità non è un
ateismo di Stato, ma la neutralità dello Stato per garantire la vita
dei vari culti”. In questo senso, aggiunge, una eccessiva legislazione
costituirebbe un passo falso: “La volontà di legiferare senza limiti
mostra che non si riesce più a trovare un consenso tra di noi dul modo
di vivere insieme. Dobbiamo diventare perpetuamente interpreti della
legge? Non credo – la sua risposta – in quanto rovinerebbe la
semplicità della vita in comune”.Leggi |
|
IL NOTIZIARIO SPECIALE "Giornata, occasione per Milano"  Continua
la marcia di avvicinamento alla Giornata Europea della Cultura Ebraica
(domenica 18 settembre), quando oltre 70 località in tutta Italia
dedicheranno conferenze, concerti, spettacoli alle Lingue e i dialetti
ebraici, tema di quest'anno. A fare da capofila sarà Milano, come
raccontano Davide Romano e Gadi Schoenheit, rispettivamente assessore e
viceassessore alla Cultura della Keillah milanese, nello speciale
notiziario realizzato appositamente per raccontare la Giornata. Nel
fitto programma milanese, che vedrà tra i suoi ospiti d'eccezione il
ministro della Difesa Roberta Pinotti (che parlerà della parola Pace,
Shalom), un viaggio attorno al mondo e alle lingue dell'ebraismo con
Caffe Odessa, lo spettacolo ideato da Miriam Camerini, di cui compare
un'intervista sulla nostra newsletter speciale.
Parlando di lingue ebraiche, non poteva mancare il giudaico romanesco,
grande protagonista delle iniziative della Capitale e di cui parla
Simona Foà, descrivendola come “la lingua della povertà e della
separazione in quanto era usata soprattutto dalla parte più povera,
anche culturalmente, degli abitanti del ghetto". Inoltre, si dice,
"essa si può considerare come una sorta di linguaggio cifrato, per così
dire, perché usata per non farsi capire in contesti quotidiani o
difficili”. Continua
la marcia di avvicinamento alla Giornata Europea della Cultura Ebraica
(domenica 18 settembre), quando oltre 70 località in tutta Italia
dedicheranno conferenze, concerti, spettacoli alle Lingue e i dialetti
ebraici, tema di quest'anno. A fare da capofila sarà Milano, come
raccontano Davide Romano e Gadi Schoenheit, rispettivamente assessore e
viceassessore alla Cultura della Keillah milanese, nello speciale
notiziario realizzato appositamente per raccontare la Giornata. Nel
fitto programma milanese, che vedrà tra i suoi ospiti d'eccezione il
ministro della Difesa Roberta Pinotti (che parlerà della parola Pace,
Shalom), un viaggio attorno al mondo e alle lingue dell'ebraismo con
Caffe Odessa, lo spettacolo ideato da Miriam Camerini, di cui compare
un'intervista sulla nostra newsletter speciale.
Parlando di lingue ebraiche, non poteva mancare il giudaico romanesco,
grande protagonista delle iniziative della Capitale e di cui parla
Simona Foà, descrivendola come “la lingua della povertà e della
separazione in quanto era usata soprattutto dalla parte più povera,
anche culturalmente, degli abitanti del ghetto". Inoltre, si dice,
"essa si può considerare come una sorta di linguaggio cifrato, per così
dire, perché usata per non farsi capire in contesti quotidiani o
difficili”.Come si diceva, sono oltre 70 le località che partecipano alla Giornata: tra queste Firenze, Siena e Venezia, di cui sul notiziario si racconta il programma. |
|
informazione - international edition Un autunno di cultura e impegno  Sono
meno di 2500 le domande per ricevere la cittadinanza spagnola
presentate dagli ebrei sefarditi del mondo alle autorità di Madrid. A
dare conto della notizia, il quotidiano iberico El Pais, che avanza
degli interrogativi sull’efficacia della recente legge che consente ai
discendenti di coloro che furono cacciati dalla Spagna nel 1492 di
riavere status e passaporto, pensata come forma di risarcimento
simbolico per ciò che accadde allora, ma anche come misura per favorire
il rilancio economico del paese. L’articolo è proposto nella sezione
Bechol Lashon dell’odierna uscita di Pagine Ebraiche International
Edition, che propone per i lettori di tutto il mondo un focus
sull’autunno dell’Italia ebraica all’insegna della cultura e della
solidarietà. Sono
meno di 2500 le domande per ricevere la cittadinanza spagnola
presentate dagli ebrei sefarditi del mondo alle autorità di Madrid. A
dare conto della notizia, il quotidiano iberico El Pais, che avanza
degli interrogativi sull’efficacia della recente legge che consente ai
discendenti di coloro che furono cacciati dalla Spagna nel 1492 di
riavere status e passaporto, pensata come forma di risarcimento
simbolico per ciò che accadde allora, ma anche come misura per favorire
il rilancio economico del paese. L’articolo è proposto nella sezione
Bechol Lashon dell’odierna uscita di Pagine Ebraiche International
Edition, che propone per i lettori di tutto il mondo un focus
sull’autunno dell’Italia ebraica all’insegna della cultura e della
solidarietà.Leggi |

|







Pagine Ebraiche 24, l'Unione Informa e Bokertov sono pubblicazioni edite dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L'UCEI sviluppa mezzi di comunicazione che incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche. Gli articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili. Gli utenti che fossero interessati a offrire un proprio contributo possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it Avete ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio "cancella" o "modifica". © UCEI - Tutti i diritti riservati - I testi possono essere riprodotti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Direzione. l'Unione informa - notiziario quotidiano dell'ebraismo italiano - Reg. Tribunale di Roma 199/2009 - direttore responsabile: Guido Vitale.




