

 |
 |
 |
 |
 Pierpaolo Pinhas Punturello, rabbino |
| È
tosto il personaggio di Pinchas. Difficile accettare il coraggio
impulsivo del suo gesto, ma è innegabile il suo merito. Certo per
“legalizzare” quel merito ci vuole Dio come leggiamo in Numeri 25,
12-13: “Perciò digli: ‘Ecco, io stabilisco con lui un’alleanza di
pace,che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui l’alleanza di
un sacerdozio perpetuo, perché ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto
l’espiazione per i figli d’Israele'”. Ed è difficile che La comunità
umana accetti di buon grado un dardo scagliato addosso. Ma proprio per
questo il gesto di Pinchas non può essere ripetuto e non è un
insegnamento, mentre il suo coraggio è d’esempio: un coraggio che è
rispetto della Torá e rispetto del prossimo, altrimenti i dardi che
lanciamo non hanno senso morale e sarebbe meglio giocare a fremette. |
 Gadi GadiLuzzatto Voghera, direttore Fondazione CDEC |
| In
un articolo su Il Giornale di martedì 3 luglio Fiamma Nirenstein
riflette sull’antisemitismo nei movimenti politici in Europa, indicando
giustamente che la sua presenza è equamente distribuita un po’ in tutte
le formazioni. La passione professionale e politica la spinge
legittimamente a sottolineare la pervasiva presenza di questa ideologia
nell’islamismo che “ha seguitato a perseguitare e uccidere ebrei in
Francia, Belgio, Inghilterra, Paesi Bassi”. La sua valutazione è che i
cosiddetti populismi di destra in Europa, sebbene non siano esenti
dalla presenza di antisemitismo diffuso, siano in realtà poco
pericolosi su questo versante perché – questa la sua idea –
mancherebbero “molti degli elementi che ne hanno fatto nel secolo
scorso un movimento di massa”. Molto più pericoloso, a suo giudizio,
sarebbe il versante progressista. “In Europa c’è antisemitismo? Di
certo. È opera della destra? No, è israelofobia antisemita di sinistra”. Si tratta naturalmente di valutazioni giornalistiche, che di certo non sono campate in aria. Per usare lo stesso metodo dell’amica Nirenstein, si potrebbe porre la domanda retorica: c’è antisemitismo a sinistra? Certo che sì, e chi scrive ne ha fatto oggetto di studio in diverse occasioni. Tuttavia va sottolineato che i sondaggi e le indagini demoscopiche degli ultimi anni non sono esattamente in linea con le valutazioni proposte nell’articolo. La grande maggioranza delle polemiche a carattere antisemita presenti su internet, oppure prodotte nell’editoria periodica o in libri, fanno parte a pieno titolo dei movimenti politici ultraconservatori del suprematismo e dell’estrema destra. |
| Leggi |
 |
| Addio a Lanzmann |
| Con
la scomparsa di Claude Lanzmann, è parere unanime, scompare un gigante
della Memoria capace con il suo Shoah di segnare un’epoca. “Nulla è
vagamente paragonabile a questo film, all’impatto che provocò,
all’avvicendarsi di volti, voci, paesaggi sullo schermo. Shoah è stato
e rimane l’abc dell’indicibile” scrive Elena Loewenthal, sulla Stampa,
a proposito del suo capolavoro. “Nella battaglia immanente per non
dimenticare la Shoah l’opera di Lanzmann è destinata a rimanere una
risorsa irrinunciabile” conferma il direttore Maurizio Molinari. “La memoria è una costruzione, basata su testimonianze, filtrate dalla nostra percezione etica ed estetica di quelle testimonianze”. Questo per Wlodek Goldkorn, che ne scrive su Repubblica, il suo insegnamento fondamentale. Shoah, da Paolo Mereghetti sul Corriere, è definita “un’opera monumentale che riesce a raccontare l’indicibile e la radicalità della morte evitando ogni retorica”. “Forse soltanto un cartoonist come Art Spiegelman, con il suo Maus, ha saputo avvicinarsi a tali cime abissali, grazie però all’uso della matita” sottolinea Claudio Vercelli sul Manifesto. Sul festival organizzato da un’associazione di estrema destra ad Abbiategrasso, di cui molto si è parlato negli scorsi giorni, da segnalare l’intervento della senatrice a vita Liliana Segre che in una interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive: “La Repubblica democratica nata dalla Resistenza non può accettare forme di manifestazione in cui vengano programmaticamente diffusi messaggi e simbologie dichiaratamente razziste, xenofobe e apologetiche del fascismo”. Scrive al riguardo il Corriere Milano: “Nei giorni scorsi sono arrivati appelli da parte di Anpi, Unione delle comunità ebraiche, sindacati, associazioni antifasciste e da una ventina di sindaci della zona. Ieri l’indignazione ha raggiunto il Viminale accompagnata da una firma che dice qualcosa di più”. |
|
Leggi |
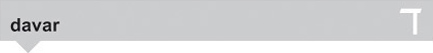
|
La lezione di anna foa al meis Ebrei e Chiesa, dall'Inquisizione alla nuova sfida del Dialogo  I
rapporti tra ebrei e Chiesa cristiana sono, per Anna Foa, non solo uno
dei temi dominanti della sua vita di docente universitaria – ha
insegnato alla Sapienza di Roma (Storia Moderna), all’Università
Gregoriana e all’Università Ebraica di Gerusalemme – ma anche il nucleo
della sala che ha curato al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah, nel percorso espositivo “Ebrei, una storia italiana. I
primi mille anni”. E proprio su “Ebrei, cristiani e Chiesa” la
professoressa Foa è intervenuta ieri al Meis, per il ciclo di incontri
alla scoperta della mostra.
I
rapporti tra ebrei e Chiesa cristiana sono, per Anna Foa, non solo uno
dei temi dominanti della sua vita di docente universitaria – ha
insegnato alla Sapienza di Roma (Storia Moderna), all’Università
Gregoriana e all’Università Ebraica di Gerusalemme – ma anche il nucleo
della sala che ha curato al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah, nel percorso espositivo “Ebrei, una storia italiana. I
primi mille anni”. E proprio su “Ebrei, cristiani e Chiesa” la
professoressa Foa è intervenuta ieri al Meis, per il ciclo di incontri
alla scoperta della mostra.“Autrice di testi e saggi che sono ormai dei classici – così l’ha introdotta il Direttore del Museo, Simonetta Della Seta –, oltre alle recensioni di libri ebraici che scrive sull’Osservatore Romano, lo scorso 25 gennaio, al Quirinale, Anna ha tenuto un bellissimo discorso in occasione del Giorno della Memoria. Perché il suo pensiero abbraccia la vicenda ebraica dalla storia antica a quella moderna, dell’Europa e dell’Italia”. Daniela Modonesi Leggi |
|
la testimonianza Pisa, giornata indimenticabile  Pisa,
piccola Comunità che subisce anch’essa il destino di assottigliarsi
sempre più qualche giorno fa invece ha brillato di luce propria,
festeggiando un Bat Mitzvah. Pisa,
piccola Comunità che subisce anch’essa il destino di assottigliarsi
sempre più qualche giorno fa invece ha brillato di luce propria,
festeggiando un Bat Mitzvah.La cronaca: una ottantina di partecipanti, le panche tutte occupate, il Coro Ventura diretto dal Maestro Paolo Filidei, avuto in prestito dalla Comunità vicina di Livorno e tanta, tanta emozione. Paola Samaia Leggi |
|
L'iniziativa ucei Ebrei nel mondo islamico, un bando rivolto all'università Nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantenario dell’arrivo degli ebrei di origine libica in Italia, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane attraverso l’Assessorato alla Cultura bandisce un concorso per l’assegnazione di tre premi per un biglietto di viaggio in Israele dell’importo massimo di 500 euro ad personam per la realizzazione di una tesi di laurea magistrale discussa negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 (sino alla sessione di giugno 2018) che affronti un aspetto della memoria e della storia delle comunità ebraiche nel mondo arabo e islamico nel Novecento. Leggi |
|
qui palermo - l'iniziativa Un albero per i magistrati uccisi "Testimone del bene che vince"  Anche
il Keren Kayemeth Le Israel, con il suo presidente Sergio
Castelbolognesi, e la rappresentanza diplomatica di Israele in Italia,
con la sua viceambasciatrice Ofra Farhi, al convegno “Ritratti del
coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati” svoltosi nella Sala
Mattarella del Palazzo dei Normanni a Palermo in ricordo di 27
magistrati assassinati. Evento nel corso del quale sono intervenuti
diversi giuristi di fama e al termine del quale, nel Comune di Ciminna,
è stata piantumata una quercia ed è stato posato un monumento donato
dall’Arma dei Carabinieri. Anche
il Keren Kayemeth Le Israel, con il suo presidente Sergio
Castelbolognesi, e la rappresentanza diplomatica di Israele in Italia,
con la sua viceambasciatrice Ofra Farhi, al convegno “Ritratti del
coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati” svoltosi nella Sala
Mattarella del Palazzo dei Normanni a Palermo in ricordo di 27
magistrati assassinati. Evento nel corso del quale sono intervenuti
diversi giuristi di fama e al termine del quale, nel Comune di Ciminna,
è stata piantumata una quercia ed è stato posato un monumento donato
dall’Arma dei Carabinieri.Leggi |

|







Pagine Ebraiche 24, l'Unione Informa e Bokertov sono pubblicazioni edite dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L'UCEI sviluppa mezzi di comunicazione che incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche. Gli articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili. Gli utenti che fossero interessati a offrire un proprio contributo possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it Avete ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio "cancella" o "modifica". © UCEI - Tutti i diritti riservati - I testi possono essere riprodotti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Direzione. l'Unione informa - notiziario quotidiano dell'ebraismo italiano - Reg. Tribunale di Roma 199/2009 - direttore responsabile: Guido Vitale.





