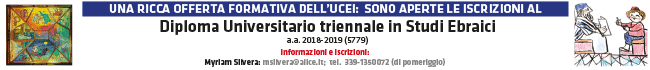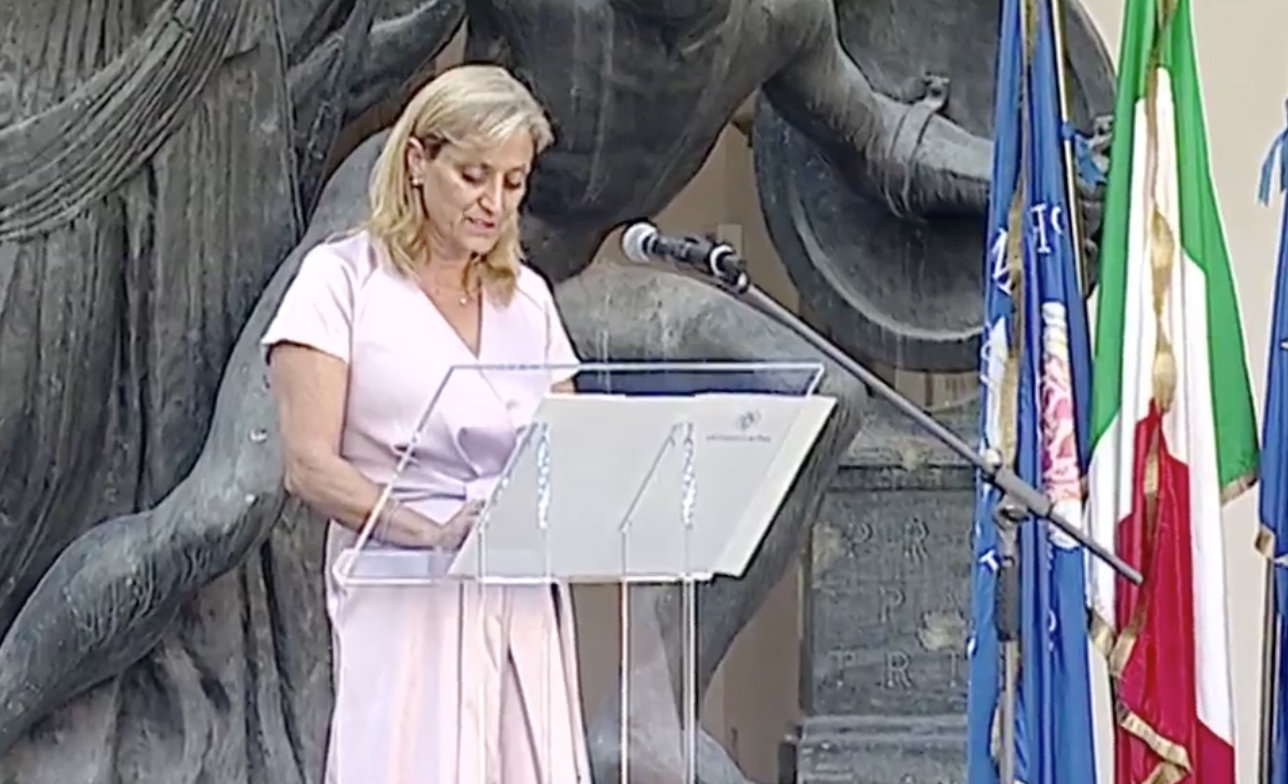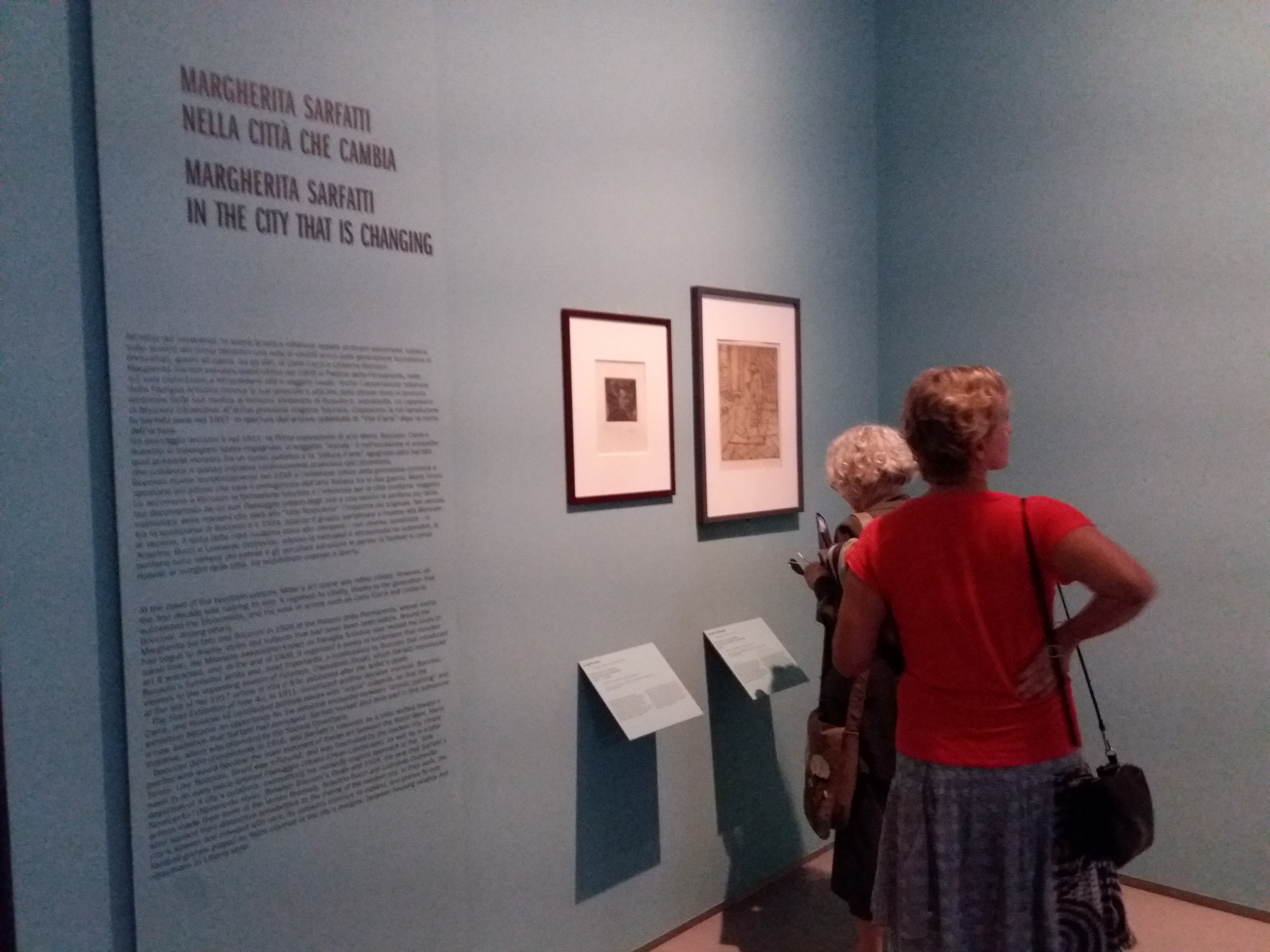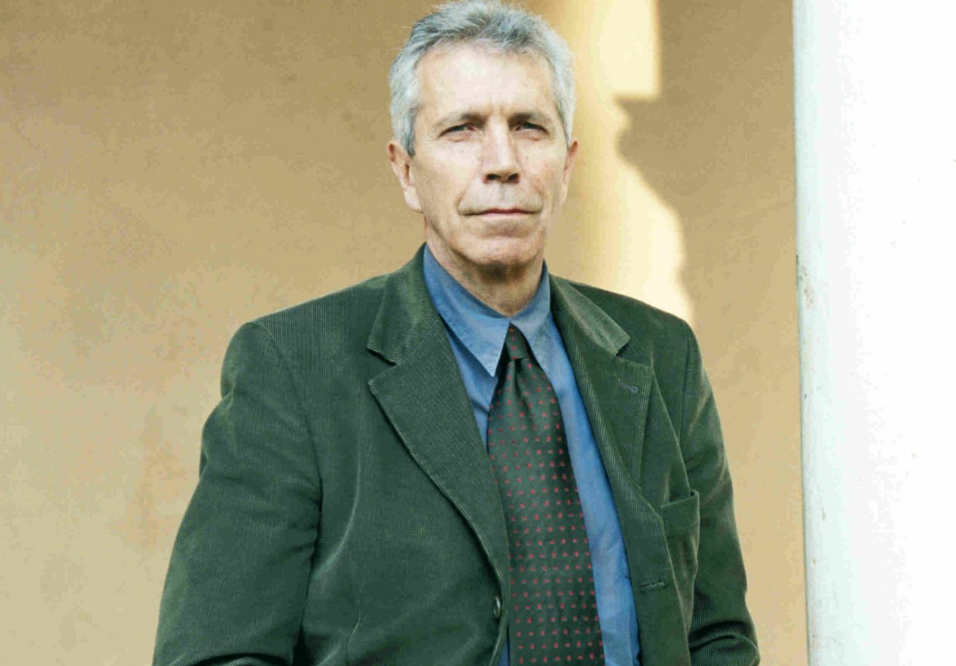Elia Richetti,
rabbino
|
La Torah dice: “Porgete orecchio, cieli”. Da
questa espressione il Rebbe di Kotzk ricavava che ai richiami della
Torà dobbiamo prestare un ascolto “celeste”. In che senso?
Parliamo spesso di “timore del Cielo”; non sarebbe meglio parlare di
“timore di D.o”?
|
| |
Leggi
|
 Giorgio Berruto Giorgio Berruto
|
Agrigento, Matera, Ferrara, oggi Torino
(presso l’Archivio di Stato fino al 14 ottobre), poi Milano. Sono le
tappe dell’itinerario italiano della mostra “Entire Life in a Package”,
personale dell’artista israeliana Orna Ben Ami. Le opere di Orna sono
composte da ferro saldato su scatti fotografici che riprendono chi
lascia una casa e va via, migra: il materiale duro per definizione e
l’attualità in presa diretta. In questo modo, sottolinea il curatore
Ermanno Tedeschi, “pone in rilievo un elemento, una valigia o una
bambola che richiamano alla forza e alla crudezza della fuga dal
proprio paese e all’aspettativa per una nuova vita”.
|
| |
Leggi
|
 |
Le scuse dell’Accademia
|
Nel pomeriggio gli occhi di molti puntati su
Pisa, dove è in programma la “cerimonia del ricordo e delle scuse” nel
corso della quale l’intera accademia italiana ricorderà la cacciata di
docenti e studenti ebrei dalle aule con l’entrata in vigore delle Leggi
razziste.
“I nostri colleghi di allora obbedirono per fede politica, convinzione,
quieto vivere, convenienza, viltà. Fu il culmine di un percorso che
aveva visto la loro adesione plebiscitaria al Giuramento di fedeltà al
fascismo del 1931” osserva il rettore dell’Università pisana Paolo
Mancarella in una intervista con La Nazione. “Anche il Manifesto degli
scienziati razzisti del ’38, dettato da Mussolini – aggiunge il rettore
– fu firmato da alcuni docenti universitari. Per quelli espulsi non ci
fu nessuna indignazione da parte dei colleghi. Come pure, dopo la
Liberazione, docenti insigni furono reinsediati nelle cattedre da cui
erano stati espulsi, ma solo affiancando e subordinandosi ai loro
‘successori’. Il nostro mondo ha quindi molte gravi colpe e conferma
che le tragedie collettive si nutrono anche delle miserie e degli
egoismi dei singoli”. Scrive Paolo Ermini, direttore del Corriere
Fiorentino, in un editoriale: “La cerimonia sarà intensa. Ma
ottant’anni sono tanti, troppi. E chi prenderà la parola a Pisa dovrà
evitare toni ritualistici per fare rivivere con emozione quella
tragedia e per parlare e farsi capire dai più giovani, sollecitando i
loro scampoli di Memoria in un Paese che sembra conservarne pochissima.
In occasione della cerimonia Piergiorgio Odifreddi celebra, sul Fatto
Quotidiano, la figura del matematico ebreo Vito Volterra. “Nel 1931 –
scrive – il regime impose ai professori universitari un giuramento di
fedeltà: Volterra fu uno dei 12 su 1250 (un centinaio dei quali ebrei)
che rifiutarono di farlo, e perse la cattedra. La storia si ripeté nel
1934 per le accademie: Volterra fu uno dei 10 che non giurarono, e
decadde da tutte le accademie di cui era membro, compresi i Lincei”.
Su 7 del Corriere protagonista dell’intervista del mese è Helena
Janeczek, vincitrice dell’ultimo Premio Strega con il libro La ragazza
con la Leica. Alla domanda “Cosa ti hanno passato i tuoi genitori?” la
scrittrice risponde: “Avrebbero voluto proteggermi, non farmi arrivare
nulla di ciò che hanno vissuto loro, scampati alla Shoah. Ma con un
amore immenso, a volte schiacciante, mi hanno trasmesso il senso
imminente del pericolo”.
Su Repubblica un intervento di Luca Bottura sull’insofferenza che
alcuni intellettuali di destra, in primis Marcello Veneziani,
proverebbero per il recente successo di libri centrati sul tema della
Memoria. Scrive Bottura: “Ai tempi in cui sostava, debitamente
lottizzato, al settimo piano di viale Mazzini, Veneziani si sarebbe
vergognato di scrivere una cosa del genere. L’opportunità e un contesto
sociale più vigile lo sconsigliavano. Se oggi se la sente, se vuole
davvero comunicarci che ‘che due palle `sta Shoah’ è un concetto
accettabile, è solo colpa nostra che gliel’abbiamo permesso”.
|
| |
Leggi
|
|
|
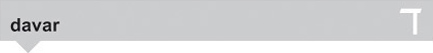
pisa,
la cerimonia del ricordo e delle scuse
1938-2018,
l'Università italiana
e il gesto per risarcire la storia
 “Spettava a noi risarcire? Non so dirlo. C’è una cosa di cui ho
certezza: noi siamo quelli venuti qui dopo coloro che, accecati, fecero
del male alle vostre madri e ai vostri padri, ed è per questo che
sentivamo di dovervi questo riconoscimento”.
“Spettava a noi risarcire? Non so dirlo. C’è una cosa di cui ho
certezza: noi siamo quelli venuti qui dopo coloro che, accecati, fecero
del male alle vostre madri e ai vostri padri, ed è per questo che
sentivamo di dovervi questo riconoscimento”.
Un lungo applauso saluta le parole del rettore dell’Università di Pisa
Paolo Mancarella, che col suo intervento ha aperto la solenne
“Cerimonia del ricordo e delle scuse” organizzata dall’ateneo pisano in
collaborazione con la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore
Sant’Anna, la Scuola IMT Alti studi Lucca, affiancate in questo impegno
da tutte le Università italiane, con l’apprezzamento del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’ottantesimo
anniversario dalla promulgazione delle Leggi razziste da parte del
fascismo.
 Un
momento alto di ricordo, riflessione e presa di coscienza sia storica
che morale sull’infame cacciata di studenti e docenti ebrei dalle aule
che guarda non soltanto al passato, alle sofferenze che furono inflitte
ai singoli e all’intera collettività ebraica, ma anche e
necessariamente al futuro, all’idea di società da costruire e
difendere, condiviso sul palco del Cortile del Palazzo della Sapienza
che ha visto riuniti rettori da tutto il paese, rappresentanti di
istituzioni e leader ebraici, assieme alla presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni. Un
momento alto di ricordo, riflessione e presa di coscienza sia storica
che morale sull’infame cacciata di studenti e docenti ebrei dalle aule
che guarda non soltanto al passato, alle sofferenze che furono inflitte
ai singoli e all’intera collettività ebraica, ma anche e
necessariamente al futuro, all’idea di società da costruire e
difendere, condiviso sul palco del Cortile del Palazzo della Sapienza
che ha visto riuniti rettori da tutto il paese, rappresentanti di
istituzioni e leader ebraici, assieme alla presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni.
“Nelle parole pronunciate – ha osservato la Presidente UCEI, raggiunta
poi dal rettore per un simbolico abbraccio – ricerchiamo la
consapevolezza che il chiedere scusa non ha un l’ingenuo fine
riparatorio di quanto è svanito e cancellato e di quanto è stato
orrendamente vissuto, ma il riconoscimento della distorta ragione,
dell’indomita acquiescenza, della penetrante indifferenza,
dell’aggravante che pesa sulla comunità dei dotti e degli scienziati
per aver ideato quel manifesto e sottoscritte quelle idee, assieme ad
una l’assunzione di responsabilità per il futuro e per le generazioni
future di accademici e scienziati”.
 Una
targa a perenne memoria di quanto accaduto oggi è stata svelata al
termine della cerimonia da Mancarella e Di Segni, come messaggio alle
nuove generazioni e ai frequentatori dell’ateneo. Una
targa a perenne memoria di quanto accaduto oggi è stata svelata al
termine della cerimonia da Mancarella e Di Segni, come messaggio alle
nuove generazioni e ai frequentatori dell’ateneo.
A riconoscere il particolare significato della cerimonia le parole
della senatrice a vita Liliana Segre, intervenuta con un video
messaggio.
Leggi
|
pisa,
la cerimonia - la presidente ucei
Le
scuse dell'Accademia italiana
"Un messaggio da tener vivo”
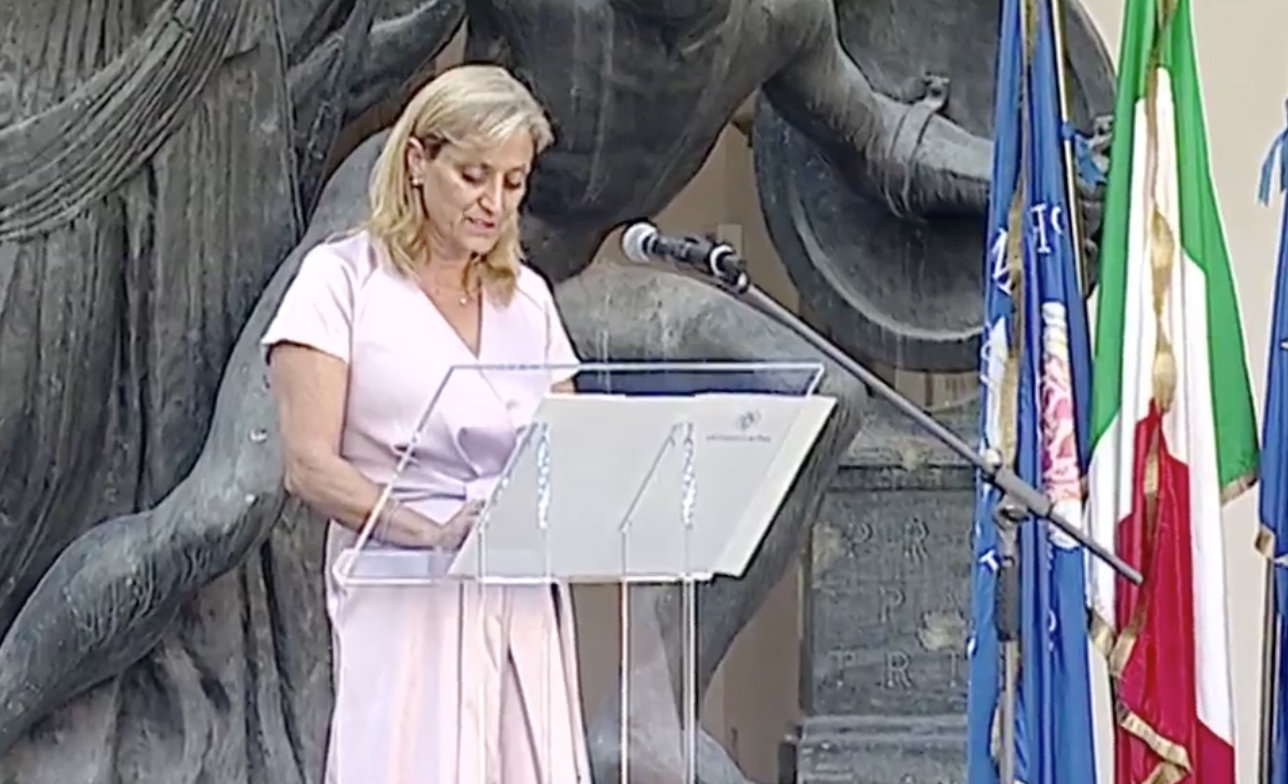 Magnifico Rettore Mancarella, Illustre Presidente Crui Manfredi,
Ambasciatore Sachs, Rav Arbib, Autorità, illustri ospiti
Magnifico Rettore Mancarella, Illustre Presidente Crui Manfredi,
Ambasciatore Sachs, Rav Arbib, Autorità, illustri ospiti
Oggi, in questo Ateneo, dinanzi a noi – rappresentanti delle comunità
ebraiche in Italia – con emozione e solennità sono state pronunciate
parole e riflessioni importanti che abbiamo ascoltato con il cuore e
con la mente.
È la parola “legge” con il suo perché sociale, la sua forza vincolante
e la sua funzione essenziale di tutela e di regolazione dello spazio
relazionale, al centro della nostra riflessione. Com’è potuto accadere
nel ’38 che un insieme di provvedimenti voluti e votati da esseri umani
– a ciò delegati in rappresentanza del popolo – siano divenuti
strumento che normalizzava un antico odio, ordinandone l’attuazione in
ogni ambito dell’essere e per ogni avere? Perché dire no alla legge era
più giusto che dire sì e sulla base di quale principio più alto
invocare giustizia?
Appena ieri è terminata la festività del Kippur, giorno dedicato
all’introspezione e all’espiazione, riflettendo sulle nostre colpe e
riaffermando propositi per l’anno a venire, riunendosi e recitando
preghiere tramandate da secoli di padre in figlio. Abbiamo più volte
nel corso della giornata ribadito – sia al singolare che al plurale –
sia rivolgendoci a D-o sia al prossimo – che non siamo stati capaci di
rispettare la legge, di riconoscere verità, di respingere maldicenza e
superbia. I nostri torti nascono dalla inosservanza delle norme
(divine) e non dall’obbedienza, ed invero il tema del perdono è
complesso, intreccia rigore, libero arbitrio, coerenza, aspettative e
speranze di cambiamenti.
La nostra generazione ha ricevuto da chi ha vissuto l’esclusione –
allora studenti o docenti – un messaggio ed una missiva che non ha
carattere di rivendicazione o restituzione di odio ma di vigilanza e
rispetto della libertà e del riconoscimento dell’altro, “altro” che è
“noi” società italiana, e di partecipazione alla ricostruzione e allo
sviluppo culturale ed accademico del paese e dell’Europa.
Noemi Di Segni,
Presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Leggi
|
pisa,
la cerimonia - il rettore dell'Università
Le
scuse dell'Accademia italiana
“Riconoscimento doveroso”
 Ci
sono giorni in cui è bene che il presente incontri il passato, oggi
abbiamo voluto che fosse uno di questi. Ci
sono giorni in cui è bene che il presente incontri il passato, oggi
abbiamo voluto che fosse uno di questi.
Qui, molti anni fa, sono avvenute cose che non sarebbero mai dovute
accadere. E noi vogliamo ricordarlo. Ci sono vite che, a partire da
questo luogo, sono state sospese, stravolte, distrutte. Diremo di loro
e di quel che accadde. Anche altrove, anche ad altri, anche prima,
anche dopo, con la speranza che questo non succeda mai più.
Nel 1938 il fascismo varò le leggi di persecuzione degli ebrei, e la
burocrazia statale, obbediente, agì con sorprendente efficienza. Con un
formulario dettagliato – albero genealogico, parentele, indirizzo,
proprietà, conto corrente – si procedette al “censimento” dei 47 mila
italiani ebrei e degli oltre 10 mila stranieri ebrei residenti in
Italia. Gli elenchi vennero tenuti aggiornati, cosicché, cinque anni
dopo, nel 1943, gli occupanti nazisti, con l’ausilio zelante dei
funzionari di Salò, poterono andare a colpo sicuro, deportarne più di
8.000 e ucciderne 7.172.
Settemila-cento-settantadue esseri umani.
Fu a due passi da noi, nella tenuta di San Rossore, – tradizionale
residenza estiva di Casa Savoia – che, ottant’anni fa, Vittorio
Emanuele III firmò il primo provvedimento antisemita voluto dal regime
fascista: il regio decreto legge n. 1390. Si trattava di sette brevi
articoli.
Usando la formula “sospensione del servizio” si stabiliva che – assieme
a studenti, presidi, insegnanti, di tutte le “scuole del regno” –
fossero espulsi dalle università: professori, assistenti, aiuti e
liberi docenti. Si precluse, inoltre, agli studenti ebrei di iscriversi
per quello e per i successivi sei anni.
I “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”
colpivano il settore che più di ogni altro rende un paese libero:
quello della formazione, dell’educazione e della ricerca.
La politica antiebraica perseguita dal fascismo nella scuola e
nell’università risultò persino più drastica delle misure adottate
dalla Germania hitleriana e dal governo della Francia di Vichy. Quel
decreto fu applicato, senza eccezioni, dai rettori di tutti gli atenei
italiani: i rettori obbedirono.
Paolo Mancarella, rettore
Università di Pisa
Leggi
|
milano
e rovereto, le mostre sulla sarfatti
Margherita,
signora Novecento
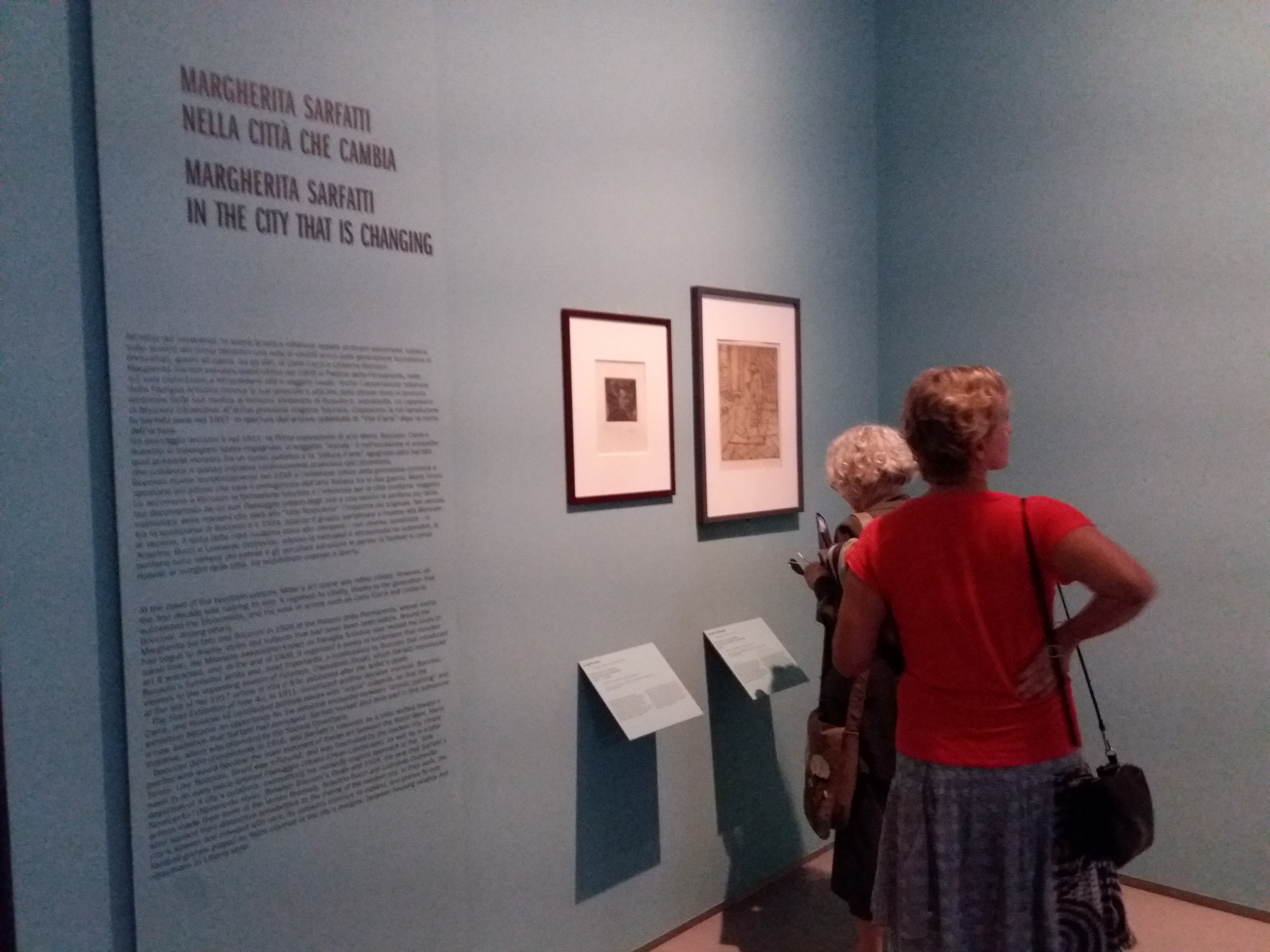 “Raccontare
Margherita Sarfatti con uno sguardo contemporaneo, con una visione
circolare, capace di cogliere le mille sfaccettature e
contraddizioni di una personalità articolata, potente e sensibile ma
anche fragile in un contesto storico segnato da un lato dal mito della
modernità, dal culto dell'innovazione e dall'altro dalle tragedie
delle leggi razziali e di due guerre mondiali, è un compito complesso
se si vuole cercare una lettura approfondita senza cadere in
stereotipi”. Le parole di Anna Maria Montaldo, direttrice del Museo del
Novecento di Milano spiegano con chiarezza la difficoltà e il lavoro
dietro alle due mostre dedicate alla figura di Margherita Sarfatti che
dal 21 settembre al 24 febbraio saranno ospitate proprio al Museo del
Novecento e al Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e
Rovereto. Presentate nelle scorse ore a Milano, le due mostra
raccontano un personaggio eclettico e originale come Margherita
Sarfatti, e le restituiscono il ruolo di protagonista del mondo
culturale dello scorso secolo, come raccontato da Ada Treves su Pagine
Ebraiche di settembre. “Raccontare
Margherita Sarfatti con uno sguardo contemporaneo, con una visione
circolare, capace di cogliere le mille sfaccettature e
contraddizioni di una personalità articolata, potente e sensibile ma
anche fragile in un contesto storico segnato da un lato dal mito della
modernità, dal culto dell'innovazione e dall'altro dalle tragedie
delle leggi razziali e di due guerre mondiali, è un compito complesso
se si vuole cercare una lettura approfondita senza cadere in
stereotipi”. Le parole di Anna Maria Montaldo, direttrice del Museo del
Novecento di Milano spiegano con chiarezza la difficoltà e il lavoro
dietro alle due mostre dedicate alla figura di Margherita Sarfatti che
dal 21 settembre al 24 febbraio saranno ospitate proprio al Museo del
Novecento e al Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e
Rovereto. Presentate nelle scorse ore a Milano, le due mostra
raccontano un personaggio eclettico e originale come Margherita
Sarfatti, e le restituiscono il ruolo di protagonista del mondo
culturale dello scorso secolo, come raccontato da Ada Treves su Pagine
Ebraiche di settembre.

"Raccontiamo
una straordinaria artefice d’arte e cultura e una stagione complessa
della nostra storia nazionale ed europea: un Novecento che ha prodotto
allo stesso tempo innovazioni straordinarie e pericolose regressioni
storiche". È così che il sindaco Giuseppe Sala presenta "Margherita
Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano" la mostra che aprirà il 21
settembre al Museo del Novecento, in parallelo con "Margherita
Sarfatti. Il Novecento Italiano nel mondo", che il giorno successivo
accoglierà i visitatori al Mart, il Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto. Due ritratti di una donna aperta e
libera, capace di dare slancio al nuovo in tanti e diversi campi
dell’arte, raccontata seguendo due direttrici: a Milano, il suo
rapporto con la città dove si trasferisce nel 1902, e la sua capacità
di internazionalizzare l’arte nazionale, e a Rovereto, dove la mostra
si concentra sulle mostre di Novecento Italiano che promosse
all’estero, a partire dal 1926, la connessione con le avanguardie
europee".
Ada Treves, Pagine
Ebraiche Settembre 2018
Leggi
|
Bilancio
Sociale 8 / Politica e valori
Rispetto
dei diritti, lotta attuale
 I
mesi alle spalle sono stati caratterizzati da un forte impegno pubblico
dell'Unione in difesa dei valori che sono patrimonio inalienabile di
una società progredita come quella italiana. E quindi rispetto della
dignità umana, delle diversità, della legalità. Si è chiesta la
Presidente UCEI Noemi Di Segni in occasione dell'80esimo anniversario
dalla pubblicazione della rivista fascista La difesa della razza:
"Quanto si è radicato nella cultura della nostra società, italiana ed
europea, il rispetto per il diritto alla vita, della dignità umana,
dell’uguaglianza degli esseri umani non solo dinanzi alla legge ma
anche dinanzi agli uomini? Alla luce di quanto viviamo oggi, con il
crescente manifestarsi di atti di intolleranza razziale, odio e
pericolosa radicalizzazione, purtroppo alimentati e legittimati anche
da esponenti delle istituzioni, questo percorso appare incompiuto e
ancor più faticoso". Una sfida che ha in Liliana Segre, la Testimone
della Shoah nominata in gennaio senatrice a vita dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, un punto di riferimento. I
mesi alle spalle sono stati caratterizzati da un forte impegno pubblico
dell'Unione in difesa dei valori che sono patrimonio inalienabile di
una società progredita come quella italiana. E quindi rispetto della
dignità umana, delle diversità, della legalità. Si è chiesta la
Presidente UCEI Noemi Di Segni in occasione dell'80esimo anniversario
dalla pubblicazione della rivista fascista La difesa della razza:
"Quanto si è radicato nella cultura della nostra società, italiana ed
europea, il rispetto per il diritto alla vita, della dignità umana,
dell’uguaglianza degli esseri umani non solo dinanzi alla legge ma
anche dinanzi agli uomini? Alla luce di quanto viviamo oggi, con il
crescente manifestarsi di atti di intolleranza razziale, odio e
pericolosa radicalizzazione, purtroppo alimentati e legittimati anche
da esponenti delle istituzioni, questo percorso appare incompiuto e
ancor più faticoso". Una sfida che ha in Liliana Segre, la Testimone
della Shoah nominata in gennaio senatrice a vita dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, un punto di riferimento.
Leggi
|

| Setirot
- Conti con il passato |
 Perché
credo profondamente che Kippur sia un giorno – o meglio un processo, un
percorso – assolutamente universale? Perché significa fare, davvero, i
conti con il proprio passato. Perché
credo profondamente che Kippur sia un giorno – o meglio un processo, un
percorso – assolutamente universale? Perché significa fare, davvero, i
conti con il proprio passato.
Stefano Jesurum, giornalista
Leggi
|
| In
ascolto - L'elegia di rav Kara |
 Siamo
giunti al termine del tempo scandito dalle selichot, i testi poetici di
supplica con cui si invocano la misericordia e il perdono e che mettono
al centro i tredici attributi della misericordia di Dio (Esodo 34,
6-7). Si tratta di componimenti dalla storia complessa, a cui hanno
contribuito i saggi di Babilonia, i talmudisti e i payyetanim (autori
di eleganti e raffinati poemi liturgici) più o meno celebri, tra cui
anche Yehudah Halevi e Shlomo Ibn Gabirol.
Siamo
giunti al termine del tempo scandito dalle selichot, i testi poetici di
supplica con cui si invocano la misericordia e il perdono e che mettono
al centro i tredici attributi della misericordia di Dio (Esodo 34,
6-7). Si tratta di componimenti dalla storia complessa, a cui hanno
contribuito i saggi di Babilonia, i talmudisti e i payyetanim (autori
di eleganti e raffinati poemi liturgici) più o meno celebri, tra cui
anche Yehudah Halevi e Shlomo Ibn Gabirol.
Tra questi vi è Avigdor Kara (XIV – XV sec.) rabbino, studioso di
Talmud, cabalista e poeta che “conosceva la dolcezza dei canti”, come
recita il suo epitaffio nel cimitero di Praga.
Maria Teresa Milano
Leggi
|
| Padri
e figli |
 "Possiate
essere meritevoli di vivere molti anni, voi figli e padri qui riuniti,
con gaudio ed esultanza, in quest'ora di chiusura delle preghiere. Dio
che sei temibile nelle Tue opere! Facci conseguire l'assoluzione in
quest'ora di chiusura delle preghiere", abbiamo cantato all'inizio di
Ne'ilà in chiusura di questo Yom HaKippurum. "Possiate
essere meritevoli di vivere molti anni, voi figli e padri qui riuniti,
con gaudio ed esultanza, in quest'ora di chiusura delle preghiere. Dio
che sei temibile nelle Tue opere! Facci conseguire l'assoluzione in
quest'ora di chiusura delle preghiere", abbiamo cantato all'inizio di
Ne'ilà in chiusura di questo Yom HaKippurum.
Sara Valentina Di Palma
Leggi
|
| Porta
Pia, simbolo di laicità |
 A
148 anni da quella breccia che liberò Roma aprendole la strada al
divenire capitale e che schiuse, finalmente, le porte del ghetto
romano, l'evento storico legato a Porta Pia , assurto a simbolo della
Laicità dello Stato (ancora lontana dall'essere pienamente realizzata
nonostante le previsioni costituzionali), è ben lungi dall'essere mera
rievocazione storica per "nostalgici". A
148 anni da quella breccia che liberò Roma aprendole la strada al
divenire capitale e che schiuse, finalmente, le porte del ghetto
romano, l'evento storico legato a Porta Pia , assurto a simbolo della
Laicità dello Stato (ancora lontana dall'essere pienamente realizzata
nonostante le previsioni costituzionali), è ben lungi dall'essere mera
rievocazione storica per "nostalgici".
Gadi Polacco
Leggi
|
|
|







 Giorgio Berruto
Giorgio Berruto
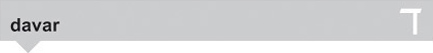
 In
luglio una lettera di minacce, con intimidazioni a sfondo antisemita,
era stata recapitata per posta nella sede dell’associazione culturale
Arte in Memoria. Destinataria la sua presidente Adachiara Zevi, che è
promotrice del progetto Memorie d’inciampo a Roma e della biennale di
arte contemporanea Arte in Memoria nella sinagoga di Ostia Antica. Da
quell’iniziativa è scaturita in risposta una petizione di solidarietà,
che ha raggiunto 700 firme.
In
luglio una lettera di minacce, con intimidazioni a sfondo antisemita,
era stata recapitata per posta nella sede dell’associazione culturale
Arte in Memoria. Destinataria la sua presidente Adachiara Zevi, che è
promotrice del progetto Memorie d’inciampo a Roma e della biennale di
arte contemporanea Arte in Memoria nella sinagoga di Ostia Antica. Da
quell’iniziativa è scaturita in risposta una petizione di solidarietà,
che ha raggiunto 700 firme.