


 |
 |
 |
 |
 Jonathan Sacks, rabbino Jonathan Sacks, rabbino |
| Il
nazionalismo è una questione di potere. Il patriottismo parla invece la
lingua dell'orgoglio. Possiamo essere patriottici senza essere
nazionalisti. |
 David
Bidussa, David
Bidussa,storico sociale delle idee |
| Abramo
finì la sua vita e morì in vecchiaia avanzata e si riunì alla sua
gente. Isacco e Ismaele, suoi figli, lo seppellirono nella grotta di
Machpelà…” (Gn, 25.8-9). Il futuro è possibile se nel passato si trova un atto condiviso che testimoni di una volontà. |
 |
| I Comuni e i nostalgici |
| No
a mafie e fascisti era lo slogan della manifestazione di ieri a Ostia,
dove un migliaio di persone hanno sfilato per rispondere al successo
elettorale dei neofascisti di CasaPound e alla violenza del clan degli
Spada. A sfilare al corteo, anche il sindaco di Roma Virginia Raggi che
però sceglie di non farlo con la fascia tricolore al collo
(Repubblica). La collega a Cinque stelle Giuliana Di Pillo proprio a
Ostia la prossima settimana sfiderà al ballottaggio Monica Picca di
Fratelli d’Italia per decidere chi guiderà la città dove i neofascisti
di CasaPound hanno ottenuto un preoccupante successo. E contro i
nostalgici intanto si mobilitano altri Comuni italiani, racconta
Repubblica, che parla di amministrazioni che “corrono ai ripari
mettendo i primi paletti: delibere ad hoc per vietare spazi a chi fa
del nostalgismo fascista la propria bandiera; modifiche ai regolamenti
per togliere agibilità a quei gruppi che predicano l’intolleranza verso
gli immigrati, le minoranze etniche, sessuali, religiose”. |
| Leggi |
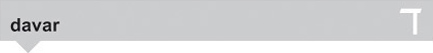
|
pagine ebraiche novembre 2017 - grandangolo Una sfida da raccogliere 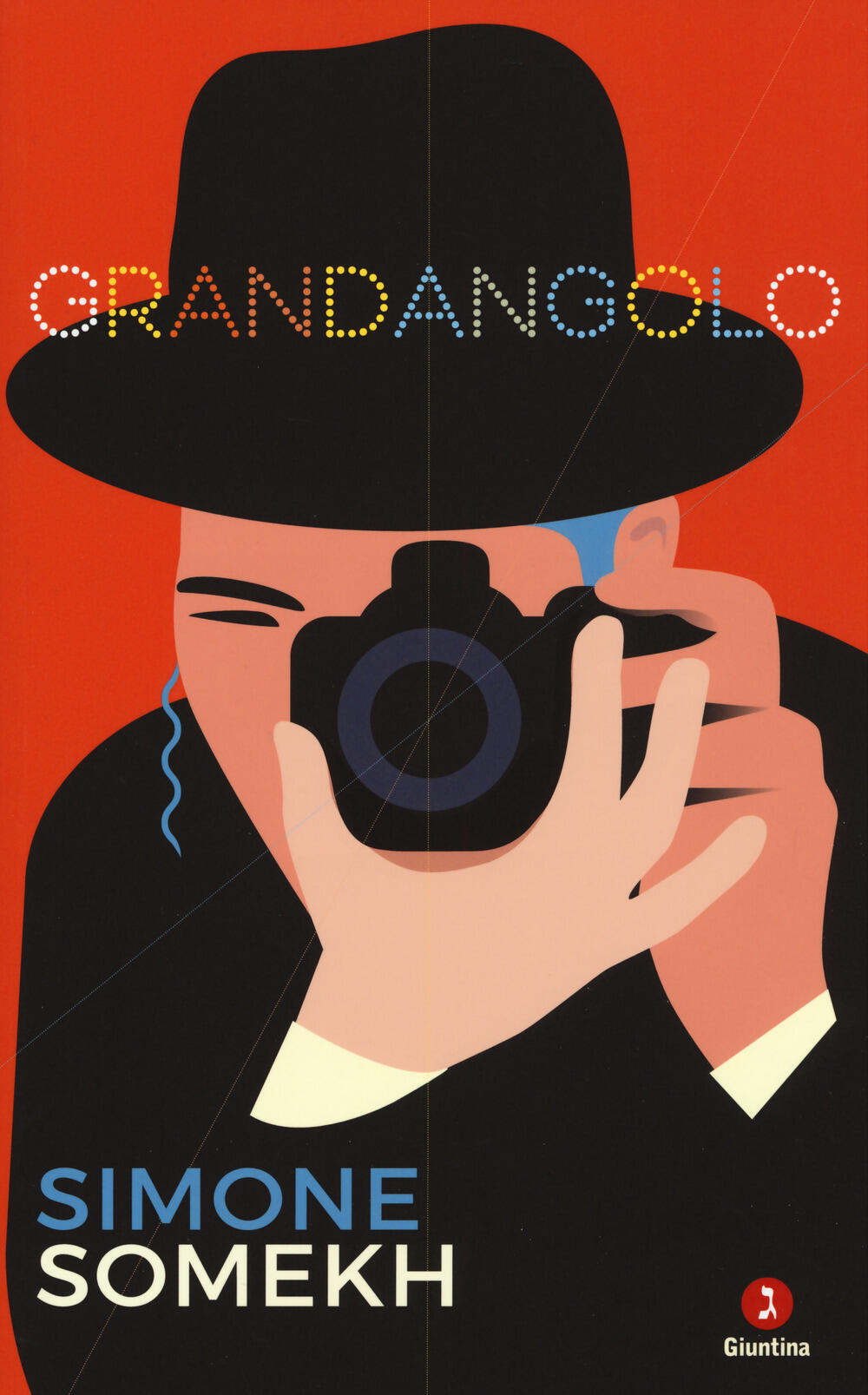 La
storia è quella di Ezra Kramer, un ragazzino che fa della sua vita una
lunga e sofferta avventura. O forse è la vita a fare di lui un
avventuriero: un po’ per scelta, un po’ per natura, un po’ per
curiosità, Ezra non si dà (e non ci dà) mai pace. Scappa, evade, poi
torna, si perde e si ritrova, crea e distrugge alla velocità della
luce; ma facciamo un po’ di ordine. Tutto ha inizio con un piccolo
regalo, una macchina fotografica, un innocuo giocattolo che presto
diventa oggetto del peccato, proprio come l’arma di un delitto. E se si
fosse trattato di un delitto, forse, il nostro protagonista non avrebbe
suscitato tanto scalpore. I suoi scatti presto diventano talmente noti
e temuti all’interno della comunità ebraica ultraortodossa di Brighton,
che l’espulsione dalla Yeshiva in cui studia non basta per placare gli
animi roventi. Ezra comincia così un’epopea che lo condurrà a New York,
lontano anni luce dalla bolla fatta di abiti rigorosamente neri e gonne
lunghe fino al pavimento in cui è cresciuto. E noi partiremo per questo
lungo viaggio insieme a lui, trascinati nel suo mondo audace e a tratti
trasgressivo, persi tra le pagine di Grandangolo e tra le riflessioni
del suo autore esordiente, Simone Somekh. Quasi come fosse un Asher Lev
dei giorni nostri, Ezra Kramer non riesce a dar freno alla sua passione
per la fotografia. “Mi chiedo dove abbiamo sbagliato”, si domanderà il
padre. “Dio ci sta punendo, me lo sento”, risponderà la madre in preda
alle lacrime. Eppure ci sarà chi lo definirà “Un ragazzo molto dotato”,
come la brillante zia Suzie, o chi gli dirà che “Sei la migliore
persona che io abbia mai conosciuto”, come l’inseparabile fratello
adottivo Carmi. Tutti i personaggi recitano la loro parte. I genitori
sono come quelli veri, non come quelli dei film. Gli amici e i colleghi
potremmo tranquillamente associarli a persone a noi vicine. Tutto è
folle e caotico nella mente dell’autore, ma nulla è surreale. Le gioie
comportano sempre dei piccoli dolori ed i successi si trascinano sempre
appresso infiniti fallimenti, proprio come nella realtà. Dopo ogni una
salita e, soprattutto, non esistono scelte giuste e scelte sbagliate.
Così, proprio quando tutto sembra andare storto, quando la luce in
fondo al tunnel tarda ad arrivare ed Ezra desidera morire piuttosto che
rassegnarsi alla vita ostile e nemica a cui è condannato, tutto cambia
e tutto si trasforma. Capitolo dopo capitolo, il lettore impara ad
uscire dalla propria comfort zone per navigare in acque torbide e mai
prevedibili. Bisogna solo fare attenzione a non annegare. La
storia è quella di Ezra Kramer, un ragazzino che fa della sua vita una
lunga e sofferta avventura. O forse è la vita a fare di lui un
avventuriero: un po’ per scelta, un po’ per natura, un po’ per
curiosità, Ezra non si dà (e non ci dà) mai pace. Scappa, evade, poi
torna, si perde e si ritrova, crea e distrugge alla velocità della
luce; ma facciamo un po’ di ordine. Tutto ha inizio con un piccolo
regalo, una macchina fotografica, un innocuo giocattolo che presto
diventa oggetto del peccato, proprio come l’arma di un delitto. E se si
fosse trattato di un delitto, forse, il nostro protagonista non avrebbe
suscitato tanto scalpore. I suoi scatti presto diventano talmente noti
e temuti all’interno della comunità ebraica ultraortodossa di Brighton,
che l’espulsione dalla Yeshiva in cui studia non basta per placare gli
animi roventi. Ezra comincia così un’epopea che lo condurrà a New York,
lontano anni luce dalla bolla fatta di abiti rigorosamente neri e gonne
lunghe fino al pavimento in cui è cresciuto. E noi partiremo per questo
lungo viaggio insieme a lui, trascinati nel suo mondo audace e a tratti
trasgressivo, persi tra le pagine di Grandangolo e tra le riflessioni
del suo autore esordiente, Simone Somekh. Quasi come fosse un Asher Lev
dei giorni nostri, Ezra Kramer non riesce a dar freno alla sua passione
per la fotografia. “Mi chiedo dove abbiamo sbagliato”, si domanderà il
padre. “Dio ci sta punendo, me lo sento”, risponderà la madre in preda
alle lacrime. Eppure ci sarà chi lo definirà “Un ragazzo molto dotato”,
come la brillante zia Suzie, o chi gli dirà che “Sei la migliore
persona che io abbia mai conosciuto”, come l’inseparabile fratello
adottivo Carmi. Tutti i personaggi recitano la loro parte. I genitori
sono come quelli veri, non come quelli dei film. Gli amici e i colleghi
potremmo tranquillamente associarli a persone a noi vicine. Tutto è
folle e caotico nella mente dell’autore, ma nulla è surreale. Le gioie
comportano sempre dei piccoli dolori ed i successi si trascinano sempre
appresso infiniti fallimenti, proprio come nella realtà. Dopo ogni una
salita e, soprattutto, non esistono scelte giuste e scelte sbagliate.
Così, proprio quando tutto sembra andare storto, quando la luce in
fondo al tunnel tarda ad arrivare ed Ezra desidera morire piuttosto che
rassegnarsi alla vita ostile e nemica a cui è condannato, tutto cambia
e tutto si trasforma. Capitolo dopo capitolo, il lettore impara ad
uscire dalla propria comfort zone per navigare in acque torbide e mai
prevedibili. Bisogna solo fare attenzione a non annegare.La vita di Ezra, tuttavia, è di relativa importanza se si considera il contesto, così attuale e complesso, e i temi trattati all’interno della trama. Non aspettiamoci giri di parole, perché Grandangolo non ne ha. Con un notevole strike, Somekh riesce a sfatare tabù con grande maestria e a parlare di omosessualità, fanatismo religioso, libertà di stampa e autolesionismo con disinvoltura e grande lucidità; specialmente se consideriamo la sua giovane età. Ed ecco il segreto: Grandangolo non è un libro che parla di giovani, bensì è un libro che parla da giovani. La differenza è sottile, lo so, ma c’è, esiste, ed è essenziale per capire l’opera. Per intenderci, dunque, Grandangolo non è un libro che parla di New York, come chi sognerebbe la Grande Mela dal lato opposto del grande schermo, ma è un libro che riemerge dal subconscio di chi la città l’ha vissuta sulla propria pelle. Il dialogo invisibile che intercorre tra l’autore ed il protagonista, è ciò che rende la trama credibile ai nostri occhi. Grandangolo è un libro ebraico senza avere la pretesa di esserlo, e se non per i suoi contenuti, per la sua instancabile ricerca di verità. Emozionante, ambizioso e appassionante, ci permette di affacciarci ad un mondo meno distante a noi di quanto possiamo pensare. È lì, dietro l’angolo, un mondo che aspetta di essere esplorato, criticato e poi abbracciato. Simone Somekh e il suo talento ci stanno lanciando una provocazione, nonché un’interessante sfida. Sta a noi ora raccoglierla. Sta a noi guardare oltre il grandangolo della vita. Io l’ho fatto, e gliene sono grato. David Zebuloni |
|
pagine ebraiche novembre 2017 - grandangolo
Le molte facce di un'identità 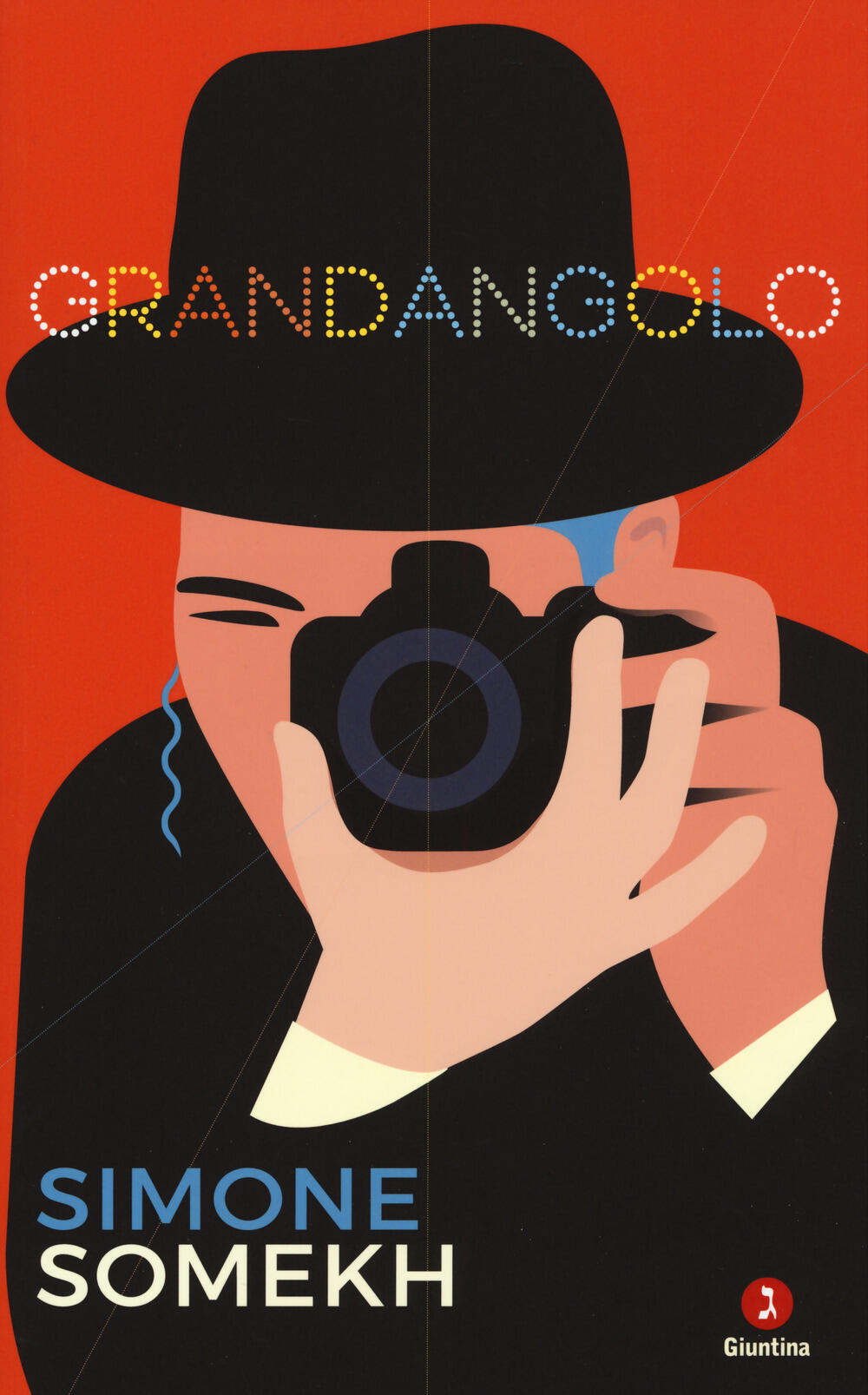 Il
ventunesimo secolo appare sempre più come l’era dei mondi che si
intrecciano e delle identità che si sovrappongono. Complici le nuove
tecnologie che hanno Il
ventunesimo secolo appare sempre più come l’era dei mondi che si
intrecciano e delle identità che si sovrappongono. Complici le nuove
tecnologie che hannoreso più rapidi ed economici viaggi e comunicazioni, noi che siamo stati bambini negli anni Novanta, adolescenti in quelli Duemila e ci costruiamo una vita in questi inaspettatamente complicati Dieci siamo abituati a spaziare tra paesi diversi e domande su chi vogliamo essere e cosa diventare, magari saltando su qualche aereo per capirlo. Così fa anche Ezra, il protagonista di Grandangolo, che parte però da una prospettiva diversa, quella di una comunità ebraica haredì (termine che letteralmente significa “timorato” ma viene comunemente tradotta in italiano come “ultraortodosso”) nei sobborghi di Boston. Così il primo mezzo di trasporto alla ricerca della propria identità diventa la metropolitana che porta il giovane a un liceo ebraico “moderno” in città, e poi il bus verso la New York in cui qualsiasi ragazzo con la passione per la fotografia come Ezra sogna di realizzarsi. Ben presto arriveranno i voli intercontinentali, per andare avanti, ma allo stesso tempo tornare indietro, e scoprire che c’è da apprezzare anche l’identità che si credeva di aver lasciato alle spalle. Nelle pagine scritte da Simone Somekh – un amico e un collega pure abituato a prendere aerei e a fare domande – si affacciano tanti temi importanti che animano oggi il dibattito delle comunità ebraiche a livello mondiale. Il rapporto tra ebraismo haredì, Modern Orthodox, conservative, reform. Il confine tra libere scelte di vita e scelte dettate dalle regole della propria comunità di appartenenza, o dalla pressione dei genitori. L’approccio della religione ebraica alle persone LGBT, ai loro diritti e all’accoglienza. Davanti all’obiettivo della macchina fotografica di Ezra sfilano però anche interrogativi dedicati a tutti i Millenial: cosa bisogna essere disposti a sacrificare per fare carriera – e cosa no; l’importanza dell’amicizia, il significato del contatto fisico, la capacità di dare e di ricevere alle persone importanti della propria vita, la necessità di lottare per realizzare i propri sogni anche contro ogni aspettativa. Un tema su tutti penso valga la pena di approfondire, quello della rabbia. Ezra ha avuto un’infanzia e un’adolescenza difficile, ed è arrabbiato. Forse ha ragione a esserlo, ma l’ira che si porta dietro per tutto il libro, riemerge e prende il controllo al primo accenno di contraddizione o di ostacolo, e diventa un limite e una debolezza. Ecco forse lui e un po’ tutti noi, giovani e meno giovani, oggi abbiamo accesso troppo facilmente a sentimenti di rabbia, ogniqualvolta la vita si rivela più difficile di quanto le pubblicità e i profili altrui sui social network, ci danno l’illusione che dovrebbe essere. Dimenticandoci di quegli aerei, di quelle tecnologie, di quelle possibilità che abbiamo di inseguire le risposte alle nostre domande che forse diamo troppo per scontate, che un tempo erano impensabili. Forse proprio per questo in passato era meno diffusa la frustrazione che sembra aver avvolto il mondo con conseguenze terribili, politiche, sociali, spirituali. Ecco lo spunto che su tutti mi porto via da Grandangolo: la vita può essere dura, ma risolvendo i risentimenti si riesce a fare molto, per noi stessi e per gli altri. E poi per ritrovare l’entusiasmo, possiamo andare in giro per la movida soleggiata di Tel Aviv, sorseggiando una spremuta delle famose arance di Jaffa. Così fa Ezra, e in fondo non è affatto una cattiva idea… Rossella Tercatin |
|
pagine ebraiche novembre 2017 - grandangolo
Provaci ancora, Sim 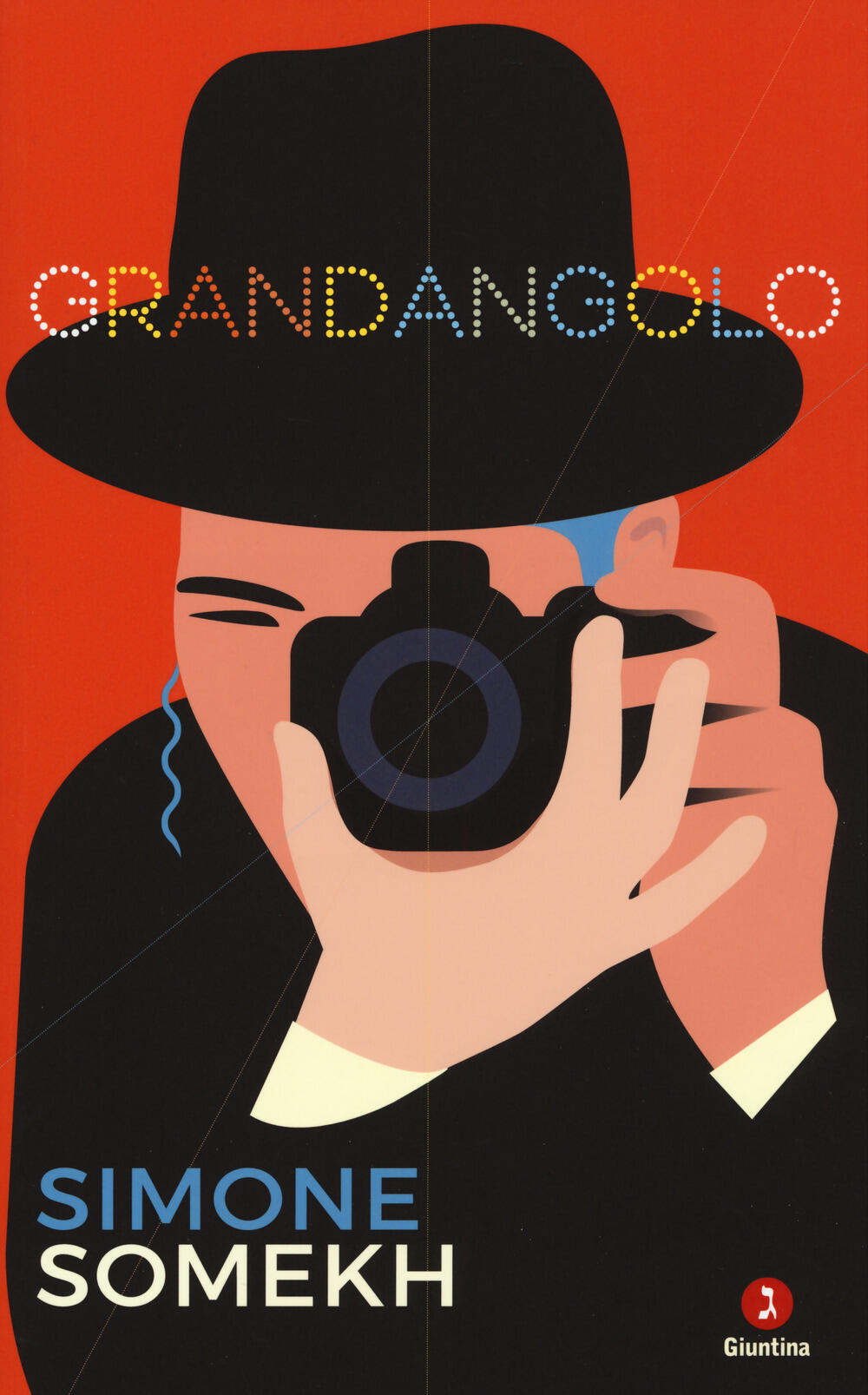 Con
Grandangolo, la sua prima opera letteraria, Simone Somekh firma un
libro importante e necessario. Il suo dare voce a una generazione
disperatamente silente e incapace di esprimersi, la sua abilità di
riaprire un dialogo fra le generazioni all’interno del mondo di casa
nostra, merita non solo una lettura attenta, ma anche una riflessione
seria. Una lettura da consigliare a tutti e in particolare ai tanti che
nell’ebraismo italiano si cullano in un limbo di incerte fantasie
identitarie e confuse consuetudini, evitando spesso di domandarsi su
quale terreno stiano effettivamente appoggiati i loro piedi e quali
problemi reali devono affrontare le giovani generazioni. Dal punto di
vista della mia generazione, che è ormai quella dei padri, più che dei
figli, questo libro, certo importante e necessario, non è tuttavia
parso convincente. L’atto d’accusa da parte di una generazione cui ci
siamo sforzati di offrire tutto il meglio (la sicurezza, la qualità
della vita, i viaggi, gli studi migliori), ma a cui abbiamo dimenticato
di dire che non c’è amore che non possa dire il suo nome, tiene, e mi
pare salutare. Con
Grandangolo, la sua prima opera letteraria, Simone Somekh firma un
libro importante e necessario. Il suo dare voce a una generazione
disperatamente silente e incapace di esprimersi, la sua abilità di
riaprire un dialogo fra le generazioni all’interno del mondo di casa
nostra, merita non solo una lettura attenta, ma anche una riflessione
seria. Una lettura da consigliare a tutti e in particolare ai tanti che
nell’ebraismo italiano si cullano in un limbo di incerte fantasie
identitarie e confuse consuetudini, evitando spesso di domandarsi su
quale terreno stiano effettivamente appoggiati i loro piedi e quali
problemi reali devono affrontare le giovani generazioni. Dal punto di
vista della mia generazione, che è ormai quella dei padri, più che dei
figli, questo libro, certo importante e necessario, non è tuttavia
parso convincente. L’atto d’accusa da parte di una generazione cui ci
siamo sforzati di offrire tutto il meglio (la sicurezza, la qualità
della vita, i viaggi, gli studi migliori), ma a cui abbiamo dimenticato
di dire che non c’è amore che non possa dire il suo nome, tiene, e mi
pare salutare.La prova narrativa no. Perché la letteratura ricalca molte delle leggi della vita. L’ossessiva ripetizione di stereotipi importati dall’armamentario della cultura dominante (a cominciare dalla continua ripetizione del termine “ultraortodosso”) non aiuta a far uscire dall’ombra l’umanità dei vari personaggi. Tutti sbagliamo, o esageriamo, o ci dimentichiamo di nutrire di passione e compassione i nostri ideali. E gli ebrei ortodossi americani evocati in Grandangolo certamente possono soffrire anche di questo. Ma a nessuno, nella vita e nella letteratura, dovrebbe essere negata quella complessità e quella contraddittoria umanità che caratterizza la vita ebraica di tutti. In un mondo di stereotipi se i protagonisti si riducono a ombre sbiadite anche il confronto necessario fra le generazioni e fra le diverse componenti della società ebraica corre il rischio di perdere il suo slancio e di smarrirsi nel frusciare dei luoghi comuni di carta patinata. Guido Vitale |
|
qui roma - l'evento Gusto Kosher, il Negev in tavola  Pubblico
folto e partecipe a Gusto Kosher, appuntamento ormai tradizionale
dedicato all’enogastronomia ebraica con la regia di Lebonton catering e
il sostegno di molteplici realtà e istituzioni. Tanti gli appuntamenti
che in queste ore, in particolare al Palazzo della Cultura ma non solo,
declinano la sfida di portare gli intensi sapori del deserto a tavola.
“BaMidbar. Il Negev delle meraviglie” è il titolo di questa edizione,
con ospiti d’onore alcuni protagonisti israeliani della cucina di
qualità. Un viaggio che è anche una sorpresa. “Da un lato è ancora
possibile mangiare, sotto le tende dei beduini, cibi dal sapore antico
che hanno saputo catturare e mettere nel piatto il gusto del deserto.
Dall’altro le produzioni agri-tech nell’Aravà permettono di assaporare
delizie che per il deserto sembrerebbero impensabili” spiegano infatti
gli organizzatori, gli chef Giovanni e Daniele Terracina e Dario
Bascetta Greco. Pubblico
folto e partecipe a Gusto Kosher, appuntamento ormai tradizionale
dedicato all’enogastronomia ebraica con la regia di Lebonton catering e
il sostegno di molteplici realtà e istituzioni. Tanti gli appuntamenti
che in queste ore, in particolare al Palazzo della Cultura ma non solo,
declinano la sfida di portare gli intensi sapori del deserto a tavola.
“BaMidbar. Il Negev delle meraviglie” è il titolo di questa edizione,
con ospiti d’onore alcuni protagonisti israeliani della cucina di
qualità. Un viaggio che è anche una sorpresa. “Da un lato è ancora
possibile mangiare, sotto le tende dei beduini, cibi dal sapore antico
che hanno saputo catturare e mettere nel piatto il gusto del deserto.
Dall’altro le produzioni agri-tech nell’Aravà permettono di assaporare
delizie che per il deserto sembrerebbero impensabili” spiegano infatti
gli organizzatori, gli chef Giovanni e Daniele Terracina e Dario
Bascetta Greco.Tra i diversi stand allestiti al Portico d’Ottavia anche quello di Tsad Kadima, associazione israeliana guidata da Alessandro Viterbo che si occupa di aiutare e organizzare il percorso formativo di ragazzi e bambini che soffrono di lesione cerebrale. Leggi |
|
qui firenze - i 30 anni di toscana ebraica Minoranze, contributo essenziale  Uno
sguardo al lungo percorso compiuto, ma anche una inevitabile proiezione
al futuro. Ai risultati da raggiungere, a quello che ancora si può fare
sul versante della divulgazione culturale. In una sala comunitaria
gremita, un susseguirsi di testimonianze e riflessioni per i 30 anni
della rivista Toscana ebraica. “Integrazione ed esclusione: il
contributo delle minoranze alla vita culturale e sociale toscana” il
tema della giornata, che si è aperta con i saluti di Dario Bedarida,
Presidente della Comunità ebraica di Firenze, del suo omologo livornese
Vittorio Mosseri e di quello pisano Maurizio Gabbrielli. A seguire la
direttrice della testata Hulda Liberanome ha parlato di “sviluppo,
finalità e futuro di Toscana Ebraica”. Uno
sguardo al lungo percorso compiuto, ma anche una inevitabile proiezione
al futuro. Ai risultati da raggiungere, a quello che ancora si può fare
sul versante della divulgazione culturale. In una sala comunitaria
gremita, un susseguirsi di testimonianze e riflessioni per i 30 anni
della rivista Toscana ebraica. “Integrazione ed esclusione: il
contributo delle minoranze alla vita culturale e sociale toscana” il
tema della giornata, che si è aperta con i saluti di Dario Bedarida,
Presidente della Comunità ebraica di Firenze, del suo omologo livornese
Vittorio Mosseri e di quello pisano Maurizio Gabbrielli. A seguire la
direttrice della testata Hulda Liberanome ha parlato di “sviluppo,
finalità e futuro di Toscana Ebraica”. Leggi |
|
sorgente di vita
Ketubbot, un'antica tradizione Inizia con un servizio sulla Ketubbà, il contratto matrimoniale ebraico, la puntata di Sorgente di Vita in onda domenica 12 novembre. Prendendo spunto dalla mostra “Concordia maritale”, esposizione di antiche Ketubbot al Museo ebraico di Roma, un approfondimento su una tradizione antica di quindici secoli. Scritte a mano su pergamena, in aramaico, le Ketubbot sono arricchite da decorazioni che esprimono il gusto delle varie epoche. Leggi |

|







Pagine Ebraiche 24, l'Unione Informa e Bokertov sono pubblicazioni edite dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L'UCEI sviluppa mezzi di comunicazione che incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche. Gli articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili. Gli utenti che fossero interessati a offrire un proprio contributo possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it Avete ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio "cancella" o "modifica". © UCEI - Tutti i diritti riservati - I testi possono essere riprodotti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Direzione. l'Unione informa - notiziario quotidiano dell'ebraismo italiano - Reg. Tribunale di Roma 199/2009 - direttore responsabile: Guido Vitale.


