
 |
 |
 |
 |
 Elia Richetti, rabbino |
| “Lo
teva’arù esh be-khòl moshevothekhèm be-yom ha-Shabbath”, “Non farete
bruciare fuoco in tutte le vostre residenze nel giorno dello Shabbath”. La Torah non dice “non accendete fuochi” o “non usate il fuoco”; dice “non farete bruciare”. Ciò ci indica che non dobbiamo far bruciare, alimentare il fuoco della polemica, della contrapposizione, del contrasto, in questo giorno, che dev’essere dedicato solo all’elevazione ed alla positività. |
| Leggi |
 Sergio SergioDella Pergola, Università Ebraica Di Gerusalemme |
| Israele
ha a tutt’oggi un sistema universitario molto brillante, con un numero
di vincitori di fondi di ricerca competitivi, di articoli scientifici
pubblicati e di brevetti fra i più alti al mondo in rapporto alla
grandezza della popolazione. Il sistema rischia ora di entrare in crisi
a causa dell’interferenza inconsueta del ministro della Pubblica
istruzione Naftali Bennett nel delicato meccanismo del Consiglio
superiore dell’Educazione superiore (Malag secondo l’abbreviazione in
ebraico). Malag è un organismo di coordinamento e di pianificazione del
sistema accademico nazionale ma rappresenta anche un’importante
barriera mediatrice fra la politica e l’accademia volta a preservare
l’autonomia delle università. È composto da 19 rappresentanti delle
università e dei collegi esistenti in Israele e include due
rappresentanti del pubblico e il presidente dell’organizzazione
nazionale degli studenti. È presieduto formalmente dal ministro ma di
fatto è diretto dal vicepresidente che viene eletto dai membri ed è
generalmente un accademico di grande prestigio (o in alcuni casi in
passato, un giudice della Corte suprema). Poco dopo la sua entrata in
carica un anno fa Bennett ha deciso di sostituire la vicepresidente del
Malag, ex-Rettore della Open University, e l’ha sostituita con una
persona di sua fiducia, una poco nota dottoressa di uno dei collegi,
ossia un’accademica che non ancora giunta al grado di professore e
oltre a tutto in uno degli istituti di minore prestigio. Per usare una
semplice metafora, Bennett si è comportato come il padrone di una
prestigiosa squadra di calcio che incurante del fatto cha la squadra è
al primo posto in classifica decide improvvisamente di cambiare il suo
noto allenatore, sostituendolo con uno delle squadre giovanili. |
| Leggi |
 |
| L'allarme dei servizi |
| “C’è
compenetrazione tra l’Is e la criminalità organizzata”, affermano i
servizi segreti italiani che avvertono Roma, nella relazione presentata
al Parlamento, del rischio di infiltrazioni terroristiche nel flusso di
migranti che arriva in Europa in particolare dall’Europa. E “l’Italia –
riporta Repubblica – appare sempre più esposta come target
privilegiato” per un attentato terroristico. Intanto la minaccia
dell’Isis e di eventuali attacchi nel Vecchio Continente preoccupano
gli organizzatori degli Europei di calcio in Francia (inizieranno tra
cento giorni) che “hanno ipotizzato di giocare alcune partite a porte
chiuse, o con orari e sedi spostate all’ultimo momento” (Corriere). |
| Leggi |
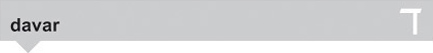
|
LA RIFLESSIONE APERTA DAL RAV DI SEGNI
Halakhah e maternità surrogata Il rabbinato italiano a confronto L’intera società italiana è attraversata in queste settimane da un vivace confronto che investe politica, intellettuali e opinion leader sul tema della maternità surrogata, con riferimento in particolare al cosiddetto “utero in affitto”. Quale la posizione del rabbinato? Quali i paletti e quali le soluzioni individuate dalla Halakhah, la Legge ebraica?  Una
materia estremamente complessa, trattata dal rabbino capo di Roma
Riccardo Di Segni in una articolata riflessione che apre il notiziario
settimanale Sheva-Idee di Pagine Ebraiche pubblicato questo mattina. Una
materia estremamente complessa, trattata dal rabbino capo di Roma
Riccardo Di Segni in una articolata riflessione che apre il notiziario
settimanale Sheva-Idee di Pagine Ebraiche pubblicato questo mattina.“Nella animata discussione che si sta sviluppando è stata tirata in ballo la matriarca Rachele come modello antico e sacro di una maternità surrogata. È il caso di discutere se e quanto questo accostamento sia lecito” osserva il rabbino capo. “Il paragone con la maternità surrogata starebbe nel fatto che una donna che non riesce ad avere figli ricorre a un’altra donna per averli. Ma fino a che punto il paragone regge?” si chiede rav Di Segni, rivolgendosi ai frequentatori “casuali” del testo biblico (che tra gli altri ignorano l’esistenza di un precedente in Sara, moglie di Abramo, nonno di Giacobbe). Un accostamento appare però difficile, anche in considerazione della diversità delle epoche e dei modelli sociali. Scrive infatti il rav: “Le persone che vengono usate per questo ‘esperimento’ biologico sono delle serve, quindi persone non libere e con le quali, secondo il diritto biblico, non era lecito il rapporto sessuale con il padrone. Sia Rachele che Sara, introducendo nel letto del marito un’estranea non libera, sanno di fare qualcosa che costerà loro cara in termini affettivi e di rapporti gerarchici, e lo fanno solo perché sono disperate”. Le serve, a loro volta, in cambio della loro prestazione biologica, “cresceranno di grado diventando mogli”. La Bibbia e la successiva tradizione rabbinica hanno tollerato l’istituto della schiavitù, riflette il rav, “ma con un sistema giuridico di tutela e protezione assolutamente innovativo rispetto alle culture coeve”. Ma oggi – si legge ancora – “a nessuno nell’ebraismo verrebbe in mente di riproporre un rapporto di schiavitù”. Se si fanno confronti tra maternità surrogata e storia di Rachele e Sara, per dire che c’è un precedente che la giustifica, andrebbe così tenuto ben chiaro “che si tratta di sfruttamento di persone non libere”. Il che non sarebbe un bel modo “per giustificare moralmente una procedura attuale”.  “Certamente
non sono pratiche incoraggiate dalla Halakhah. Il rabbinato però deve
tenere conto del fatto che esse vengono messe in atto e bisogna quindi
risolvere tutta una serie di problemi riguardo ai figli. Non vi sono
soluzioni preconfenzionate e univoche, tali da adattarsi universalmente
alle diverse situazioni. Ogni caso richiede una valutazione a parte.
Ogni caso porta con sé interrogativi e possibili soluzioni halakhiche”
dice il rav Gianfranco Di Segni, biologo e coordinatore del Collegio
Rabbinico Italiano. In particolare, osserva il rav, si pone il problema
di chi debba essere considerata “madre”: quella genetica o quella che
partorisce (la madre surrogata)? O forse tutte e due? La questione si
pone per diversi aspetti: per esempio, riguardo al divieto di incesto
con eventuali altri figli e figlie di una o entrambe le madri; o per la
questione della ebraicità dei figli, che come è noto segue la madre (“è
ebreo chi nasce da madre ebrea o si converte all’ebraismo secondo la
Halakhah”); o anche riguardo al Quinto Comandamento, “Onora tuo padre e
tua madre”: quale delle due madri si ha l’obbligo di onorare? “Certamente
non sono pratiche incoraggiate dalla Halakhah. Il rabbinato però deve
tenere conto del fatto che esse vengono messe in atto e bisogna quindi
risolvere tutta una serie di problemi riguardo ai figli. Non vi sono
soluzioni preconfenzionate e univoche, tali da adattarsi universalmente
alle diverse situazioni. Ogni caso richiede una valutazione a parte.
Ogni caso porta con sé interrogativi e possibili soluzioni halakhiche”
dice il rav Gianfranco Di Segni, biologo e coordinatore del Collegio
Rabbinico Italiano. In particolare, osserva il rav, si pone il problema
di chi debba essere considerata “madre”: quella genetica o quella che
partorisce (la madre surrogata)? O forse tutte e due? La questione si
pone per diversi aspetti: per esempio, riguardo al divieto di incesto
con eventuali altri figli e figlie di una o entrambe le madri; o per la
questione della ebraicità dei figli, che come è noto segue la madre (“è
ebreo chi nasce da madre ebrea o si converte all’ebraismo secondo la
Halakhah”); o anche riguardo al Quinto Comandamento, “Onora tuo padre e
tua madre”: quale delle due madri si ha l’obbligo di onorare? “Non
c’è un’ostilità preconcetta – dice rav Joseph Levi, rabbino capo di
Firenze – ma è fondamentale valutare caso per caso. L’Halakhah
prescrive infatti come modello ideale di famiglia una coppia che riesca
a generare un figlio e una figlia. Nel caso in cui questo non avvenga,
per i motivi più disparati, allora si rende possibile il ricorso ad
altre strade. Ma l’estrema varietà delle situazioni umane esclude
giudizi decretati a priori. Bisogna andare a fondo di ogni singola
vicenda”. “Non
c’è un’ostilità preconcetta – dice rav Joseph Levi, rabbino capo di
Firenze – ma è fondamentale valutare caso per caso. L’Halakhah
prescrive infatti come modello ideale di famiglia una coppia che riesca
a generare un figlio e una figlia. Nel caso in cui questo non avvenga,
per i motivi più disparati, allora si rende possibile il ricorso ad
altre strade. Ma l’estrema varietà delle situazioni umane esclude
giudizi decretati a priori. Bisogna andare a fondo di ogni singola
vicenda”.  “Una
delle mitzvot (doveri) più importanti per un ebreo è la procreazione.
Una pratica come quella della maternità surrogata rappresenta una
soluzione alternativa, non certo la prima scelta. Quindi non mi
entusiasma, anche alla luce delle molte sfumature che la
caratterizzano. Da un punto di vista ebraico, c’è infatti da chiedersi
chi sia realmente la madre e ancora si aprono molte questioni inerenti
la consanguineità o l’eventuale conversione del bambino o della
bambina. Temi spinosi – riflette rav Alberto Somekh – su cui da tempo
il rabbinato dibatte”. “Una
delle mitzvot (doveri) più importanti per un ebreo è la procreazione.
Una pratica come quella della maternità surrogata rappresenta una
soluzione alternativa, non certo la prima scelta. Quindi non mi
entusiasma, anche alla luce delle molte sfumature che la
caratterizzano. Da un punto di vista ebraico, c’è infatti da chiedersi
chi sia realmente la madre e ancora si aprono molte questioni inerenti
la consanguineità o l’eventuale conversione del bambino o della
bambina. Temi spinosi – riflette rav Alberto Somekh – su cui da tempo
il rabbinato dibatte”. "L’ebraismo
è abbastanza permissivo sulle pratiche extrauterine, non mancando però
di porre alcuni limiti” conferma il rabbino capo di Trieste, rav
Eliezer Di Martino. Nell'arco delle opzioni inammissibili, dice il rav,
l'azione a favore di coppie composte da persone dello stesso sesso. “In
questo caso è chiaro che si tratta di un sotterfugio”. "L’ebraismo
è abbastanza permissivo sulle pratiche extrauterine, non mancando però
di porre alcuni limiti” conferma il rabbino capo di Trieste, rav
Eliezer Di Martino. Nell'arco delle opzioni inammissibili, dice il rav,
l'azione a favore di coppie composte da persone dello stesso sesso. “In
questo caso è chiaro che si tratta di un sotterfugio”.Adam Smulevich twitter @asmulevichmoked |
|
qui napoli Orgoglio, passione, progetti 150 anni guardando al futuro O  “Quella
della Comunità ebraica di Napoli è una storia antichissima, che inizia
molto prima del 1864″. Così Giancarlo Lacerenza, direttore del Centro
di studi ebraici dell’Università di studi di Napoli L’Orientale,
presenta i contenuti del volume La Comunità ebraica di Napoli
(1864-2014): centocinquant’anni di storia, un catalogo comprendente una
raccolta di saggi che raccontano l’eredità ebraica della città
realizzato a seguito delle due mostre ospitate dalla Biblioteca
Nazionale e dall’Archivio di Stato lo scorso anno. Un’iniziativa resa
possibile grazie al contributo dell’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia, della
Comunità ebraica di Napoli assieme all’Archivio di Stato cittadino e al
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo. Alla
presentazione – svoltasi nella stessa sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli che ha ospitato anche la mostra e condotta in
dialogo con la giornalista Titti Marrone – hanno portato il loro saluto
il Consigliere UCEI Sandro Temin, il presidente della Fbcei Dario
Disegni, il presidente della Comunità ebraica di Napoli Lydia Schapirer. “Quella
della Comunità ebraica di Napoli è una storia antichissima, che inizia
molto prima del 1864″. Così Giancarlo Lacerenza, direttore del Centro
di studi ebraici dell’Università di studi di Napoli L’Orientale,
presenta i contenuti del volume La Comunità ebraica di Napoli
(1864-2014): centocinquant’anni di storia, un catalogo comprendente una
raccolta di saggi che raccontano l’eredità ebraica della città
realizzato a seguito delle due mostre ospitate dalla Biblioteca
Nazionale e dall’Archivio di Stato lo scorso anno. Un’iniziativa resa
possibile grazie al contributo dell’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia, della
Comunità ebraica di Napoli assieme all’Archivio di Stato cittadino e al
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo. Alla
presentazione – svoltasi nella stessa sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli che ha ospitato anche la mostra e condotta in
dialogo con la giornalista Titti Marrone – hanno portato il loro saluto
il Consigliere UCEI Sandro Temin, il presidente della Fbcei Dario
Disegni, il presidente della Comunità ebraica di Napoli Lydia Schapirer.Leggi |
|
JCIAK
Tre baciati dall'Oscar  Senza
sorprese mozzafiato, l’Oscar quest’anno ci consegna alcune belle
certezze. Si può discutere se sia stato davvero l’Oscar dell’impegno,
come molti critici l’hanno subito etichettato. O se l’impegno non sia
stato piuttosto una foglia di fico da esibire contro la scottante
etichetta di Oscar troppo bianchi e distanti dalla vita vera. In
alternativa, ci si può invece godere qualche serata al cinema con i
vincitori, che molto ci regalano anche sotto il profilo ebraico con una
superba tripletta composta da Il figlio di Saul (miglior film
straniero), Spotlight (miglior film) e Amy (miglior documentario
lungo). Senza
sorprese mozzafiato, l’Oscar quest’anno ci consegna alcune belle
certezze. Si può discutere se sia stato davvero l’Oscar dell’impegno,
come molti critici l’hanno subito etichettato. O se l’impegno non sia
stato piuttosto una foglia di fico da esibire contro la scottante
etichetta di Oscar troppo bianchi e distanti dalla vita vera. In
alternativa, ci si può invece godere qualche serata al cinema con i
vincitori, che molto ci regalano anche sotto il profilo ebraico con una
superba tripletta composta da Il figlio di Saul (miglior film
straniero), Spotlight (miglior film) e Amy (miglior documentario
lungo). Daniela Gross Leggi |

|
|
|






Pagine Ebraiche 24, l'Unione Informa e Bokertov sono pubblicazioni edite dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L'UCEI sviluppa mezzi di comunicazione che incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche. Gli articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili. Gli utenti che fossero interessati a offrire un proprio contributo possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it Avete ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio "cancella" o "modifica". © UCEI - Tutti i diritti riservati - I testi possono essere riprodotti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Direzione. l'Unione informa - notiziario quotidiano dell'ebraismo italiano - Reg. Tribunale di Roma 199/2009 - direttore responsabile: Guido Vitale.







