Rotschild Boulevard Murdoch e il cibo cinese
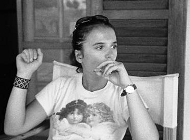 Perché proprio il cibo cinese? Ho cominciato a pensarci quando ho letto del discorso di Rupert Murdoch, che lo scorso 4 marzo ha ritirato un premio per le “relazioni umane nazionali” dall’American Jewish Committee. Il magnate dei mezzi di comunicazione, che ebreo non è, ha attaccato il suo discorso di ringraziamento con una battuta: “Negli ultimi anni, alcuni dei miei critici più feroci hanno dato per scontato che in fossi ebreo, mentre alcuni dei miei migliori amici si auguravano che lo fossi” ha detto Murdoch. Che
Perché proprio il cibo cinese? Ho cominciato a pensarci quando ho letto del discorso di Rupert Murdoch, che lo scorso 4 marzo ha ritirato un premio per le “relazioni umane nazionali” dall’American Jewish Committee. Il magnate dei mezzi di comunicazione, che ebreo non è, ha attaccato il suo discorso di ringraziamento con una battuta: “Negli ultimi anni, alcuni dei miei critici più feroci hanno dato per scontato che in fossi ebreo, mentre alcuni dei miei migliori amici si auguravano che lo fossi” ha detto Murdoch. Che
poi ha aggiunto: “E in effetti vivo a New York, ho una moglie che adora il cibo cinese. E persone di cui mi fido mi dicono che praticamente costituisco la concreta applicazione della parola chutzpah”.
Ora, Murdoch ha tirato in ballo (scherzando, s’intende) i tre cliché molto comuni sull’identità moderna ebraico-americana. Su New York e la chutzpah, nulla da dire. Ma il cibo cinese? Quello degli ebrei, specie a New York, che “adorano il cibo cinese” è uno archetipo vecchio quasi un secolo. Va bene, ma da dove viene? Cercando qua e là, ho scoperto che la questione ha incuriosito alcuni sociologi, ed è
stata oggetto persino di discussioni accademiche. Gaye Tuchman (docente presso l’Università del Connecticut) e Harry G. Levine (del Queens College di New York) ci hanno dedicato uno studio, pubblicato anni fa sul “Journal of Contemporary Ethnography”.
L’articolo, intitolato “Safe treyf, New York, Jews and chinese food”, nota che “gli ebrei immigrati dall’Europa orientale, e ancora di più i loro figli e nipoti, hanno incorporato il cibo dei ristoranti cinesi nella propria nuova cultura ebraico-americana (…) al punto da farne la propria seconda cucina di riferimento”. La spiegazione, sostengono i due sociologi, sta nella storia dell’immigrazione: ebrei, italiani e cinesi arrivarono a New York più o meno nello stesso periodo; più degli altri due gruppi, i membri della comunità ebraica (molti venivano dalle città) erano più avvezzi a mangiare fuori casa.
Perché hanno scelto i locali cinesi e non quelli italiani, allora? In parte, sostengono Tuchman e Levine, perché i ristoratori cinesi cercavano di attirare anche clienti al di fuori della loro comunità, mentre i ristoratori italiani all’inizio cercavano di attirare quasi solo clienti italiani. Poi i locali italiani spesso avevano in bella mostra immagini sacre cattoliche, mentre i ristoranti cinesi erano privi di riferimenti religiosi: di conseguenza i clienti ebrei potevano sentirsi più a casa.
Resta la questione della kasherut. E qui si spiega il titolo “Safe treyf” (non kasher, ma “sicuro”): i due sociologi sostengono infatti che gli immigrati ebrei di seconda generazione spesso non rispettavano le regole alimentari, ma per abitudine “provavano un disgusto” istintivo per carne di maiale e frutti di mare. Ingredienti di cui abbondano e la cucina italiana e la cucina cinese. La differenza, sostengono gli autori dello studio, è che il cibo cinese è sempre stracotto e tagliato in piccoli pezzi: “Poteva essere mangiato dagli ebrei ribelli, perché le sostanze proibite erano così ben nascoste che non sembravano più così repellenti”.
Un tantino forzato? Probabilmente sì. Seguono pagine e pagine di riflessioni accademiche sul valore culturale dell’agrodolce e dello stracotto. Sarà. Io preferisco la spiegazione di una vecchia amica di Filadelfia. Quando le hanno chiesto perché gli ashkenaziti americani amano tanto il cibo cinese, lei ha risposto: “Vi sembra meglio il gefiltefish?”
Anna Momigliano
