USA – «In primo luogo sono americani»
Sergio Della Pergola racconta gli ebrei d’Oltreoceano

Previsione secca: Kamala Harris al 70%, Donald Trump al 30%.
Così Sergio Della Pergola immagina il voto ebraico americano alle presidenziali, «in linea grosso modo con le scelte tradizionali degli ebrei Usa, da sempre più vicini alle istanze democratiche; solo una volta, ai tempi di Ronald Reagan, i repubblicani furono premiati con circa il 40% dei consensi». Nessuno scossone in vista, insomma, «pur con una distinzione tra ortodossi e altre correnti: i primi, una minoranza nel paese, sono senz’altro più vicini a Trump, mentre gli altri prediligono di gran lunga Harris».
Solo una delle “spaccature” sulle quali l’accademico – Della Pergola è stato a lungo demografo all’Università di Gerusalemme – si sofferma nel nuovo libro in uscita, US JEWS: Reflections on Identity and Demography. Pubblicato dall’editore Springer, in oltre 500 pagine condensa decenni di studi e articoli sul tema, con una loro attualizzazione. Della Pergola parla anche per esperienza vissuta: per oltre due anni ha abitato negli Stati Uniti, insegnando all’università e facendo frequentare ai figli le scuole ebraiche.
Il saggio si apre con un approfondimento sull’identità ebraica Usa a confronto con altri modelli di aggregazione, affronta le tendenze in atto e la sfida di definire quantitativamente tale presenza; quindi prosegue con l’analisi dei vari gruppi e sottogruppi e documenta il volgere del mondo ebraico verso il concetto unificante di “americanità”.
Un concetto «molto forte, dominante, in teoria amichevole, perché sembra invitarci a stare tutti insieme sotto la stessa cupola». Idea affascinante sulla carta, ma con risvolti pratici discutibili. Lo si vede ad esempio «nelle due divisioni che stanno lacerando l’ebraismo Usa: da una parte nel modo di porsi con Israele, dall’altra nella dialettica interna tra ortodossi e altre correnti». Il pendolo è in movimento e «oggi non è possibile dire dove si fermerà».
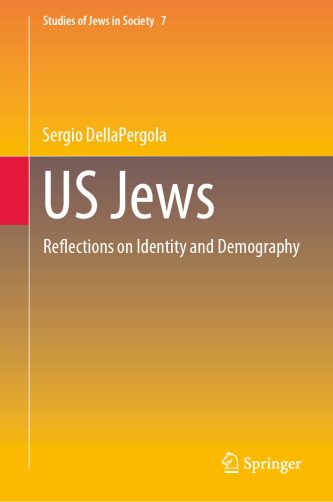 Intanto c’è da intendersi sul numero degli ebrei Usa. «Li definiamo univocamente o a seconda delle tendenze ideologiche o politiche del momento? E poi: come ci rapportiamo con ciò che la Halakhah definisce come criteri e quella che è invece la situazione reale sul terreno? Non possiamo far altro che accettare le dichiarazioni delle persone», sostiene Della Pergola, fautore in tal senso del concetto “di nucleo ebraico” da cui restano ad esempio esclusi «centinaia di migliaia di americani che si definiscono al tempo stesso ebrei e cristiani o Jews for Jesus: è una storia interessante, ma è un’altra storia». Per questo la cifra di sei milioni e 300mila unità da lui proposta è in genere più contenuta rispetto a quella fatta da alcuni suoi colleghi più “generosi”.
Intanto c’è da intendersi sul numero degli ebrei Usa. «Li definiamo univocamente o a seconda delle tendenze ideologiche o politiche del momento? E poi: come ci rapportiamo con ciò che la Halakhah definisce come criteri e quella che è invece la situazione reale sul terreno? Non possiamo far altro che accettare le dichiarazioni delle persone», sostiene Della Pergola, fautore in tal senso del concetto “di nucleo ebraico” da cui restano ad esempio esclusi «centinaia di migliaia di americani che si definiscono al tempo stesso ebrei e cristiani o Jews for Jesus: è una storia interessante, ma è un’altra storia». Per questo la cifra di sei milioni e 300mila unità da lui proposta è in genere più contenuta rispetto a quella fatta da alcuni suoi colleghi più “generosi”.
Uno dei temi studiati è quello dei matrimoni misti. «Se nel 1950 erano il 5%, una percentuale bassissima, nel 1960 già sfioravano il 10%. Oggi sono più del 60%, più che nell’Europa ebraica», spiega Della Pergola. Si innesta in questo quadro la divaricazione «molto forte» tra gruppi ortodossi in espansione «con un numero crescente di scuole ebraiche nella loro orbita» e altre componenti ebraiche che, dotate anche di scarse strutture educative attraverso cui erogare servizi, «procedono a passi spediti verso l’assimilazione». Un capitolo di US JEWS: Reflections on Identity and Demography è dedicato alle differenze tra uomini e donne a livello identitario e demografico. «È la donna che mantiene molto più dell’uomo l’identità ebraica nel contesto familiare», rileva Della Pergola. «La spiegazione è che i processi di trasmissione da una generazione all’altra si sono svolti in maniera più conservatrice, così che nella sociologia americana la donna ha una centralità non dissimile dall’Halakhah». Tornando alle elezioni, Della Pergola osserva che gli elettori ebrei di Trump «hanno in genere una percezione delle problematiche ebraiche molto più forte e molto più chiara degli elettori del partito democratico: per molti versi, li si potrebbe definire più integralmente ebrei». Mentre i sostenitori ebrei dei dem «hanno una visione più nazionale, statunitense: è in quella prospettiva che inseriscono i temi ebraici». C’entra in ciò anche la funzione della scuola e in particolare della scuola ebraica. «Perché se in tutti i paesi del mondo è un fattore centrale di aggregazione, un ponte tra religiosi e laici per sviluppare un senso di solidarietà comune, questo non è vero per gli Usa», puntualizza Della Pergola. Qui «l’elemento coalizzante, fuori dall’ambito dell’ortodossia, è l’americanità, il sentirsi prima di tutto americani». È un discorso in fondo non nuovo, già visto cent’anni fa alle nostre latitudini, «quando ci si definiva italiani ebrei piuttosto che ebrei italiani». Un’altra divergenza di vedute profonda riguarda Israele «e deriva anche da questioni anagrafiche: le persone anziane, sopra i 70, hanno assistito alla sua nascita e per loro è un qualcosa di molto importante e fonte al tempo stesso di enorme preoccupazione».
Per i giovani la questione è meno sentita e «a fronte di un parziale ritorno di alcuni all’ortodossia si sedimenta sull’altro fronte un processo di perdita dell’identità nazionale ebraica che si traduce anche in una maggiore distanza».
Una delle conseguenze è «la presenza di tanti giovani ebrei alla guida dei movimenti ostili allo Stato ebraico nelle università e non solo: una realtà che i dati di inchiesta lasciavano prevedere».
Adam Smulevich
(Nell’immagine in alto Sergio Della Pergola – Foto: Giovanni Montenero)
