SCAFFALE – Nexus o della verità e della propaganda
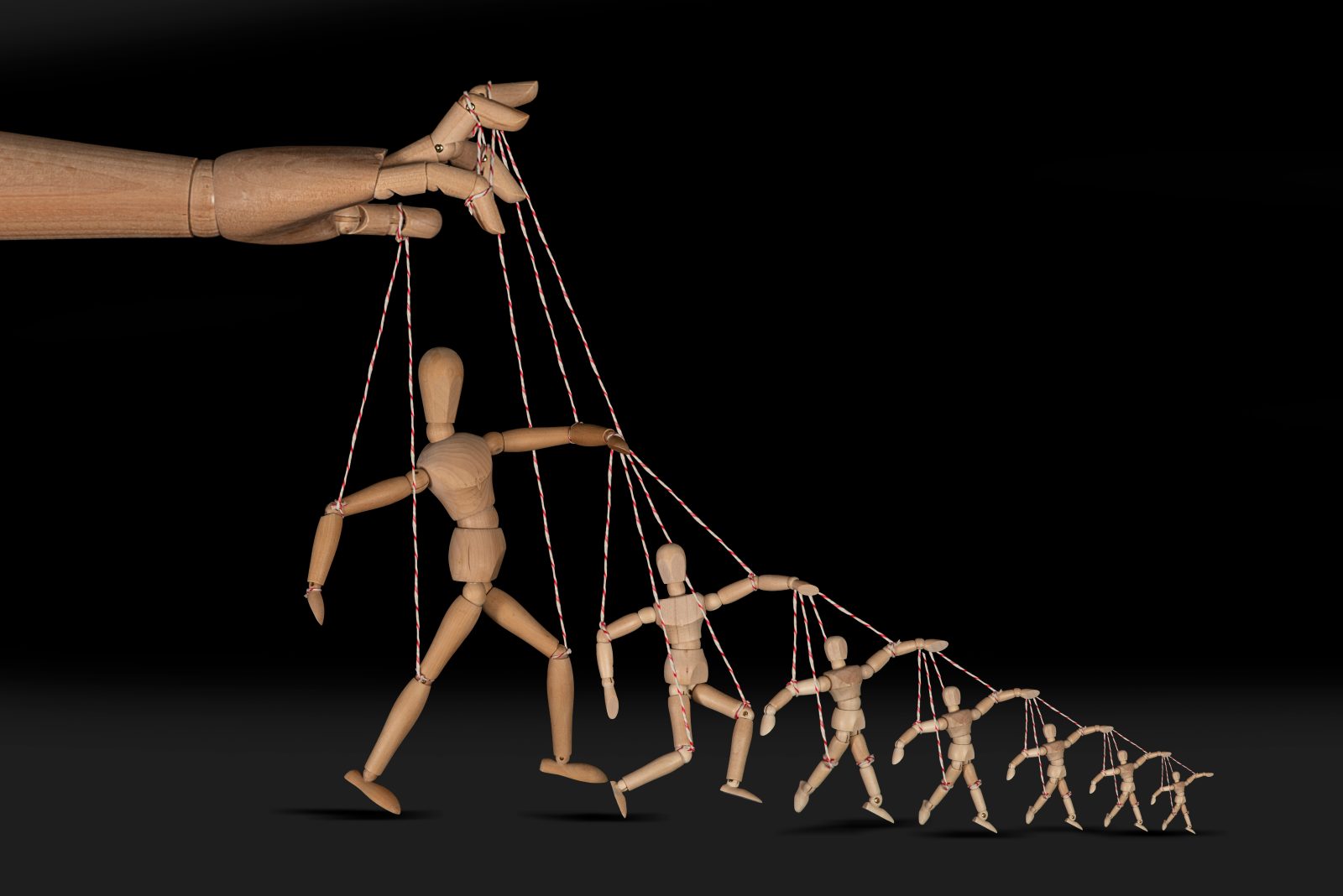
In che modo l’informazione ha inciso sulla storia dell’umanità? In che modo può rappresentare una forma di “verità”, o può aiutare a raggiungerla? Che rapporto c’è tra informazione e potere? Come si può definire un’informazione “vera” o “falsa”? Può mai essere concepibile una rappresentazione “fedele” della realtà? E può quindi esistere un’informazione “oggettiva”, “neutrale”, “innocente” della realtà?
Queste e altre le domande di fondo che emergono dall’ultimo, poderoso volume del grande storico e filosofo israeliano Yuval Noha Harari: Nexus. Breve storia delle reti di informazione dall’età della pietra all’I.A. (ed. it. Bompiani-Giunti, Firenze-Milano, 2024, pp. 600, euro 26). Un libro che non è da meno dei suoi precedenti bestseller, tradotti in quasi tutto il mondo (Sapiens. Da animali a dèi, Homo Deus, 21 lezioni sul XXI secolo), anzi, a mio avviso, riesce a superarli come forza di suggestione e originalità di impostazione, e credo basti a cancellare definitivamente la diceria (dettata probabilmente da meschine 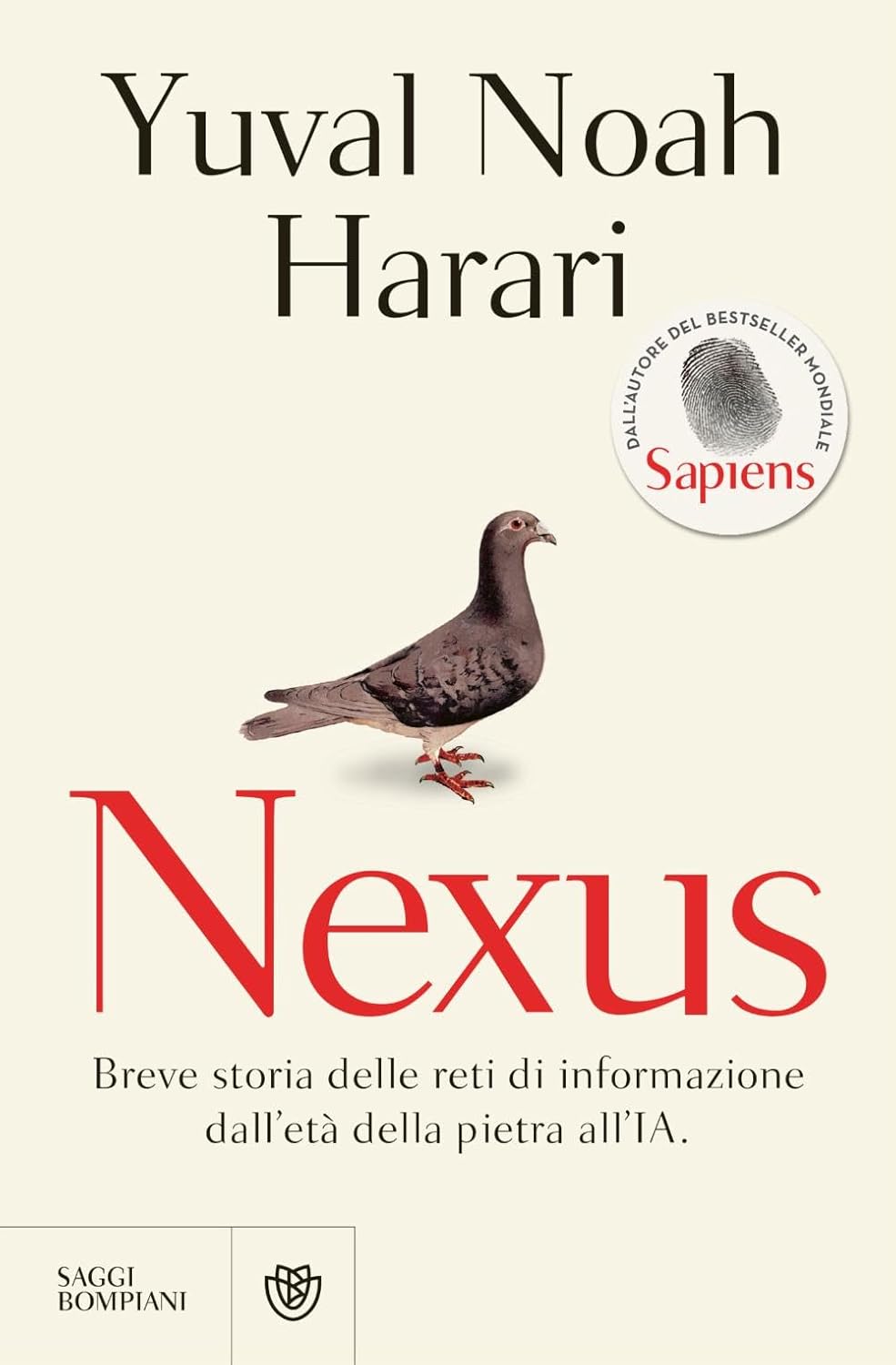 gelosie da parte dell’ambiente accademico) secondo cui Harari sarebbe sostanzialmente un grande divulgatore, che renderebbe accessibili a un ampio pubblico acquisizioni scientifiche raggiunte ed elaborate da altri. A parte il fatto che la capacità di divulgazione e di irradiazione del pensiero rappresentano un indubbio merito per qualsiasi opera di scienza, non c’è dubbio che lo studioso, particolarmente in questa sua ultima opera, riesca a proporre un approccio di grande novità e suggestione con alcuni degli snodi fondamentali della storia. Le sue non sono propriamente delle “scoperte”, ed è vero che la maggioranza dei dati da lui esposti sono già conosciuti, almeno in ambienti specialistici. Ma il suo angolo di visione è certamente nuovo, e offre spunti di riflessione di indubbio interesse.
gelosie da parte dell’ambiente accademico) secondo cui Harari sarebbe sostanzialmente un grande divulgatore, che renderebbe accessibili a un ampio pubblico acquisizioni scientifiche raggiunte ed elaborate da altri. A parte il fatto che la capacità di divulgazione e di irradiazione del pensiero rappresentano un indubbio merito per qualsiasi opera di scienza, non c’è dubbio che lo studioso, particolarmente in questa sua ultima opera, riesca a proporre un approccio di grande novità e suggestione con alcuni degli snodi fondamentali della storia. Le sue non sono propriamente delle “scoperte”, ed è vero che la maggioranza dei dati da lui esposti sono già conosciuti, almeno in ambienti specialistici. Ma il suo angolo di visione è certamente nuovo, e offre spunti di riflessione di indubbio interesse.
Harari ripercorre la plurimillenaria evoluzione dell’Homo Sapiens alla luce della creazione, della trasformazione e degli usi delle diverse forme di informazione e di comunicazione, degli innumerevoli modi in cui gli essere umani si sono scambiati notizie di ogni genere, consapevolmente o inconsapevolmente, con scopi solidaristici o malevoli, in buona o in cattiva fede, facendosi (o cercando di farsi) del bene o del male, facendo sì che i propri messaggi venissero correttamente compresi, o anche più o meno travisati, distorti, capovolti.
All’inizio del volume l’autore distingue quelle che gli appaiono essere due fondamentali e opposte visioni delle reti di informazioni, che egli definisce la visione “ingenua” e quella “populista”.
La prima sarebbe la concezione secondo cui l’informazione riceverebbe naturalmente beneficio (in termini di “veridicità”, credibilità, affidabilità) dalla propria semplice crescita e moltiplicazione. Se in un sistema dittatoriale o autoritario, sostiene la visione ingenua, un solo dittatore o una sola oligarchia dominante sono padroni di tutti i mezzi di informazione, è molto difficile che le notizie date siano veritiere e affidabili, perché esse dipendono soltanto dalla volontà di poche persone, che verosimilmente avranno interesse a far conoscere solo ciò che è utile alla perpetuazione del loro predominio. E sarà molto difficile fare filtrare e circolare notizie e interpretazioni di tipo diverso, perché sarà molto difficile, se non impossibile, costruire e divulgare delle diverse rappresentazioni della realtà. La pluralità dei mezzi di informazione e dei soggetti che li hanno a disposizione, perciò, rappresenterebbe di per sé un antidoto alla menzogna e alla distorsione, perché una notizia falsa farebbe fatica a contrastare, da sola, tante altre notizie vere, o semplicemente diverse. Le società democratiche e liberali, perciò, dove ognuno può dire la sua, sarebbero lo spazio ideale per la formazione e la circolazione di una corretta informazione, mentre quelle totalitarie rappresenterebbero il contrario.
Questa visione avrebbe un suo fondamento, ma sarebbe, appunto, “ingenua”, in quanto basata sul falso presupposto che gli uomini tenderebbero naturalmente alla conquista della “verità”, e sarebbero perciò istintivamente propensi a cercare e a trovare le notizie “vere”, così come i mercanti di gioielli d’oro, per fare il loro mestiere, devono innanzitutto imparare a distinguere quelli veri da quelli falsi.
In realtà, la storia insegna inesorabilmente che le cose non vanno così, e che gli uomini non hanno alcun innato desiderio di conoscere la verità, mentre amano sentirsi dire le cose che a loro, in quel dato frangente storico, piace sentire. Sono spesso dei mercanti che preferiscono acquistare dei gioielli falsi, buttando nella spazzatura quelli veri. Non è affatto vero, perciò, che “più informazione” equivale a “migliore informazione”.
La visione “populista”, invece, sostiene che l’informazione non avrebbe nessun rapporto con la “verità”, e sarebbe soltanto una forma di potere. Chi detiene i mezzi di informazione (da un tamburo a un giornale, da una rete televisiva a una piattaforma social) esercita una forma di potere, e stare a giudicare sulla verità o falsità delle notizie trasmesse sarebbe del tutto inutile. L’unica cosa che conta è ragionare su chi esercita tale potere, per quali obiettivi, e contro quali avversari. La dicotomia vero/falso non c’entrerebbe nulla con l’informazione, trattandosi di due questioni del tutto distinte.
Ma anche la visione “populista”, secondo Harari, pur avendo dei riscontri, sarebbe parziale e semplicistica, perché non è vero che l’informazione non ha nessun rapporto con la verità. La verità, semplicemente, è il frutto dell’informazione, e ciò che non viene comunicato, in pratica, non esiste. E se l’informazione “crea” la verità, essa non può essere considerata soltanto una forma di potere, dal momento che il potere deve poi fare i conti con la verità che ha creato, e che poi vive di vita autonoma.
Entrambe le visioni, quindi, sono incomplete e illusorie.
Può essere cercata una terza visione di informazione, “intermedia” tra questi due opposti?
Il libro è stato scritto con questo intento, e vale certamente la pena leggerlo.
Francesco Lucrezi, storico
