SCAFFALE – Rebecca, la Musica contro il Male

«L’archetto di parole con cui Jasminka Domaš anima le scene di vita della famiglia sefardita Levi magicamente suona i tempi della sinfonia di un destino umano che è concreto e immaginario, lirico e drammatico, quello zagabrese ebraico e al contempo una semplice ed universale immagine dell’Uomo. Jasminka Domaš, con sincerità artistica, orchestra le parole svelandone un’anima in cui è incisa l’anima dell’Uomo. Dell’uomo artista e di chiunque senta di dover umanamente compiere una missione sulla Terra».
Queste toccanti parole di Suzana Glavaš – tratte dalla sua prefazione al libro di Jasminka Domaš Rebecca nel Profondo dell’Anima (Carthago edizioni, Catania 2022, traduzione dal croato di Suzana Glavaš, con Nota dell’Editore [a cura di Margherita Guglielmino e Giuseppe Pennisi], Prefazione della stessa Glavaš, Nota dell’Autrice e Postfazione di David Albahari, pagg. 202, euro 18) – ben rendono l’essenza di un romanzo di grande intensità, nel quale la narratrice riesce a intrecciare con maestria storia e poesia, tragedia e speranza, in una narrazione che coinvolge il lettore per la sua delicatezza e forza di suggestione.
La storia è ambientata in una famiglia ebraica benestante di Zagabria, prima e durante l’emanazione delle Leggi razziali da parte del governo nazifascista croato. Protagonista è una giovane violoncellista, Rebecca Levi, la quale, di fronte all’immane tragedia che sta per travolgere il suo popolo e, con esso, buona parte del mondo, cerca rifugio in quella che è sempre stata la sua scialuppa di salvataggio, la sua àncora di salvezza, ossia la musica.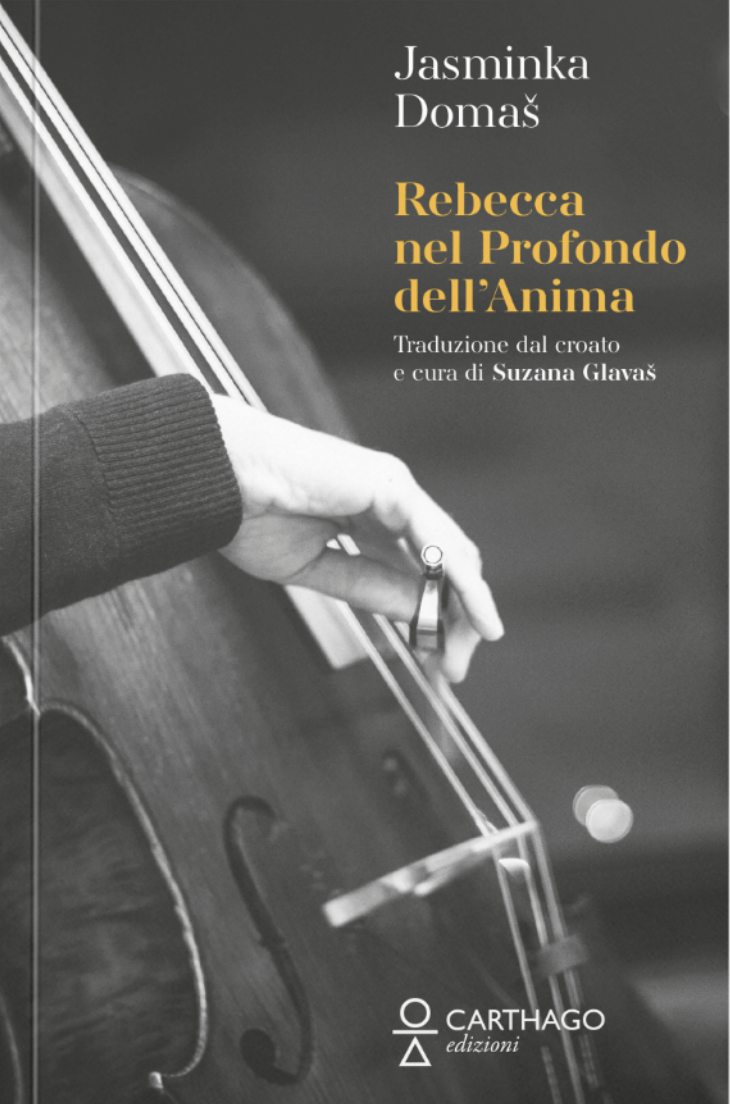 Il romanzo descrive con toni di incredula disperazione il repentino passaggio da una vita fatta di benessere, arte, gentilezza a una segnata da rifiuto, disprezzo, sopraffazione. Rebecca legge sbigottita il decreto che impedisce tassativamente a tutti gli appartenenti alla razza ebraica di «collaborare alla costruzione della cultura nazionale e ariana», escludendoli «in particolare dal campo delle lettere, del giornalismo, dell’arte figurativa e musicale e dall’urbanistica, dall’arte teatrale e cinematografica». Si accosta a una sua fotografia che la ritrae nel giorno in cui si diplomò al Conservatorio di Zagabria: «Dalla fotografia mi scruta un’altra Rebecca che ormai non conosco più, la Rebecca dal volto raggiante, dallo sguardo felice e aperto, inteso a dire: “Questo mondo è mio ed io faccio parte di questo mondo. Il mio mondo è la musica, la musica è il mondo”».
Il romanzo descrive con toni di incredula disperazione il repentino passaggio da una vita fatta di benessere, arte, gentilezza a una segnata da rifiuto, disprezzo, sopraffazione. Rebecca legge sbigottita il decreto che impedisce tassativamente a tutti gli appartenenti alla razza ebraica di «collaborare alla costruzione della cultura nazionale e ariana», escludendoli «in particolare dal campo delle lettere, del giornalismo, dell’arte figurativa e musicale e dall’urbanistica, dall’arte teatrale e cinematografica». Si accosta a una sua fotografia che la ritrae nel giorno in cui si diplomò al Conservatorio di Zagabria: «Dalla fotografia mi scruta un’altra Rebecca che ormai non conosco più, la Rebecca dal volto raggiante, dallo sguardo felice e aperto, inteso a dire: “Questo mondo è mio ed io faccio parte di questo mondo. Il mio mondo è la musica, la musica è il mondo”».
L’essere violentemente staccata dalla musica, quindi dal mondo intero, mette a dura prova anche la fede della violoncellista, che, per lei, era un tutt’uno con la musica stessa: «La mia religiosità era nella musica, nella consapevolezza di dover incrementare il talento donatomi, offrendo al mondo, per suo tramite, bellezza e conforto. Ora, con un solo Decreto Legge, sono cancellata, espulsa». Un’espulsione che sembra essere definitiva, totale, da tutto: dal mondo, dalla musica, dalla fede, dalla vita stessa. Anche gli altri componenti della sua famiglia, naturalmente, vengono colpiti, e innanzi alla famiglia Levi, come a tutti gli ebrei croati, si apre solo una nera voragine. «Mi auguro – pensa la protagonista – che almeno qualcuno di noi sopravviva».
Il romanzo è scritto con una prosa asciutta, sobria, fatta di frasi brevi e scarne, che non abbondano in aggettivi (e di ciò, ovviamente, il merito va diviso tra l’autrice e la bravissima traduttrice, nota poetessa e filologa italo-croata, studiosa di letteratura croata, italiana ed ebraica), che fa ulteriormente risaltare la tragicità del racconto.
L’edizione originale del romanzo, in lingua croata, risale a circa vent’anni fa, e non si può non ringraziare l’autrice, l’editore e la traduttrice per averne permesso la conoscenza anche al pubblico italiano. «Il romanzo – scrive la scrittrice nella sua nota introduttiva – nel corso di un ventennio trascorso non ha minimamente perso di attualità. Al contrario, poiché le guerre non finiscono. Il male non è scomparso… Purtroppo, se guardiamo in faccia alla verità, vediamo che è disastrosa, avendo i costruttori di pace un avversario sempre più potente».
Eppure, nonostante tutto, il romanzo apre una porta alla speranza. «Talvolta – scrive, nella sua postfazione, Albahari – bisogna piegarsi fino a terra, sta scritto nei libri sacri, per vedere il volto del Signore. Talvolta, invece, bisogna rimanere in silenzio per esprimere le giuste parole. E talvolta bisogna prendere in mano un libro, un libro come Rebecca nel Profondo dell’Anima».
Viene da chiedersi se il romanzo autorizzi a interpretare l’eterna lotta tra il Bene e il Male anche come una lotta tra l’Arte e il Male. Ma è una domanda a cui è impossibile rispondere. Diciamo solo che l’Arte (in questo caso, la musica e la narrativa) permette di interrogarsi sul significato della domanda.
Francesco Lucrezi, storico
