TU BISHVAT – Uno shabbat planetario per un pianeta migliore

«Le scienze umane per l’ambiente sono un tentativo di affrontare la crisi ambientale non da un punto di vista solo scientifico ed economico ma utilizzando tutte le risorse della cultura umanistica, in un dialogo interdisciplinare. L’idea che si possa affrontare il problema ambientale solo in chiave tecnologica o di sviluppo sostenibile è un enorme equivoco. Una illusione colossale». Shaul Bassi risponde dalla Folger Shakespeare Library di Washington D.C., dove si trova per un periodo di studio: sta lavorando a una nuova edizione del Il mercante di Venezia per The Arden Shakespeare Fourth Series. Quello stesso Mercante intorno a cui aveva organizzato numerose iniziative in occasione dei cinquecento anni del Ghetto di Venezia, e che ha definito «l’ebreo veneziano più famoso di tutti i tempi». Ma Bassi non si occupa solo di letteratura inglese, di cui è ordinario all’Università Ca’Foscari: i suoi interessi spaziano dagli studi postcoloniali all’ebraismo ed è uno dei docenti del corso di Environmental Humanities, sempre a Ca’ Foscari.
È un fiume in piena e a Pagine Ebraiche spiega: «Pensate agli incendi a Los Angeles, basta guardarsi intorno per vedere cosa sta succedendo. È evidente che non possiamo affidarci solo alla scienza e all’economia. È in atto un gigantesco processo di rimozione, vediamo davanti a noi un futuro apocalittico, terrificante. Esiste però un approccio umanistico che affronta questa paura facendo tesoro di tutte le risorse che possono offrire filosofia, storia e letteratura. Le scienze umane non hanno alcuna pretesa di essere strumento esclusivo ma possono aiutarci a trovare una strada; sono convinto che l’unica possibilità che forse ancora abbiamo sia una trasformazione radicale del nostro modo di pensare». Bassi porta esempi pratici: è possibile, suggerisce, mangiare in maniera diversa e così evitare di danneggiare il nostro mondo, ma non saranno le informazioni scientifiche che ci faranno rinunciare allo spezzatino della nonna; solo la riflessione, un cambiamento della narrazione e un diverso rapporto con la tradizione possono portarci a una scelta simile. «Bisogna anche essere attenti al rischio di rimozione di questi temi, i messaggi catastrofisti e moralisti allontanano le persone e il paradosso è che serviranno alcune generazioni prima di poter modificare il paradigma. Per questo sono così importanti le culture religiose, tutte. E quella ebraica in particolare: che contiene un pensiero intergenerazionale e transgenerazionale fondamentale per questo approccio umanistico».
«Lo spiega mirabilmente Amitav Ghosh», continua Bassi menzionando lo scrittore e antropologo indiano in La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile. «Non si tratta di inventare soluzioni miracolose ma di prepararsi ad affrontare una crisi estrema, e in questo l’esperienza ebraica può essere importantissima. So bene che è un parallelo azzardato ma è anche molto stimolante: l’esperienza del trauma della Shoah può aiutarci ad affrontare lo shock di un mondo squassato dalla crisi ambientale. Non sono solo incendi e alluvioni: si muoveranno grandi quantità di migranti climatici e ne seguiranno nuovi scontri fra popoli. Cose che causeranno anche difficoltà psicologiche. La psicanalista Sally Weintrobe, per esempio, in questo ambito si occupa di due grandi argomenti: la rimozione e la cura, aspetti della crisi che sono molto sottovalutati ». Spiega Bassi che questi temi vengono trattati come disturbi cui dare soluzioni terapeutiche: l’eco-ansia viene affrontata con terapie brevi, come viene fatto con la paura di volare. Le scienze umane per l’ambiente, invece, portano a un approccio intellettuale e poi spesso alla militanza e all’attivismo.
Continua: «È molto diffusa l’idea che la crisi ambientale derivi dalla tradizione giudaico-cristiana, che a partire dalla Genesi ha messo nelle mani dell’essere umano tutta la natura, come una cosa da dominare. Da qui discende l’interesse specifico per le culture indigene, che con la natura avrebbero un rapporto più equilibrato. Ma nella tradizione ebraica esistono forme di pensiero e di pratica incentrate sulla cura del mondo, non sul suo dominio, e sono convinto che questa cultura offra grandi risorse. A partire dalla centralità del sabato e dalla kasherut: è importante sapersi porre dei limiti in un momento storico in cui tutto è a disposizione e si pensa che non si debbano ridurre i consumi».
Bassi prosegue ricordando la prima migrazione ebraica, causata da una carestia che aveva spinto Abramo ad abbandonare la terra di Canaan per l’Egitto. Allo stesso modo molte aree del mondo sono già o diventeranno presto invivibili: «Gli ebrei in fondo non si illudono mai di essere in una situazione stabile. E il nostro umorismo è una risorsa fondamentale: se davvero sta arrivando un altro diluvio universale i rabbini ci insegnano che invece di pregare o affidarci a D-o dobbiamo sbrigarci e imparare a vivere sott’acqua». Esiste anche una cultura rabbinica che si occupa di pensiero delle catastrofi. E molti ne hanno scritto: l’americana Julia Watts Belser si è occupata del rapporto tra etica ebraica e giustizia ambientale e rav Yonatan Neril nel suo Eco Bible si interroga su Torah ed ecologia. Sono molti però gli autori che hanno un pensiero eco-critico anche se non è quello l’obiettivo dichiarato dei loro testi: «Ho dedicato un corso intero a Il sistema periodico di Primo Levi, che è a tutti gli effetti un libro di scienze umane per l’ambiente scritto da un autore che molte pagine ha dedicato al rapporto tra umano e non umano. Nella nostra cultura il pensiero ecologico è molto più importante di quello che appare a un primo sguardo. Per Giorgio Bassani, che è stato anche cofondatore di Italia Nostra, l’attivismo ambientalista era una sorta di prosecuzione della Resistenza. Serenella Iovino ha dedicato a queste tematiche il suo 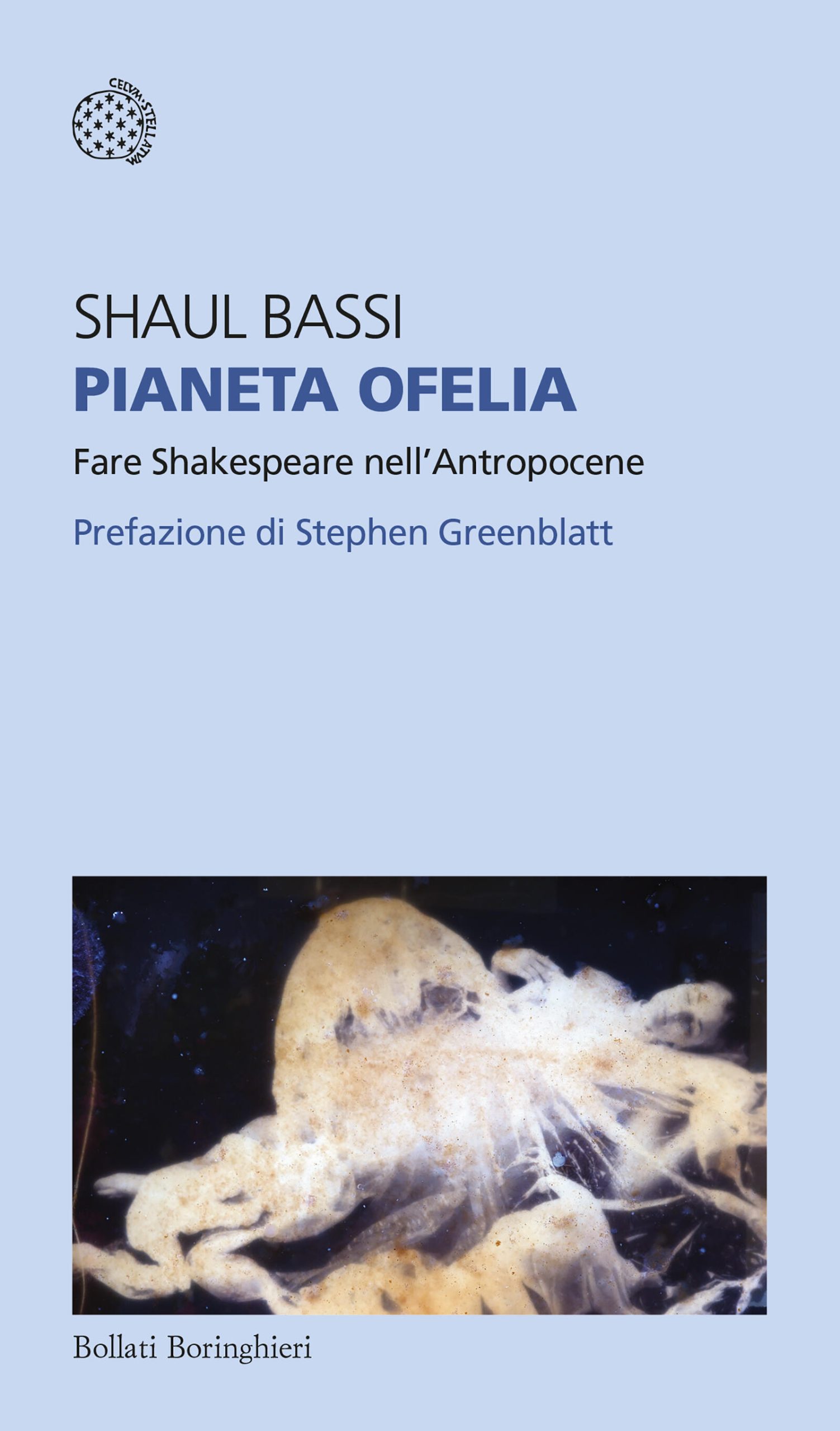 Ecologia letteraria. Una strategia di sopravvivenza e Paesaggio civile: Storie di ambiente, cultura e resistenza. Poi, ovviamente, non va dimenticato Italo Calvino». Shaul Bassi, dal canto suo, ha da poco pubblicato con Bollati Boringhieri Pianeta Ofelia. Fare Shakespeare nell’Antropocene, un libro che Stephen Greenblatt, nell’introduzione, definisce visionario, innovativo e audacemente sperimentale: «Mi occupo di Shakespeare da tempo e credo che i suoi testi contengano passi straordinari che possono aiutarci», spiega Bassi. «Ma bisogna lasciare da parte il timore reverenziale e “usarlo”. Bisogna metterlo in scena, ricrearlo, tradurlo, giocarci… non a caso il titolo del libro parla di “fare” Shakespeare. Un collega negli scorsi giorni mi raccontava di avere fatto una lezione su La tempesta a studenti texani che erano appena sopravvissuti a un uragano che ha distrutto le loro case. Ecco, le scienze umane per l’ambiente fanno convivere i corsi di materie scientifiche con la filosofia e la letteratura e non credo ci sia una strada migliore di questa: le storie ci aiutano quando siamo davanti a una cosa talmente enorme che fatichiamo a concettualizzarla. Abbiamo bisogno di racconti, romanzi, poesie, film e opere d’arte. Il Mercante di Venezia ci mostra un mondo sotto pressione, globalizzato, in cui non a caso si creano meccanismi potenti di disumanizzazione. Ed è un testo che non si finisce mai di scoprire, contiene riferimenti alle stagioni che cambiano e al rapporto con gli animali».
Ecologia letteraria. Una strategia di sopravvivenza e Paesaggio civile: Storie di ambiente, cultura e resistenza. Poi, ovviamente, non va dimenticato Italo Calvino». Shaul Bassi, dal canto suo, ha da poco pubblicato con Bollati Boringhieri Pianeta Ofelia. Fare Shakespeare nell’Antropocene, un libro che Stephen Greenblatt, nell’introduzione, definisce visionario, innovativo e audacemente sperimentale: «Mi occupo di Shakespeare da tempo e credo che i suoi testi contengano passi straordinari che possono aiutarci», spiega Bassi. «Ma bisogna lasciare da parte il timore reverenziale e “usarlo”. Bisogna metterlo in scena, ricrearlo, tradurlo, giocarci… non a caso il titolo del libro parla di “fare” Shakespeare. Un collega negli scorsi giorni mi raccontava di avere fatto una lezione su La tempesta a studenti texani che erano appena sopravvissuti a un uragano che ha distrutto le loro case. Ecco, le scienze umane per l’ambiente fanno convivere i corsi di materie scientifiche con la filosofia e la letteratura e non credo ci sia una strada migliore di questa: le storie ci aiutano quando siamo davanti a una cosa talmente enorme che fatichiamo a concettualizzarla. Abbiamo bisogno di racconti, romanzi, poesie, film e opere d’arte. Il Mercante di Venezia ci mostra un mondo sotto pressione, globalizzato, in cui non a caso si creano meccanismi potenti di disumanizzazione. Ed è un testo che non si finisce mai di scoprire, contiene riferimenti alle stagioni che cambiano e al rapporto con gli animali».
Nel capitolo del suo libro dedicato al Mercante e a Otello, Shaul Bassi scrive: «Shakespeare ci fa intravedere dei barlumi di possibilità, ma poi è in qualche modo portato a dare una risposta almeno superficialmente negativa. Come ci comporteremo noi quando i migranti climatici saranno sempre di più, quando da luoghi che sono stati resi inabitabili a causa della nostra insostenibile impronta ecologica si muoveranno masse ben più numerose di quelle già sfruttate e poi trasformate in capri espiatori dai governi più reazionari d’Europa?». E a voce risponde: «Sarebbe meglio fermarsi. E se potesse essere planetario… servirebbe uno shabbat».
Ada Treves
(Foto di Alexander Chekmenev)
