SCAFFALE – Nazismo e parossismo

La storiografia come scienza, com’è noto, è un’invenzione dell’età contemporanea, e si consolida come tale a partire dell’Ottocento e soprattutto nella prima metà del secolo scorso. L’antichità ha conosciuto molti grandi storiografi (Erodoto, Tucidide, Livio, Tacito e tanti altri), sulla base delle cui testimonianze cerchiamo di ricostruire ciò che è accaduto nel passato, ma le loro finalità erano del tutto diverse da quelle degli storici contemporanei, a partire dal fatto che era assente, dal loro bagaglio culturale, l’idea della ricerca e della rappresentazione della cosiddetta “verità dei fatti”. Quando, per esempio, narravano della fondazione di Roma, sapevano benissimo che si trattava di una vicenda leggendaria, mentre, se trattavano delle guerre puniche, sapevano di esporre fatti realmente accaduti. E di questa differenza erano perfettamente consapevoli anche i loro lettori. Ma nessuno, né gli scrittori né i lettori, avvertiva l’esigenza di avvertire o di essere avvertito della differenza tra verità e leggenda, perché la storiografia era essenzialmente una narrazione, un racconto, che serviva a determinati scopi, per lo più di tipo celebrativo o propagandistico, ma anche di altro tipo. Poteva essere quindi efficace o inefficace, avvincente o noiosa, ma non “vera” o “falsa”, perché, appunto, non era una scienza.
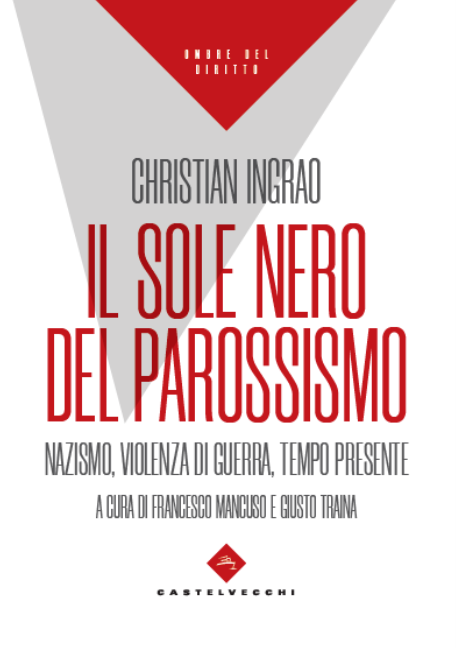 Quando lo è diventata, o ha cercato di diventarlo, si è dotata di strumenti analitici simili a quelli delle scienze esatte: obiettività, neutralità, obbligo di citare le fonti, di riferire il grado di attendibilità delle notizie riportate, di distinguere tra le ipotesi e le verità accertate, di indicare i possibili margini di errore e di probabilità, di dichiarare gli obiettivi e le finalità delle ricerche effettuate. Se in un romanzo storico lo scrittore può e deve inserire dei dati di fantasia in un quadro reale e documentato, lo storiografo non deve farlo, deve tenere a freno la fantasia. Può anche, come tutti, immaginare o ipotizzare che le cose siano andate in un certo modo, ma ha il dovere di avvertire il lettore che quelle che espone sono solo sue personali congetture.
Quando lo è diventata, o ha cercato di diventarlo, si è dotata di strumenti analitici simili a quelli delle scienze esatte: obiettività, neutralità, obbligo di citare le fonti, di riferire il grado di attendibilità delle notizie riportate, di distinguere tra le ipotesi e le verità accertate, di indicare i possibili margini di errore e di probabilità, di dichiarare gli obiettivi e le finalità delle ricerche effettuate. Se in un romanzo storico lo scrittore può e deve inserire dei dati di fantasia in un quadro reale e documentato, lo storiografo non deve farlo, deve tenere a freno la fantasia. Può anche, come tutti, immaginare o ipotizzare che le cose siano andate in un certo modo, ma ha il dovere di avvertire il lettore che quelle che espone sono solo sue personali congetture.
Ma potrà mai la storiografia diventare una “scienza esatta”, come la fisica o la matematica? L’I.A., forse, potrebbe cercare di avvicinarsi a un simile traguardo, ma appare molto improbabile che lo raggiunga, perché, se anche la historia rerum gestarum riuscisse a raggiungere il massimo livello raccolta e catalogazione dei dati e di minuziosa analisi e fredda esposizione degli stessi, non potrebbe mai ricostruire in modo scientifico i nessi eziologici degli eventi, per il semplice fatto che il suo oggetto di analisi, e cioè le res gestae, sono fondamentalmente dominate dall’irrazionalità e imperscrutabilità. I libri di storia, nello spiegare che la Rivoluzione americana è stata determinata dal desiderio di indipendenza dei latifondisti anglosassoni, quella francese dall’esigenza di affermazione del Terzo Stato, e quella bolscevica dalla miseria dei contadini e dal ruolo del partito-guida, trascurano sempre le pulsioni emotive, oscure e nascoste, alla base degli eventi. Non sapremo mai perché quello che è accaduto è accaduto, in quel luogo e in quel tempo, e cosa di diverso avrebbe potuto accadere. Leggendo un qualsiasi libro di storia, abbiamo sempre l’impressione che ciò che è avvenuto dovesse avvenire, ma ciò non è mai vero. Che due più due faccia quattro è una regola che vale solo per la matematica, nella storia il risultato di un’operazione non si potrà mai conoscere in anticipo.
Queste considerazioni mi sono state suggerite dalla lettura di un libro di grande importanza e interesse (come scritto sulla quarta di copertina, «un libro ‘di’ storia e ‘sulla’ storia»), apparso ora in una pregevole edizione italiana curata da Francesco Mancuso e Giusto Traina: Il sole nero del parossismo. Nazismo, violenza di guerra, tempo presente, di Christian Ingrao (Castelvecchi, Roma, pp. 260, euro 25).
Il volume prende in esame, in pagine di grande lucidità, il modo in cui l’analisi storiografia può cogliere e spiegare gli aspetti più tenebrosi della storia umana, che vengono ricondotti alla categoria del “parossismo” (che, annota Ingrao, «in cardiologia designa la sequenza più acuta di una patologia»), che non esattamente può essere fatta coincidere con il concetto di “violenza estrema” («se la violenza estrema è sempre parossistica – nota Mancuso, nella sua introduzione -, non tutto il parossismo si esprime come violenza»).
Vengono presi in esame il «volto oscuro dell’umano» come anche il fascino nero esercitato dalle cosiddette «comunità della morte», intendendo con tale espressione quelle formazioni umane volte a dare la morte non solo ai nemici, ma anche a loro stesse.
L’autore analizza il comportamento dei tedeschi e dei giapponesi alla fine della Seconda guerra come uno straordinario caso di «suicidio come uscita parossistica dalla guerra». Moltissimi soldati e anche civili dei due Paesi, com’è noto, scelsero di suicidarsi, anche quando avrebbero potuto salvare la vita e ottenere una resa onorevole, spesso togliendola anche ai loro congiunti, che avrebbero voluto vivere. «Ti prego, papà, non mi uccidere, non voglio morire», imploravano, come testimoniato, i bambini giapponesi. I loro non erano cattivi padri, li avevano educati amorevolmente, ma il parossismo imponeva di ignorare le loro implorazioni.
L’esperienza del nazismo e quella del militarismo nipponico restano diverse, da diversi punti di vista, ma hanno anche molti punti in comune, a partire dal culto della morte, e dalla sua capacità di divampare come un incendio, travolgendo ogni freno di tipo culturale o morale, ogni forma di pietà, dubbio, esitazione. Dare la morte a sé stessi, in certe circostanze, appare ancora più importante che darla ai nemici. Loro possono anche sopravvivere, noi no. E a suicidarsi possono essere non solo individui, ma anche popoli, nazioni civiltà.
Un libro che fa molto riflettere, soprattutto di questi tempi, e che offre anche, a mio avviso, delle chiavi di lettura originali del morbo antisemita (che, com’è tristemente noto, porta sovente alla voluta distruzione anche di chi lo nutre e propaga). Un volume che ammonisce a tenere presente che gli eventi storici vanno letti e interpretati con l’uso della ragione, ma ricordando sempre che gli stessi sono scatenati, molto spesso, da forze irrazionali.
Francesco Lucrezi, storico
(Nell’immagine in alto: ufficiali giapponesi ispezionano la linea Maginot)
