LIBRI – Riflessioni sull’uguaglianza, fra Costituzione e tradizione ebraica
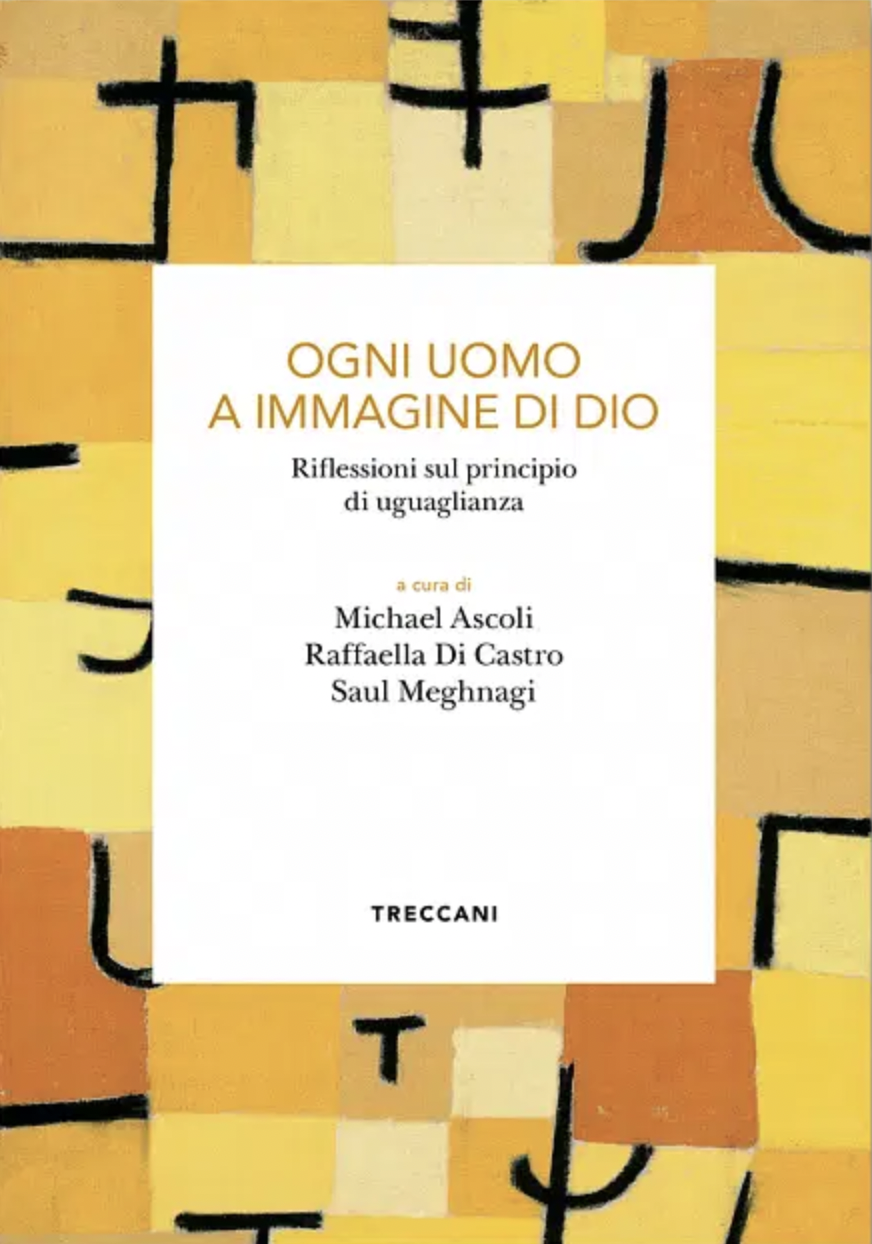
Si interroga in primis su “Religione, laicità e democrazia” la raccolta di saggi Ogni uomo a immagine di Dio (ed. Treccani) da oggi in libreria a cura di Michael Ascoli, Raffaella Di Castro e Saul Meghnagi. Nel libro sedici riflessioni «sul principio di uguaglianza» prendono le mosse dal progetto “Articolo 3 – Diversi tra uguali” promosso dall’Ucei attorno a uno degli articoli fondamentali della Costituzione, cardine del principio che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Tra le pagine di Ogni uomo a immagine di Dio il concetto è declinato da giuristi, rabbini, sociologi ed educatori anche alla luce degli insegnamenti della tradizione ebraica. Insegnamenti cari anche agli stessi curatori: Michael Ascoli, ingegnere e rabbino, è stato docente al Collegio rabbinico italiano e insegna al Diploma universitario triennale in Studi ebraici dell’Ucei. Di Castro, filosofa, è responsabile all’Unione per il Giorno della Memoria e la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Saul Meghnagi, pedagogista, coordina la Commissione Cultura dell’ente.
«Ogni uomo a immagine di Dio», ricordano nell’introduzione, è la formula classica con la quale l’ebraismo «sottolinea la responsabilità che ogni uomo reca con sé; afferma il diritto intrinseco al rispetto di ogni vita umana; rende esplicito il principio di uguaglianza fra tutti gli uomini, ciascuno nella sua irriducibile specificità». Ciò viene fatto sin dal racconto biblico della Creazione per arrivare alla filosofia ebraica del Novecento, passando dai commentari rabbinici antichi e moderni. Con riflessi quindi sia religiosi sia “laici”, la locuzione scelta per avviare l’impegno editoriale «consolida la consapevolezza che i doveri siano un complemento, se non addirittura una premessa necessaria dei diritti, piuttosto che in opposizione a questi».
I saggi sono stati suddivisi in tre sezioni. Se nella prima si riprende la strada tracciata dal progetto Ucei, nella seconda si analizzano le sfide aperte nell’Italia di oggi e nella terza si gettano alcuni “sguardi ebraici” sull’uguaglianza. Il libro è aperto da un’introduzione dell’ex ministro della Cultura Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana. Bray richiama l’urgenza di «riscoprire e diffondere l’importanza dei valori che sono alla base del nostro vivere civile e del processo di costruzione del senso di comunità che ci unisce nel rispetto delle specificità e differenze di ciascuno». È necessario, rileva, anche per la crescente intolleranza verbale e fisica e per il manifestarsi di «veri e propri attentati all’ordine pubblico e alla vita di tanti cittadini innocenti». Uniti nella diversità: le sedici riflessioni sono una miniera di spunti in questo senso. Come ricorda tra gli altri Meghnagi, «la storia degli ebrei è segnata da periodi di sofferenza e di dolore, ma è stata anche fonte di sensibilità politica e culturale». Per questo, aggiunge, è possibile «non cedere al pianto e alla chiusura in se stessi, ma perseguire il conseguimento di quell’uguaglianza per la quale hanno lottato, nel nostro paese, ebrei e non ebrei». Guardando alla storia degli ebrei in Europa, sostiene il rabbino Roberto Della Rocca in un suo scritto su identità e alterità, «appare evidente come uno degli elementi di forza sia stata la capacità di contribuire alla cultura dominante e al tempo stesso di attingere all’esterno» insieme alla capacità «di seminare e raccogliere, di restare se stessa, ideando di volta in volta risposte nuove» e di essere una minoranza «che lotta per la sopravvivenza e il rispetto di culture e condizioni di minoranza».
Le differenze esistono, ricorda il rav. «Ed è l’interazione fra di esse a generare progresso e cultura».
Adam Smulevich
