SCAFFALE – Francesco Lucrezi: L’attualità di Maimonide

L’editrice Giuntina, tra i suoi tanti meriti, ha anche quello di procedere da decenni a una preziosa opera di divulgazione e interpretazione del pensiero di Maimonide, che ha permesso a vaste fasce di lettori di entrare a contatto con la imponente produzione del grande scienziato, filosofo, giurista, teologo, medico, astronomo, mistico, esegeta (ma ognuna di queste definizioni è indubbiamente riduttiva), considerato, da una parte, il massimo sintetizzatore ed espositore dell’interpretazione rabbinica medievale del Ta-Na-K, e, dall’altra, il punto di partenza per la costruzione delle successive categorie ermeneutiche, che avrebbero cominciato a essere elaborate subito dopo di lui.
Alla Giuntina si deve l’edizione, in versione italiana, di alcuni dei testi principali del Rambàm, sfociati in volumi di grande interesse, quali Ritorno a Dio. Norme sulla Teshuvà (2004), Gli otto capitoli. La dottrina etica (2017), Norme di vita morale. Hilkòt de’ot (2018), Norme sullo studio. Hilkòt Talmud Torà (20220), Norme sui fondamenti della Torà. Hilkòt ha Torah (2023), Norme suyll’idolatria. Hilkòt ‘avodà Zarà (2024). Tra i molti studi dedicati alla figura del grande pensatore, inoltre, è stato pubblicato, nel 1999, il volume di Yeshayahu Leibowitz Lezioni sulle “Massime dei padri” e su Maimonide.
Questa preziosa serie di libri di e sul Rambàm si arricchisce adesso di un testo di grande profondità e interesse, quale l’ampio studio della filosofa Irene Kajon, Attualità di Maimonide. La guida dei perplessi sulla condizione umana (Firenze, La Giuntina, 2024, pp. 374, 2025, 20 euro). Oggetto del volume non è solo l’analisi dei contenuti della speculazione del filosofo (che, com’è noto, abbracciò tutti i temi ‘ultimi’ della condizione umana, non solo ebraica, quali la verità, la giustizia, la divinità, la pace, l’amore), ma anche la lettura che delle sue opere è stata data da alcuni grandi pensatori dell’Ottocento e del Novecento, quali Samuel Hirsch, Samuel Luzzatto, Elia Benamozegh (il quale, in particolare, trasse grande ispirazione dalle pagine del Rambàm per la costruzione della sua moderna concezione del noachismo), Dante Lattes, Hermann Cohen, Leo Strauss. In quanto investigazione sull’approccio al pensiero di Maimonide nell’età contemporanea, il libro rappresenta, pertanto, anche una riflessione sul rapporto tra ebraismo e modernità, che in larga misura coincide con l’irradiazione della parola del Rambàm nel mondo moderno.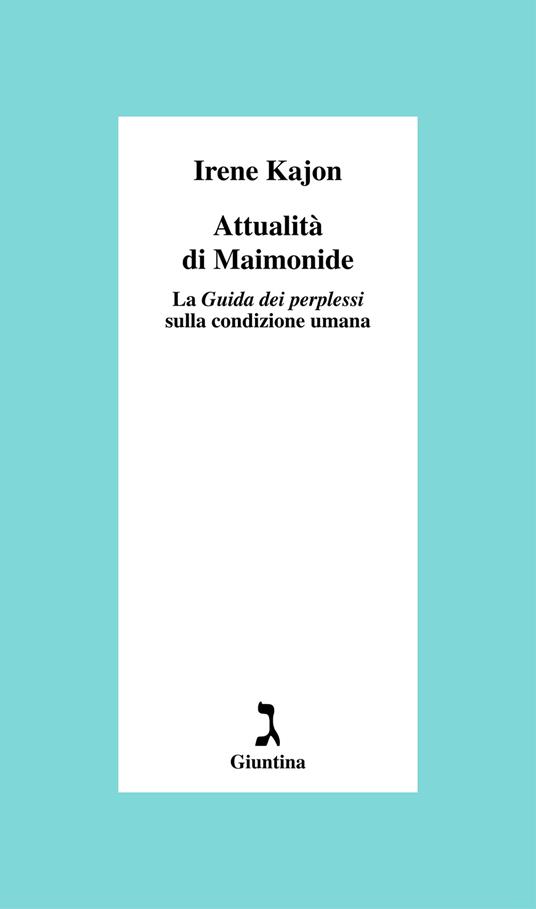 Come accade a tutti i grandi, anche il pensiero di Maimonide è stato oggetto di continue reinterpretazioni, che hanno di volta in volta cercato di adattarlo alle nuove esigenze dei tempi mutati. Questo lavoro di aggiornamento e adattamento, nel caso del pensatore, è stato particolarmente sottile e delicato, sia perché, per la sua indiscutibile autorità, nessuno si è mai azzardato a dire in cosa egli possa avere “sbagliato” («tra Mosè e Mosè – recita il noto detto – non c’è stato nessuno grande come Mosè»: e ciò vale anche per gli otto secoli successivi), sia perché scopo costante della sua ricerca fu sempre quello di fissare un indirizzo dell’azione umana, di definire gli argini che essa non deve e non può oltrepassare, per rispetto non solo alla Torah, ma anche alla stessa identità umana, bisognosa, per sua stessa natura, di libertà nel pensiero, ma di limiti nei comportamenti. La definizione di quali siano questi limiti, nell’età moderna, è profondamente cambiata, come anche l’idea di quale possa essere la loro origine, la loro sorgente. Ma la necessità della loro ricerca e comprensione non può mai venire meno, ed è anche questo che spiega – come si evince dal libro della Kajon – la perenne «attualità di Maimonide».
Come accade a tutti i grandi, anche il pensiero di Maimonide è stato oggetto di continue reinterpretazioni, che hanno di volta in volta cercato di adattarlo alle nuove esigenze dei tempi mutati. Questo lavoro di aggiornamento e adattamento, nel caso del pensatore, è stato particolarmente sottile e delicato, sia perché, per la sua indiscutibile autorità, nessuno si è mai azzardato a dire in cosa egli possa avere “sbagliato” («tra Mosè e Mosè – recita il noto detto – non c’è stato nessuno grande come Mosè»: e ciò vale anche per gli otto secoli successivi), sia perché scopo costante della sua ricerca fu sempre quello di fissare un indirizzo dell’azione umana, di definire gli argini che essa non deve e non può oltrepassare, per rispetto non solo alla Torah, ma anche alla stessa identità umana, bisognosa, per sua stessa natura, di libertà nel pensiero, ma di limiti nei comportamenti. La definizione di quali siano questi limiti, nell’età moderna, è profondamente cambiata, come anche l’idea di quale possa essere la loro origine, la loro sorgente. Ma la necessità della loro ricerca e comprensione non può mai venire meno, ed è anche questo che spiega – come si evince dal libro della Kajon – la perenne «attualità di Maimonide».
Mi permetto di aggiungere alle molte stimolanti osservazioni dell’autrice un’importante annotazione, di cui nel libro non si poteva fare menzione, per il semplice fatto che è stata esposta lo scorso giovedì sei maggio in un intervento – intitolato Cosa vuol dire essere sionisti oggi – svolto da Rav Michael Ascoli nel Moked organizzato dal Dipartimento Educazione e Cultura dell’UCEI a Diamante. Il rav ha spiegato come il pensiero dei Maimonide rappresenti un importante punto di riferimento, tra l’altro, anche per la concezione religiosa e identitaria nel sionismo. Nelle 613 mitzvòt elencate nel Sefer ha-mitzvòt, infatti, non figura l’obbligo per l’ebreo di risiedere in ‘Erez Israel. Ma il Nachmanide (detto Rambàn, da distinguere dal primo, com’è noto, per l’ultima lettera dell’acronimo), nel suo testo di aggiunte al trattato del suo predecessore, specificò che tra i precetti figura anche quello di «prendere possesso della Terra che Dio ha dato ai nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe, e di non abbandonarla in mano ad altri popoli né lasciarla desolata». È oggetto di discussione, però, se questo precetto implichi una vera e propria mitzvà di risiedere nella Terra promessa, o semplicemente un dovere di prendersene cura, anche vivendo fuori di essa. Il Nachmanide sposò la prima idea, Maimonide sembra avere invece optato per la seconda, anche se, ha ricordato Rav Ascoli, per lui la dimora in Terra d’Israele rappresentava comunque un completamento dell’identità ebraica. E, anche se morì in Egitto, lasciò espresso desiderio di ricevere sepoltura nella terra dei padri, ove, a Kinneret, riposa.
Tra i suoi mille insegnamenti c’è anche, quindi – dato col concreto esempio -, quello dell’importanza del ritorno a Sion, ossia del sionismo.
Francesco Lucrezi, storico
