SCAFFALE – Il grande frastuono

Il verso di Geremia (10.22) “Si ode un rumore che avanza e un grande frastuono” è stato scelto da Roy Chen come titolo del suo romanzo Il grande frastuono (ed. originale: Ra’ash gadol, Tel Aviv 2023, ed. italiana Giuntina, Firenze, 2025, pp. 274, euro 20).
Non sono un critico letterario, e in genere non ho la presunzione di esprimere giudizi sul valore artistico delle opere narrative di fantasia, ma stavolta mi sbilancio, e mi azzardo a dire che l’autore, giovane scrittore, traduttore e drammaturgo israeliano (nato a Tel Aviv nel 1980, in una famiglia di origini sefardite) è davvero uno di quei rari narratori in grado di allargare l’anima, di aprire nuove, inaspettate finestre su ignoti e inesplorati terreni della natura umana. Questo suo ultimo romanzo è un vero capolavoro, un libro in grado di divertire, commuovere e turbare. I piani di lettura possono essere diversi, ma il messaggio principale che mi pare emergere dalle pagine è quello di una inquietante interrogazione sul mistero della conoscibilità (da parte degli altri, ma anche di noi stessi) dell’animo umano.
È possibile conoscere davvero qualcuno? Anche se di lui crediamo di sapere quasi tutto, tutto quello che fa e dice, anche se abbiamo visto questa persona crescere e cambiare accanto a noi, magari anche fin dal suo concepimento? O è invece possibile che tutto quello che sappiamo sia illusorio, o comunque lontanissimo da una “verità” destinata a restare per sempre inaccessibile? 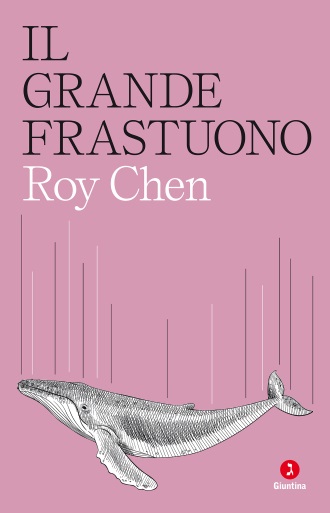 Protagoniste del romanzo sono tre donne di diverse generazioni, una madre di 66 anni, una figlia di 40 e una nipote di 16, che vivono in una caotica e chiassosa Tel Aviv dei giorni d’oggi, segnata da diffusa ansia, rabbia, frustrazione, agitazione. Le tre donne sono completamente diverse. La ragazza, Gabriela, è ipersensibile, sognatrice, insicura, silenziosa, complessata. Sua madre, Noa, è frenetica, iperattiva, logorroica, invadente, straripante. La nonna, Tzipora, è lunatica, isterica, polemica, scostumata, mezza matta.
Protagoniste del romanzo sono tre donne di diverse generazioni, una madre di 66 anni, una figlia di 40 e una nipote di 16, che vivono in una caotica e chiassosa Tel Aviv dei giorni d’oggi, segnata da diffusa ansia, rabbia, frustrazione, agitazione. Le tre donne sono completamente diverse. La ragazza, Gabriela, è ipersensibile, sognatrice, insicura, silenziosa, complessata. Sua madre, Noa, è frenetica, iperattiva, logorroica, invadente, straripante. La nonna, Tzipora, è lunatica, isterica, polemica, scostumata, mezza matta.
Le tre, a modo loro, si vogliono bene, e le loro vite sono strettamente collegate. Ma, in realtà, nessuna delle tre mostra di conoscere i sentimenti delle altre due. Per esempio, Gabriela intreccia – tra mille esitazioni, paure, palpitazioni – un timido accenno di storia d’amore, la prima della sua vita, con un compagno di classe, geniale e ribelle, dal carattere chiuso e ombroso, e affetto da disturbi psichici. Il dirompente sentimento stravolge l’esistenza della ragazza, facendo esplodere in lei emozioni laceranti, che però non condivide con nessuno, non facendo parola con alcuno della sua esperienza.
Quando il giovane, senza nessun segno premonitore, si toglie la vita, Gabriela non manifesta in nessun modo il suo sgomento, scegliendo di custodire solo nel cuore, per sempre, il suo straziante segreto. Tutti i compagni di classe del ragazzo scomparso, insieme ai loro genitori, partecipano al lutto; tutti tranne Gabriela, che mostra di non dare alcun rilievo a quanto accaduto. Noa se ne compiace, pensando che sua figlia, già psicologicamente fragile, non sia stata colpita da questa tragedia, e che ciò, per lei, sia un bene. Noa ama sua figlia, è quella che si può definire una buona madre, ma, in realtà, non sa nulla di lei. E, allo stesso modo, mostra di non avere capito nulla di sua madre, Tzipora, della quale guarda con fastidio le intemperanze e le bizzarrie, senza curarsi di decifrare lo straordinario patrimonio emotivo che si cela dietro di esse. Tzipora sembra dotata di doti intuitive al limite del paranormale, tanto da apparire una vera e propria profetessa, ma esse non sono in alcun modo apprezzate dalla figlia, che, in realtà, non sa nulla di lei.
Il “grande frastuono” descritto nel volume è quello dei tumultuosi, disordinati, contraddittori sentimenti che affollano i cuori delle tre protagoniste, come anche quello del “balagàn” delle strade di Tel Aviv e Gerusalemme, dove si agita un’umanità tesa, irascibile, nevrotica, che sembra non credere più in niente. Ma è un frastuono silenzioso, dal momento che nessuno conosce nessuno, tutti sentono solo il rumore, ma senza curarsi di quali speranze, delusioni, dolori siano ad esso sottesi.
Anche il lettore, alla fine del romanzo, ha la sensazione di non conoscere le anime delle protagoniste, coperte dal “grande frastuono”. Cosicché la lettura del romanzo ci fa sorgere una domanda riguardo a un possibile cambiamento, ai giorni nostri, della stessa funzione della letteratura. Leggendo Omero, Sofocle, Virgilio, Dante, perfino Kafka, ci sembra di “conoscere” i personaggi di Achille, Ulisse, Edipo, Enea, Francesca, Samsa. Ci riesce magari difficile interpretare le storie e le tragedie in cui sono calati, ma abbiamo l’impressione di capire le loro scelte, le loro azioni, il loro destino. Ma, forse, ciò poteva accadere nel tempo della parola, che perfora il silenzio. Ma, nell’epoca del frastuono, forse, non c’è più silenzio e, quindi, neanche parola. Comunicare, e conoscere, è quindi, forse, impossibile.
Francesco Lucrezi, storico
