LIBRI – Dal Sinai alla Knesset in 11 capitoli
Un saggio che è anche un manuale per muoversi all’interno della storia del popolo ebraico e dei suoi testi sacri, una guida per capire la centralità della Torah, il suo processo di scrittura e il rapporto che corre fra la stessa Legge rivelata, testo centrale per il popolo ebraico, e altre raccolte come Neviim (il libro dei Profeti) e Ketuvim (gli Scritti).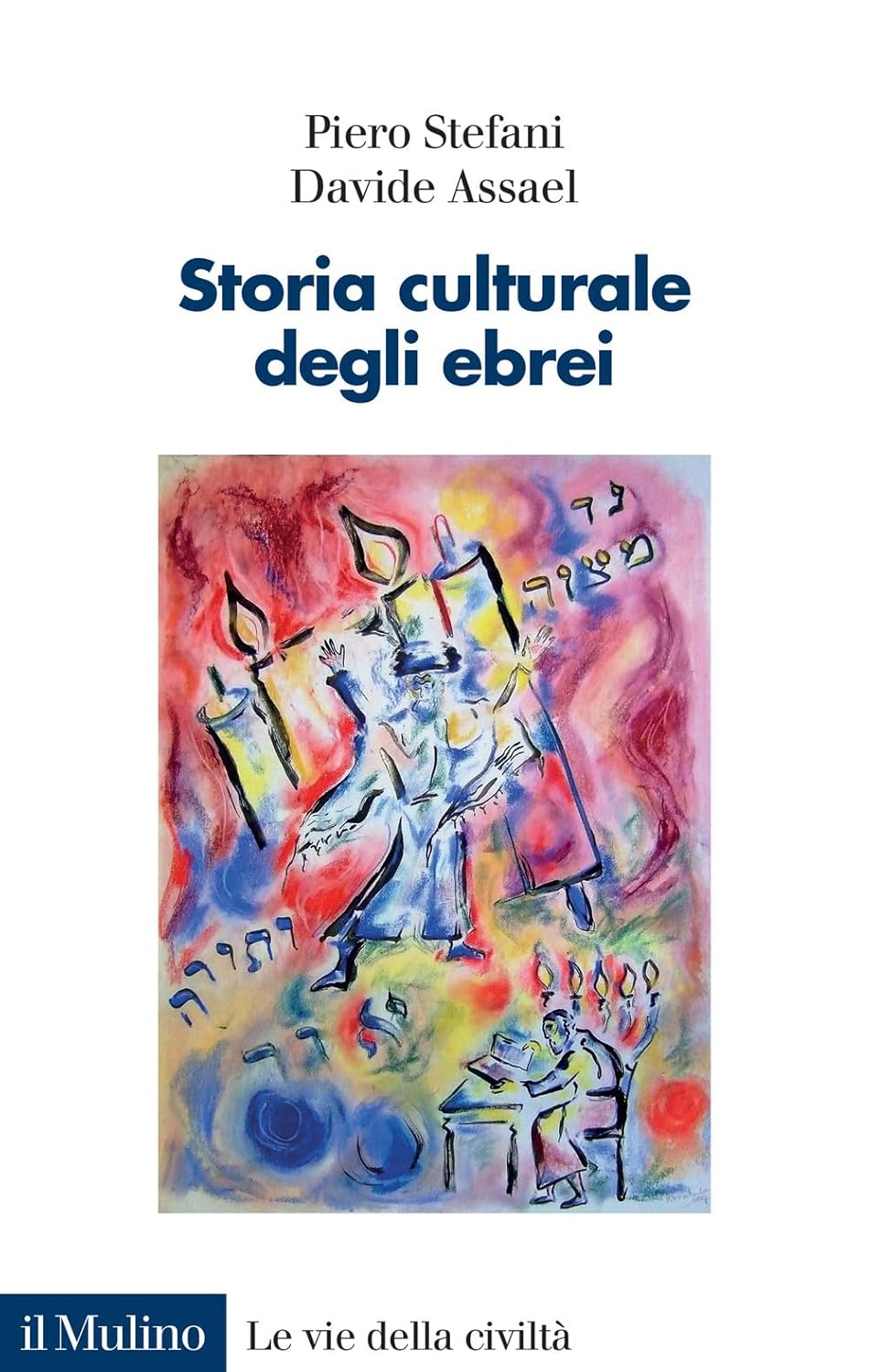
Storia culturale degli ebrei (Il Mulino, 2024) di Piero Stefani e Davide Assael non è però solo una bussola per la navigazione interna al mare magnum del Tanakh (l’acronimo che indica la Bibbia ebraica, ossia l’insieme di Torah, Neviim e Ketuvim): se è interessante riscoprire che «secondo la successiva tradizione rabbinica, questi testi, tutti ritenuti composti in epoche posteriori ai cinque libri di Mosè, si presentano anzitutto come inviti a ritornare alla Torah per poterne cogliere tutta la ricchezza», non meno interessante è riscoprire le «risonanze universalistiche legate alla Torah» in virtù di un Tanakh che non dimentica «il ruolo attribuito nella ricostruzione del Santuario al non ebreo Ciro. Nella Bibbia tripartita l’ultima parola spetta, per così dire, a un re persiano; non solo, è proprio questo riferimento ad aprire alla speranza di ritornare alla pienezza del culto».
Da Mosè – la cui assenza nel racconto dell’esodo dall’Egitto (la Haggadah) è spiegata dagli autori – a Ciro, alla millenaria condizione diasporica del popolo ebraico (il capitolo Abitare in casa di altri), il saggio galoppa fra i secoli analizzando gli effetti di alcune date chiave per gli ebrei, come il 1492, anno dell’espulsione (il Gherush) dalla Spagna e i suoi territori, passando per il secolo dei totalitarismi fino ad arrivare al 1948, la fondazione dello Stato d’Israele.
Ma poiché non si tratta di un manuale di storia ma di storia culturale è particolarmente interessante vedere come i due autori si soffermino non solo sull’evoluzione dei testi, del dibattito e delle correnti interne all’ebraismo ma si producano in un costante esercizio di analisi dei rapporti fra il mondo degli ebrei con quello dei “gentili”: dalla diversa sistemazione e funzione di alcuni testi dei Profeti nel Tanakh e nel Nuovo Testamento a come il messianismo ebraico abbia contaminato e plasmato le altre fedi e culture. E viceversa: a seguito dell’ellenizzazione del Medio Oriente aperta dalle conquiste di Alessandro Magno, «tra la civiltà ebraica e quella greca avvenne un confronto da cui scaturirono due alternative principali: o l’assorbimento o la radicalizzazione delle posizioni presenti nei due ambiti».
E così avanti nei secoli a osservare gli effetti rivoluzionari dell’emancipazione ebraica in Europa: chi scelse la via della riforma nel tentativo di modernizzare l’antica identità ebraica, chi tentò di valorizzare gli ideali universalistici dell’ebraismo aderendo al socialismo e chi scelse la via del sionismo, spiegano gli autori. «Fuori da queste tre opzioni rimane solo la completa assimilazione alla società ospitante».
Un testo denso che compensa la difficoltà di alcuni passaggi con un linguaggio pulito ma che soprattutto ha il pregio dell’attualità: il libro non si ferma con la nascita di Israele ma ne studia l’evoluzione politica e religiosa e l’intreccio fra religione, lingua e identità nazionale. Per interrogarsi tanto sulla Legge della nazione approvata dalla Knesset nel 2018 quanto sulle sfide future dello Stato d’Israele.
