Storia dell’ebraismo mitteleuropeo
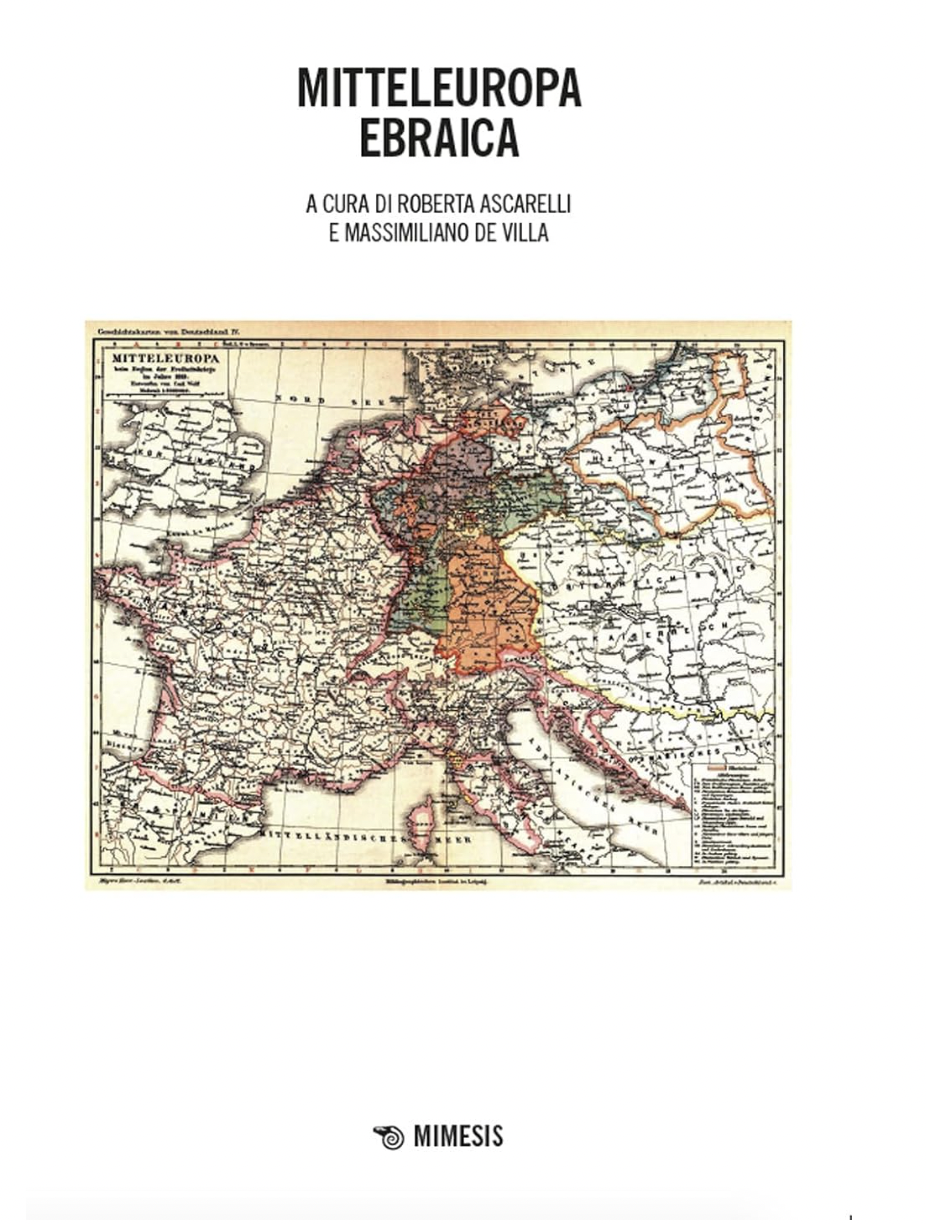 Testimonianze autobiografiche, testi letterari, articoli su quotidiani e periodici. Sono le fonti dalle quali hanno attinto gli autori dei saggi del volume Mitteleuropa ebraica (ed. Mimesis), un affascinante viaggio in quel mondo “di mezzo” segnato dall’esperienza ebraica in molte, e a volte contraddittorie, declinazioni. Vale ancora la pena parlarne, vale ancora la pena confrontarsi con quel retaggio, sostengono i curatori dell’opera: Roberta Ascarelli e Massimiliano De Villa premettono che «la storia dell’ebraismo mitteleuropeo pone problemi di ampio spettro, toccando questioni legate ai confini, alle migrazioni, alle delocalizzazioni e offrendo così la possibilità di una proiezione critica su fenomeni più attuali».
Testimonianze autobiografiche, testi letterari, articoli su quotidiani e periodici. Sono le fonti dalle quali hanno attinto gli autori dei saggi del volume Mitteleuropa ebraica (ed. Mimesis), un affascinante viaggio in quel mondo “di mezzo” segnato dall’esperienza ebraica in molte, e a volte contraddittorie, declinazioni. Vale ancora la pena parlarne, vale ancora la pena confrontarsi con quel retaggio, sostengono i curatori dell’opera: Roberta Ascarelli e Massimiliano De Villa premettono che «la storia dell’ebraismo mitteleuropeo pone problemi di ampio spettro, toccando questioni legate ai confini, alle migrazioni, alle delocalizzazioni e offrendo così la possibilità di una proiezione critica su fenomeni più attuali».
Entrambi docenti universitari, Ascarelli ha all’attivo saggi su Joseph Roth e Stefan Zweig, mentre De Villa ha scritto, tra l’altro, di Martin Buber, Paul Celan e Franz Rosenzweig.
Da Vienna a Praga, da Leopoli a Trieste, da Cracovia a Czernowitz, da Budapest a Lubiana. Tra le pagine di Mitteleuropa ebraica si raccontano tante storie distinte e intrecciate: i grandi salotti intellettuali di quelle città di cultura; i fermenti dell’Haskalah, il cosiddetto “illuminismo ebraico”; le istanze contrapposte del movimento chassidico a trazione pietistica. Sempre in bilico tra cosmopolitismo e piccole patrie, la Mitteleuropa fu terra anche in parte yiddish.
«Lingua sotterranea, lingua di famiglia, lingua segreta», come spiega Simona Leonardi nel suo contributo sulla mameloschen e le migrazioni dall’Europa orientale verso la Germania.
Sempre in tema, scopriamo con Guido Massino alcune vicende di attori del teatro yiddish «tra la Galizia e Budapest nello specchio di Kafka». Grazie a Ester Saletta entriamo nella Mitteleuropa viennese «dalle profonde radici sefardite» della poetessa Veza Canetti, moglie del futuro Premio Nobel per la letteratura Elias, anche lui plasmato da quelle origini.
In evidenza tra tanti temi ci sono anche le «cronache dall’Europa centro-orientale» di Joseph Roth, che nel suo Ebrei erranti del 1927 fotografò gli ultimi momenti di vita di un mondo prossimo all’abisso, oltre alla trasposizione del mito del Golem sul grande schermo.
È un tuffo in un passato complesso, in un “mondo di ieri” che non ha esaurito il suo serbatoio di stimoli. Secondo Ascarelli e De Villa, «la Mitteleuropa come mito moderno dai caratteri politicamente sfuggenti, ma dal grande fascino culturale, ha ancora oggi la capacità di porre interrogativi sul rapporto tra centro e periferia imponendo un ripensamento, anche radicale, dei concetti di transculturalità e transnazionalità».
Un ripensamento che a detta dei curatori «investe le contraddizioni dell’Europa contemporanea, interrogando forme di identità apparentemente monolitiche, collegate a confini territoriali, linguistici, etnici o religiosi».
