SOCIETÀ – Chi decide chi è ebreo
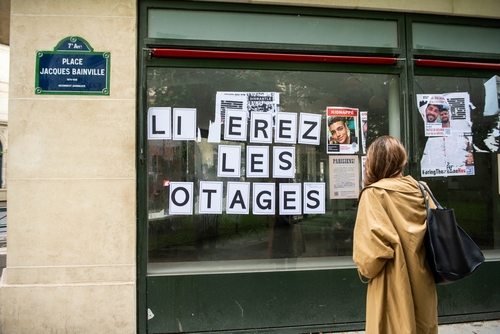
Dopo il 7 ottobre 2023 l’Ose – organizzazione ebraica di assistenza medico-sociale nata a inizio Novecento a Parigi – ha attivato una linea telefonica per offrire sostegno a chi debba fare i conti con l’antisemitismo che attraversa la società francese. Da qui prende avvio il testo di Alain Ksensee, psichiatra e psicoanalista, pubblicato il 29 settembre su Tribune Juive con il titolo “Ce n’est pas l’antisémitisme qui fait le Juif”, ossia “non è l’antisemitismo che fa l’ebreo”. Le testimonianze raccolte non si limitano a denunciare aggressioni o insulti, ma rivelano come l’antisemitismo agisca in profondità insinuandosi nella percezione di sé e trasformando l’identità ebraica. Dai racconti emergono episodi che portano in sé una violenza radicale: dalla vicina che deride la mezuzah attaccata a una porta all’interlocutore che dichiara che «dei Giudei non si vuole nemmeno l’esistenza». Non è soltanto l’esperienza della discriminazione a segnare chi parla, ma la percezione di una volontà di cancellazione: Ksensee individua qui il cuore di un antisemitismo che non si limita a respingere l’altro ma lo priva del diritto stesso a esistere. Con gli strumenti della fenomenologia e della psicoanalisi l’autore mostra come l’identità ebraica, sotto l’urto dell’ostilità, finisca per essere definita dall’esterno: non è più il soggetto a scegliere come vivere il proprio essere ebreo, ma lo sguardo dell’altro a imporre un contorno rigido e stigmatizzato. È un movimento che non discrimina soltanto: vuole rendere invisibile. Da qui nasce la rabbia che si avverte nei racconti, un segnale di resistenza, rifiuto dell’assegnazione, forza di negare a chi odia il potere di stabilire un’identità dall’esterno. Ksensee chiede cosa significhi essere ebreo in Francia oggi: non esiste una definizione unica, religiosa o culturale: l’identità è instabile, frammentata, attraversata da contraddizioni, soprattutto nel rapporto con Israele, che genera tensioni e incomprensioni. Questa instabilità però apre uno spazio in cui sottrarsi alla riduzione, rifiutare l’assegnazione dell’antisemita non significa ripiegarsi in un’identità chiusa, ma riaffermare la pluralità delle appartenenze, restituire valore al fatto di essere insieme ebrei e francesi senza consentire che l’una appartenenza annulli l’altra. La resistenza comincia nella scrittura di sé, nella capacità di nominarsi, di dire il proprio essere senza cedere alla definizione imposta. L’antisemitismo non fa l’ebreo, conclude Ksensee, l’ebreo si definisce da sé, nel rapporto con la storia e con la memoria, nella capacità di custodire il presente senza lasciarsi espropriare dall’ostilità.
