Davar acher – La Memoria e le semplificazioni
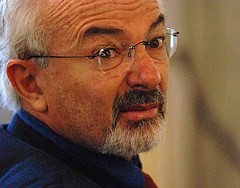 Mi sembra molto significativo che nel mondo ebraico italiano si ricominci a discutere di memoria non in relazione alla giornata dedicata, che suscita sempre qualche incertezza, ma a preoccupazioni politiche attuali, per cui si invoca la memoria come rimedio. Il tema della memoria è stato molto vivo in questi anni nel dibattito delle scienze umane: la memoria come fatto collettivo oltre che individuale (Halbwachs), la memoria come movimento collettivo di natura teologico-politica (Assman), la memoria come pratica e come costruzione di significanti, come tecnologia pedagogica (a questo tema è stato dedicato un congresso dell’associazione di studi semiotici un paio d’anni fa a Bologna), la contrapposizione fra memoria e storia (Nora), ecc.
Mi sembra molto significativo che nel mondo ebraico italiano si ricominci a discutere di memoria non in relazione alla giornata dedicata, che suscita sempre qualche incertezza, ma a preoccupazioni politiche attuali, per cui si invoca la memoria come rimedio. Il tema della memoria è stato molto vivo in questi anni nel dibattito delle scienze umane: la memoria come fatto collettivo oltre che individuale (Halbwachs), la memoria come movimento collettivo di natura teologico-politica (Assman), la memoria come pratica e come costruzione di significanti, come tecnologia pedagogica (a questo tema è stato dedicato un congresso dell’associazione di studi semiotici un paio d’anni fa a Bologna), la contrapposizione fra memoria e storia (Nora), ecc.
Da tutto questo lavoro intellettuale, che non ho modo di riassumere qui, emerge con forza il carattere politico, “caldo”, che è proprio della memoria, la sua forte valenza identitaria. Produrre (e conservare) una memoria condivisa vuol dire stabilire un’identità, fondarla su valori, proporre delle dinamiche esemplari. In questo la tradizione ebraica è stata maestra. La Torah ha una dimensione memoriale, molto più che storica; la nostre feste sono costruite in maniera tale da “insegnare”, sottolineando certi aspetti dell’esperienza collettiva del popolo di Israel invece di altri. Un esempio chiarissimo è il modo in cui in questi giorni “non” ricordiamo la guerra dei Maccabei contro la dominazione greca e contro gli ebrei ellenizzanti (che fu dunque in buona parte una guerra civile, come sottolinea con forza Leibowitz), ma ci soffermiamo piuttosto sul miracolo dei lumi.
I maestri che stabilirono la festa, già probabilmente riconoscibili nella linea farisea, scelsero di non sottolineare la guerra e la monarchia asmonea che ne derivò, ma un simbolo della continuità che consideravano già evidentemente miracolosa della nostra identità culturale e religiosa. Un discorso analogo si può fare con altre ricorrenze come Pesach e Purim o Tishà beAv, rispetto a cui abbiamo meno fonti storiche, ma che sono tutte celebrate in modo da generare memoria, cioè insegnamento. Su Purim, fra l’altro, abbiamo tracce forse pedagogiche anche loro di una discussione, forse di un negoziato fra i protagonisti e i maestri della Mishnà, che decisero di inserirne la cronaca (memoriale più che storica) nelle Scritture. Per altre circostanze non vi sono feste: la conquista di Gerusalemme, l’impero di David, la fondazione del Tempio, per esempio. Ma sono scarse anche le tracce rituali di grandi catastrofi dopo la caduta del Tempio, come le persecuzioni dei crociati, la cacciata di Spagna, i pogrom cosacchi del Seicento, per cui pure erano stati proposti dei rituali. E vi è una certa difficoltà a trovare una dimensione liturgica adeguata per la memoria della Shoà e dello Stato di Israele, anche se diverse pratiche si sono diffuse .
Naturalmente la memoria non passa solo per la dimensione liturgica, anche se tende a inventare liturgie pure quand’è civile: si pensi ai riti connessi in Italia al 25 aprile, al 2 giugno, fino a qualche anno fa al 4 novembre e ai fenomeni analoghi negli altri paesi. Gli esempi che ho appena fatto, di date scelte per celebrare la memoria con appositi rituali, sono molto tipici della coltivazione della memoria, insieme ad altri dispositivi come monumenti, musei, canzoni, spettacoli; ma almeno alcune segnalano anche il fatto che la memoria, quando perde d’attualità o di funzione identitaria, tende a svanire e le feste che la ricordano finiscono col perdere senso.
Una memoria artificiale regge meno di una traccia autentica e profonda nella cultura collettiva. E qui vi è un altro punto, decisivo: una memoria identitaria è una narrazione che identifica un certo soggetto collettivo, marca dei confini; nel momento in cui questa capacità di distinzione cade, anche la memoria perde forza. Chi cerca una “memoria condivisa”, per esempio nei conflitti, si condanna al fallimento: non che non sia possibile ricostruire i fatti e giudicarli in maniera equanime; ma questo è il lavoro della storia, non della memoria.
Di qui viene una conseguenza su cui dovremmo riflettere: è molto difficile insegnare la memoria, se non a quelli che si possono includere nel “noi” di cui si narra: l’ingiunzione dell’Aggadà a considerarci tutti come uscita dall’Egitto è la premessa perché noi ebrei possiamo conservarne e propagarne la memoria dopo millenni. Molto più difficile è chiedere di rammemorare la Shoà e di imparare da essa a chi non ne sarebbe stato colpito perché non appartenente alla categoria delle vittime. Si può testimoniare, conservare il ricordo, imporlo perfino. Ma è difficile che ne nasca memoria vera. Ancora più difficile e per certi versi pericoloso è la proposta di mettere un soggetto collettivo (come l’ebraismo) nella posizione di chi insegna e giudica la società in cui vive, in nome della sua memoria: Magari il giudizio è giusto e perfino doveroso; ma c’è il forte rischio che non sia gradito. Arriva sempre un faraone che non si ricorda di Giuseppe ed è infastidito a sentirselo dire.
Un ultimo punto problematico va menzionato: la memoria è sempre parziale, si nel senso che riguarda una parte, un “noi” (nazionale, politico, etnico, religioso, sociale), sia nel senso che costituisce una semplificazione della vicenda storica, ne mette in luce una parte, quella che il soggetto collettivo attiva o conserva per ragioni che di solito sono contemporanee ma attingono comunque alla sua autodefinizione. Per quanto riguarda l’esperienza ebraica, anche solo quella delle persecuzioni e dell’antisemitismo, per non essere parziali bisognerebbe richiamare tutta la terribile vastità di queste memorie, senza attribuirle a una parte sola: c’è stata la Shoà, naturalmente, e tutto l’antisemitismo nazifascista; ma c’è stato anche molto antisemitismo socialista e comunista, che spesso si è preferito dimenticare, ma ha fatto molto male ed è stato per esempio la vera causa della distruzione dell’ebraismo orientale, già prima dell’invasione nazista. C’è stato l’antigiudaismo cristiano, probabilmente paragonabile per gravità delle ferite inferte nel corso dei secoli e per volontà di distruzione alle persecuzioni naziste; e ci sono state le persecuzioni islamiche, non meno frequenti e distruttive. C’è stato infine l’antisemitismo della “buona” cultura europea di Voltaire e di Kant e di Wagner e Baudelaire e di tanti altri filosofi e artisti. Di tutti dovremmo tener memoria.
Le varie posizioni e le varie memorie non vanno confuse, ma non vanno neanche ridotte a una, come se l’idea di eliminare gli ebrei fosse una prerogativa unica dei nazisti, come se solo la destra fosse stata antisemita, come se non dovessimo essere, oltre che antifascisti, anche diffidenti di comunisti, islamisti, integralisti cristiani. Insomma, la memoria è uno strumento potente e difficilmente controllabile, soprattutto perché è collettiva e si riferisce all’identità profonda dei gruppi umani, fra cui il popolo ebraico. Meglio non averne una visione semplificata e non cercare di piegarla alla polemica politica, per non banalizzarla o farsela sfuggire.
Ugo Volli
