Georges Moustaki: “Ho cantato con questa faccia da straniero”
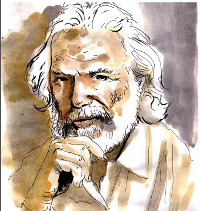 Quando nel febbraio del 1969 appare alla tivù francese nella trasmissione Discorama e intona Le Métèque, il brano che nella versione italiana prenderà il titolo di Lo straniero, nessuno si aspetta quanto sta per accadere. Nel giro di 48 ore la canzone sbanca gli ascolti e inizia una vertiginosa scalata alle classifiche di vendita di tutt’Europa. La casa discografica stenta a tenere dietro alle richieste, solo in Francia il brano vende 800 mila copie. Georges Moustaki è ormai una star di primo piano che per un decennio almeno incarna davvero l’immagine dello straniero. Uno straniero di gran fascino, artista e giramondo, affamato di vita e d’amori. Un personaggio che non è frutto di un accurato marketing ma rispecchia appieno la sua vocazione di cittadino del mondo. Nato ad Alessandria d’Egitto, da una famiglia ebraica originaria di Corfù il cui cognome originario è l’italianissimo Mustacchi, trapiantato a Parigi da ragazzo, Georges Moustaki è uno straniero che coniuga le sue identità in un mosaico colorato e privo di tormenti. “Sono ebreo, sono greco, sono francese, mi sento a casa in Italia: la mia è una pluridentità”, racconta nella sua bella casa parigina nel cuore dell’Ile Saint Louis nell’intervista che ha accettato di realizzare, malgrado le difficili condizioni di salute, nell’ambito della mostra Evraikì-Una diaspora mediterranea da Corfù a Trieste organizzata dalla Comunità ebraica di Trieste.
Quando nel febbraio del 1969 appare alla tivù francese nella trasmissione Discorama e intona Le Métèque, il brano che nella versione italiana prenderà il titolo di Lo straniero, nessuno si aspetta quanto sta per accadere. Nel giro di 48 ore la canzone sbanca gli ascolti e inizia una vertiginosa scalata alle classifiche di vendita di tutt’Europa. La casa discografica stenta a tenere dietro alle richieste, solo in Francia il brano vende 800 mila copie. Georges Moustaki è ormai una star di primo piano che per un decennio almeno incarna davvero l’immagine dello straniero. Uno straniero di gran fascino, artista e giramondo, affamato di vita e d’amori. Un personaggio che non è frutto di un accurato marketing ma rispecchia appieno la sua vocazione di cittadino del mondo. Nato ad Alessandria d’Egitto, da una famiglia ebraica originaria di Corfù il cui cognome originario è l’italianissimo Mustacchi, trapiantato a Parigi da ragazzo, Georges Moustaki è uno straniero che coniuga le sue identità in un mosaico colorato e privo di tormenti. “Sono ebreo, sono greco, sono francese, mi sento a casa in Italia: la mia è una pluridentità”, racconta nella sua bella casa parigina nel cuore dell’Ile Saint Louis nell’intervista che ha accettato di realizzare, malgrado le difficili condizioni di salute, nell’ambito della mostra Evraikì-Una diaspora mediterranea da Corfù a Trieste organizzata dalla Comunità ebraica di Trieste.
Il tema dell’identità domina molte delle sue canzoni. Per quale motivo?
Mio nonno paterno, Giuseppe, veniva dall’isola di Corfù mentre il nonno materno era di Zante. I miei parenti parlavano dunque italiano, perché quelle terre erano state sotto la dominazione veneziana. Noi vivevamo ad Alessandria d’Egitto dove sono cresciuto in un intreccio linguistico. Nelle riunioni di famiglia si usava il greco. I miei genitori conoscevano perfettamente il greco e a casa parlavano fra loro in italiano mentre noi bambini a scuola studiavamo il francese. Tra il greco e l’italiano ho scelto quest’ultimo, forse perché era più facile per via del francese.
Il metissage, l’intreccio di lingue e culture, oggi è entrato a pieno titolo nella letteratura e nella musica come nell’immaginario collettivo. Quarant’anni fa cantare quest’identità mista era invece una cosa molto nuova.
È vero, ed è il motivo per cui ha avuto successo. Per me non era affatto un problema. È la mia identità, sono così. Sono ebreo, sono egiziano, sono greco, sono francese e italiano perché parlo italiano e mi sento a casa quando vado in Italia. Tra l’altro il mio vero nome è Giuseppe … Non sono fissato con una parte sola della mia identità.
C’è voluto coraggio per dichiare di essere, come recitava il testo francese, un métèque, uno straniero, un ebreo errante e un pastore greco?
Per niente. La mia esperienza era proprio quella di essere straniero. Quando da giovane sono arrivato in Francia ho vissuto sulla mia pelle i problemi dell’immigrazione. Lavoravo illegalmente, sono stato un sans papiers per ben sette anni. Se mi avessero trovato sarei stato espulso. Per fortuna non mi è successo nulla di male, a un certo punto mi hanno fatto i documenti e tutto è andato a posto. Ma per tutto quel tempo ho avuto paura. Io parlavo francese, ero in buona salute, trovavo da lavorare. Ma penso a tutti quelli che non parlano correttamente la lingua che non hanno una protezione: è terribile trovarsi su un aereo e costretti ad andare via. Mi sento molto vicino a loro.
È mai stato in Israele?
Molte volte. Ho tenuto lì parecchi concerti e ho avuto anche una fidanzata israeliana.
Quali sono i suoi ricordi legati a Corfù?
Per me bambino era un paradiso perduto che tornava di continuo nei discorsi dei miei parenti che tra di loro parlavano anche il dialetto corfioto. Per questo a 32 anni ho deciso di andarci. Sono arrivato la mattina alle sei dall’Italia con la mia piccola macchina, mi sono fermato al porto, ho fatto colazione e quasi stavo per tornare indietro. Volevo dire ai miei genitori che ero stato lì e in fondo ci ero arrivato, no? Poi per fortuna ho incontrato una coppia di turisti greci. Li ho presi in macchina con me e abbiamo girato l’isola insieme. Sono andato nel quartiere ebraico, ho visto la casa del nonno e mi sono detto che ero arrivato a casa: per la prima volta mi sono sentito in patria. Potevo dire: ecco, da qui vengono i Mustacchi. Anni dopo sono diventato amico del sindaco e mi ha fatto vedere il registro comunale dove era iscritta tutta la famiglia. Da noi uno nasce in Grecia e muore in Egitto. L’altro nasce in Egitto e muore in Francia. Anche la morte ci trova in esilio, non si muore dove siamo nati.
Come i suoi antenati anche lei vive in un’isola, anche se un’isola assai particolare come l’Ile Saint Louis.
Abito qui da cinquant’anni. Ci ho messo dieci anni a trovare questa casa. Mi ha conquistato proprio il fatto che si trova su un’isola. Chissà, forse è la mia anima corfiota. L’importante è che sono circondato dall’acqua: ho la sensazione di trovarmi in un luogo che non fa parte della città. È come trovarsi su un battello. Da qui si può scappare ancora, con i sogni.
Ricorda della sua infanzia qualche particolare usanza ebraica?
Nella mia famiglia la parte ebraica era molto superficiale. Solo mia madre Sara andava in sinagoga, noi non eravamo molto praticanti, mio padre Nissim non lo era per nulla. Festeggiavamo solo qualche festa, di solito quelle divertenti, tipo Purim o Pesach, soprattutto con gli zii o con gli altri bambini. Qual è il suo rapporto con l’ebraismo? Per me essere ebreo è una ricchezza: è il senso dell’umorismo, una certa saggezza ludica. Mi piace ciò che è leggero della parte ebraica, non la lamentazione. Poi mi sono sempre interessato a quanto accade in Medio Oriente.
Nel 1969 lei ha scritto una canzone, En Méditerranée, in cui dipingeva la difficile situazione in quella parte del mondo. Cos’è cambiato da allora?
La situazione è diventata più rigida ma vedo che adesso la gioventù adesso si indigna. A Tel Aviv come in Spagna come nei paesi arabi, è una cosa che mi sembra molto sana.
Suona ancora?
Sì. Non posso più cantare. Con questa malattia ho appena fiato per parlare. Ascolto musica: la classica, Ravel, Bach, Satie e il jazz. Mi piace tutta la musica, tranne il rock’n roll.
E il rap?
Parlavo di musica, quello è parlato. Ha sempre sognato di fare il musicista? Io non volevo fare niente. Sognavo di fare un mestiere che non fosse un lavoro: volevo divertirmi. E cantare mi diverte, come disegnare o scrivere. Anche se faccio tutto seriamente. È un modo di raccontare la mia vita, parlare a me stesso.
Si è divertito?
Sì, per tutta la mia vita.
Ha dei rimpianti?
Direi di no. Forse quello di aver fumato. Ma magari fumando sono riuscito a scrivere belle canzoni. Quando l’ho contattata per l’intervista mi ha scritto che Trieste le ricordava qulacosa.
Di che si tratta?
Il nome di Trieste mi ha riportato alla mente una canzone di moda alla fine degli anni Quaranta. Ad Alessandria avevo imparato a suonarla al pianoforte per fare colpo sulla ragazzina che mi piaceva, una certa Vanna, forse Giovanna, un’italiana. Ho cercato di ritrovare quella canzone un sacco di volte ma non ci ero mai riuscito perché non sapevo come si chiamava. Quando mi ha scritto, ho pensato che potevo recuperarla attraverso di lei ed è stata un’emozione. Poi, quando mi ha detto il titolo, sono andato su su internet e l’ho scaricata. Lo sa che oggi lì si può trovare quasi tutta la musica?
Daniela Gross, Pagine Ebraiche ottobre 2011
(23 maggio 2013)
