Da Bogotà a Medellin, il gran dilemma della sopravvivenza
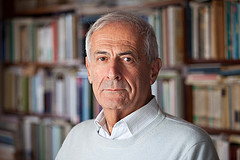 Voltiamo pagina e occupiamoci per una volta degli ebrei in Colombia. Lontani dall’occhio del ciclone globale, ma pur sempre coinvolti da forti turbolenze locali, i circa 3.000 ebrei che vivono oggi in questo bel paese sudamericano sono il residuo di una comunità che non molti anni fa contava 10.000 persone ma si è ridotta notevolmente a causa della forte emigrazione. Questa si è diretta soprattutto verso Miami e la Florida, ma anche verso Panama e qualche altra destinazione latinoamericana, e finalmente verso Israele dove oggi vivono oltre 3.000 ebrei colombiani: altrettanti quanti ne vivono nel paese di origine. È stata soprattutto un’emigrazione di reazione alle drammatiche circostanze del terrorismo legato alla produzione e al commercio della droga. In Colombia per molti anni a partire dal 1964 si è svolta una vera guerra civile tra il governo e i movimenti terroristici, in primo luogo le FARC – le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito del Popolo. Le FARC affermano di essere un movimento di contadini marxistileninisti, si sostengono economicamente attraverso rapimenti e riscatti di persone, estorsione e tassazione in nero, attività minerarie illegali e produzione e distribuzione di prodotti stupefacenti. La forza di questi movimenti consiste non solamente nella loro diffusione su tutto il territorio nazionale, ma nella vera e propria sovranità e autonomia su larghe porzioni di questo paese che ha una superficie complessiva un po’ inferiore al doppio dell’Italia. In queste zone periferiche l’esercito nazionale esitava a entrare. Come avviene in questi casi, spesso le linee di separazione fra le forze del potere costituito e quelle dell’opposizione armata non sono chiarissime. Decine di migliaia i morti, uccisi frequentemente sia alti funzionari del governo e delle amministrazioni locali, sia i capi del movimento rivoluzionario. La Colombia è stata a lungo uno dei paesi meno sicuri in America Latina, il che ne ha ritardato il tasso di sviluppo, a parte l’assai dubbia componente economica dei proventi della vendita di droga, in particolare negli Stati Uniti. Oggi è in corso un processo detto di riconciliazione fra il governo e i gruppi di opposizione. L’iniziativa non è triviale e a detta di molti esprime una sincera convinzione dalle due parti che per il bene del paese si debba giungere a un compromesso equilibrato e negoziato in cui si riconosca il ruolo sovrano dello Stato, ma si tenga conto anche delle necessità di sviluppo delle parti più arretrate del paese dove l’industria della droga procurava reddito e sostentamento a grandi masse di popolazione rurale i cui interessi i movimenti terroristici, almeno in forma dichiarativa, difendevano. Se si raggiungerà una drastica riduzione della redditizia produzione di droga – il che richiederà anche un ugualmente drastico sforzo per ridurne l’importazione da parte degli Stati Uniti – si dovranno anche sviluppare fonti alternative di supporto per l’economia locale, il che non è semplice. Interessante è comunque questo concetto di riconciliazione perché è basato sulla trasparenza e la disponibilità delle due parti contendenti. Una parte si impegnerebbe a chiarire le fonti e i meccanismi di tanti atti di violenza in parte ancora oscuri e impuniti, e inoltre esprimerebbe pentimento per i danni causati alla società civile. L’altra parte si impegnerebbe a inserire delle procedure di particolare cautela nell’applicazione della giustizia, ossia non la commina delle pene dovute ma qualcosa di più simbolico, oltre alla riammissione nella società civile dei colpevoli. Questa per lo meno è la teoria portata avanti da coloro che sono impegnati attualmente nella trattativa, anche se la traduzione in pratica non è affatto semplice, né è garantito il risultato finale. Il principio della riconciliazione si potrebbe anche adottare come metodo nella soluzione di altri conflitti, non ultimo quello in Medio Oriente, ma restano gli ostacoli della disponibilità a riconoscere che la pratica del terrorismo era inaccettabile, e a riunirsi in un’unica società civile. In Colombia questo è teoricamente possibile perché si tratta di una nazione divisa che cerca di ricompattarsi. In Medio Oriente invece le nazioni in conflitto sono due, e non vi è stata fin qui disponibilità a riconoscere la legittimità dell’esistenza dell’altro, certo non da parte palestinese. Fra le vittime di questa dolorosa situazione di guerra civile combattuta vi sono stati in passato anche diversi membri della comunità ebraica, alcuni dei quali sono stati non solamente rapiti e ricattati ma anche uccisi. Di qui l’esodo di molte famiglie, la forte riduzione nel numero dei giovani ebrei e dei ragazzi iscritti alle scuole ebraiche e ai movimenti giovanili. E tuttavia la parte restante della comunità ebraica soprattutto a Bogotà, e in piccolissime concentrazioni a Medellin, Barranquilla e Cali, cerca di funzionare con quello che è rimasto. Seguendo il modello in uso in molti paesi latinoamericani, la comunità che si è formata con migrazioni avvenute soprattutto nella prima metà del 20° secolo, è divisa secondo linee sub-etniche fra ashkenaziti e sefarditi, con in più una terza sinagoga aderente al movimento conservatore. Le varie comunità della capitale e quelle degli altri centri minori sono consociate in una Confederazione delle Comunità Ebraiche della Colombia. A Bogotà funziona una bella scuola ebraica che ha oggi poco più di 200 alunni, un terzo o un quarto rispetto alle cifre del passato. Numerosi membri della comunità svolgono un ruolo importante nella vita economica e culturale del paese. I rapporti dell’attuale governo del presidente Juan Manuel Santos Calderón (succeduto nel 2010 a Álvaro Uribe Vélez) con il governo di Israele sono buoni ed esistono forti legami commerciali e non pochi interessi comuni legati alle procedure di sicurezza. Il paese è chiaramente in forte crescita e la vita, per lo meno nella capitale, appare molto più tranquilla e rilassata di quanto ci si potrebbe attendere. A parte il vantaggio che in altura (Bogotà sta a 2700 metri) le pericolose zanzare portatrici di virus non possono sopravvivere. Nelle molte università locali si respirano climi diversi, dal boicottaggio nei confronti di professori israeliani alla Nazionale e alla Xavieriana (di ispirazione gesuita), alla massima cortesia in altre università cattoliche come la Sergio Arboléda o la Rosario, e a un dibattito anche acceso ma tutto sommato corretto alla prestigiosa Università delle Ande e alla Centrale. Un tema di crescente interesse è legato al flusso incessante di possibili o reali convertiti all’ebraismo, in parte capaci di esibire radici familiari che risalgono all’epoca dell’Inquisizione. In questi anni il loro numero è cresciuto fino a divenire quasi pari a quello degli ebrei iscritti alle comunità ufficiali. La comunità sefardita non effettua conversioni, ma le altre – per coloro che vogliono sottomettersi alla procedura specialmente in casi legati ai matrimoni misti – lo fanno con successo. Ma molti possibili neofiti si sentono già storicamente ebrei e ritengono quindi la procedura di conversione ridondante. Si sono così create ben 26 comunità alternative, non riconosciute peraltro dalla Confederazione centrale, alcune delle quali praticano forme di ebraismo anche da manuale. Una di queste comunità è animata da un colombiano, convertito negli Usa dal gruppo Satmar – una delle corti hassidiche più estremiste, antisioniste e isolazioniste – che a sua volta ha convertito alla stessa comunità Satmar un gruppetto di persone. Il problema centrale, al di là delle sottigliezze rabbiniche sul ghiúr (conversione), sono semmai le differenze di classe fra la parte veterana di ceto medio-superiore, e la parte novizia, spesso anche se non sempre di ceto medio-inferiore. Non è semplice accettare come membro egualitario della propria comunità qualcuno che il giorno prima abbiamo incontrato in una situazione di forte divario sociale. Ma l’osmosi fra i due gruppi è inevitabile e le prime coppiette interclassiste già ci sono cosicché la questione non può essere ignorata. Il dilemma per gli ebrei colombiani è fra la necessità di sopravvivere ai numeri in declino, e quella di stabilizzarsi e anche crescere ridefinendosi socialmente e culturalmente.
Voltiamo pagina e occupiamoci per una volta degli ebrei in Colombia. Lontani dall’occhio del ciclone globale, ma pur sempre coinvolti da forti turbolenze locali, i circa 3.000 ebrei che vivono oggi in questo bel paese sudamericano sono il residuo di una comunità che non molti anni fa contava 10.000 persone ma si è ridotta notevolmente a causa della forte emigrazione. Questa si è diretta soprattutto verso Miami e la Florida, ma anche verso Panama e qualche altra destinazione latinoamericana, e finalmente verso Israele dove oggi vivono oltre 3.000 ebrei colombiani: altrettanti quanti ne vivono nel paese di origine. È stata soprattutto un’emigrazione di reazione alle drammatiche circostanze del terrorismo legato alla produzione e al commercio della droga. In Colombia per molti anni a partire dal 1964 si è svolta una vera guerra civile tra il governo e i movimenti terroristici, in primo luogo le FARC – le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito del Popolo. Le FARC affermano di essere un movimento di contadini marxistileninisti, si sostengono economicamente attraverso rapimenti e riscatti di persone, estorsione e tassazione in nero, attività minerarie illegali e produzione e distribuzione di prodotti stupefacenti. La forza di questi movimenti consiste non solamente nella loro diffusione su tutto il territorio nazionale, ma nella vera e propria sovranità e autonomia su larghe porzioni di questo paese che ha una superficie complessiva un po’ inferiore al doppio dell’Italia. In queste zone periferiche l’esercito nazionale esitava a entrare. Come avviene in questi casi, spesso le linee di separazione fra le forze del potere costituito e quelle dell’opposizione armata non sono chiarissime. Decine di migliaia i morti, uccisi frequentemente sia alti funzionari del governo e delle amministrazioni locali, sia i capi del movimento rivoluzionario. La Colombia è stata a lungo uno dei paesi meno sicuri in America Latina, il che ne ha ritardato il tasso di sviluppo, a parte l’assai dubbia componente economica dei proventi della vendita di droga, in particolare negli Stati Uniti. Oggi è in corso un processo detto di riconciliazione fra il governo e i gruppi di opposizione. L’iniziativa non è triviale e a detta di molti esprime una sincera convinzione dalle due parti che per il bene del paese si debba giungere a un compromesso equilibrato e negoziato in cui si riconosca il ruolo sovrano dello Stato, ma si tenga conto anche delle necessità di sviluppo delle parti più arretrate del paese dove l’industria della droga procurava reddito e sostentamento a grandi masse di popolazione rurale i cui interessi i movimenti terroristici, almeno in forma dichiarativa, difendevano. Se si raggiungerà una drastica riduzione della redditizia produzione di droga – il che richiederà anche un ugualmente drastico sforzo per ridurne l’importazione da parte degli Stati Uniti – si dovranno anche sviluppare fonti alternative di supporto per l’economia locale, il che non è semplice. Interessante è comunque questo concetto di riconciliazione perché è basato sulla trasparenza e la disponibilità delle due parti contendenti. Una parte si impegnerebbe a chiarire le fonti e i meccanismi di tanti atti di violenza in parte ancora oscuri e impuniti, e inoltre esprimerebbe pentimento per i danni causati alla società civile. L’altra parte si impegnerebbe a inserire delle procedure di particolare cautela nell’applicazione della giustizia, ossia non la commina delle pene dovute ma qualcosa di più simbolico, oltre alla riammissione nella società civile dei colpevoli. Questa per lo meno è la teoria portata avanti da coloro che sono impegnati attualmente nella trattativa, anche se la traduzione in pratica non è affatto semplice, né è garantito il risultato finale. Il principio della riconciliazione si potrebbe anche adottare come metodo nella soluzione di altri conflitti, non ultimo quello in Medio Oriente, ma restano gli ostacoli della disponibilità a riconoscere che la pratica del terrorismo era inaccettabile, e a riunirsi in un’unica società civile. In Colombia questo è teoricamente possibile perché si tratta di una nazione divisa che cerca di ricompattarsi. In Medio Oriente invece le nazioni in conflitto sono due, e non vi è stata fin qui disponibilità a riconoscere la legittimità dell’esistenza dell’altro, certo non da parte palestinese. Fra le vittime di questa dolorosa situazione di guerra civile combattuta vi sono stati in passato anche diversi membri della comunità ebraica, alcuni dei quali sono stati non solamente rapiti e ricattati ma anche uccisi. Di qui l’esodo di molte famiglie, la forte riduzione nel numero dei giovani ebrei e dei ragazzi iscritti alle scuole ebraiche e ai movimenti giovanili. E tuttavia la parte restante della comunità ebraica soprattutto a Bogotà, e in piccolissime concentrazioni a Medellin, Barranquilla e Cali, cerca di funzionare con quello che è rimasto. Seguendo il modello in uso in molti paesi latinoamericani, la comunità che si è formata con migrazioni avvenute soprattutto nella prima metà del 20° secolo, è divisa secondo linee sub-etniche fra ashkenaziti e sefarditi, con in più una terza sinagoga aderente al movimento conservatore. Le varie comunità della capitale e quelle degli altri centri minori sono consociate in una Confederazione delle Comunità Ebraiche della Colombia. A Bogotà funziona una bella scuola ebraica che ha oggi poco più di 200 alunni, un terzo o un quarto rispetto alle cifre del passato. Numerosi membri della comunità svolgono un ruolo importante nella vita economica e culturale del paese. I rapporti dell’attuale governo del presidente Juan Manuel Santos Calderón (succeduto nel 2010 a Álvaro Uribe Vélez) con il governo di Israele sono buoni ed esistono forti legami commerciali e non pochi interessi comuni legati alle procedure di sicurezza. Il paese è chiaramente in forte crescita e la vita, per lo meno nella capitale, appare molto più tranquilla e rilassata di quanto ci si potrebbe attendere. A parte il vantaggio che in altura (Bogotà sta a 2700 metri) le pericolose zanzare portatrici di virus non possono sopravvivere. Nelle molte università locali si respirano climi diversi, dal boicottaggio nei confronti di professori israeliani alla Nazionale e alla Xavieriana (di ispirazione gesuita), alla massima cortesia in altre università cattoliche come la Sergio Arboléda o la Rosario, e a un dibattito anche acceso ma tutto sommato corretto alla prestigiosa Università delle Ande e alla Centrale. Un tema di crescente interesse è legato al flusso incessante di possibili o reali convertiti all’ebraismo, in parte capaci di esibire radici familiari che risalgono all’epoca dell’Inquisizione. In questi anni il loro numero è cresciuto fino a divenire quasi pari a quello degli ebrei iscritti alle comunità ufficiali. La comunità sefardita non effettua conversioni, ma le altre – per coloro che vogliono sottomettersi alla procedura specialmente in casi legati ai matrimoni misti – lo fanno con successo. Ma molti possibili neofiti si sentono già storicamente ebrei e ritengono quindi la procedura di conversione ridondante. Si sono così create ben 26 comunità alternative, non riconosciute peraltro dalla Confederazione centrale, alcune delle quali praticano forme di ebraismo anche da manuale. Una di queste comunità è animata da un colombiano, convertito negli Usa dal gruppo Satmar – una delle corti hassidiche più estremiste, antisioniste e isolazioniste – che a sua volta ha convertito alla stessa comunità Satmar un gruppetto di persone. Il problema centrale, al di là delle sottigliezze rabbiniche sul ghiúr (conversione), sono semmai le differenze di classe fra la parte veterana di ceto medio-superiore, e la parte novizia, spesso anche se non sempre di ceto medio-inferiore. Non è semplice accettare come membro egualitario della propria comunità qualcuno che il giorno prima abbiamo incontrato in una situazione di forte divario sociale. Ma l’osmosi fra i due gruppi è inevitabile e le prime coppiette interclassiste già ci sono cosicché la questione non può essere ignorata. Il dilemma per gli ebrei colombiani è fra la necessità di sopravvivere ai numeri in declino, e quella di stabilizzarsi e anche crescere ridefinendosi socialmente e culturalmente.
Sergio Della Pergola, Università Ebraica di Gerusalemme
Pagine ebraiche, marzo 2016
