Società – Legge ebraica e proprietà intellettuale “Citare la fonte porta salvezza al mondo”
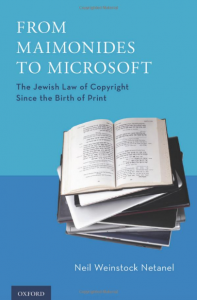 Nel 1997, il braccio israeliano di Microsoft portò in tribunale alcune compagnie di software che ne avevano copiato i programmi. Il tribunale decise in loro favore, ma la vittoria non fu completa finché alla società creatrice di Windows non fu data ragione anche da parte della Corte rabbinica di Bnei Berak, che ribadiva come la protezione dei diritti d’autore rappresenti un principio centrale nella legge ebraica. È con questo episodio che la rivista americana Commentary apre la presentazione del libro “From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print” (Da Maimonide a Microsoft: la legge ebraica del Copyright dalla nascita della stampa) di Neil Weinstock Netanel da poco uscito per la Oxford University Press. Perché il tema è antico quanto i caratteri mobili, precursori di tutto secoli prima della nascita di internet e di musica, film e programmi piratati. E tra i primi a mettere al bando la ripubblicazione non autorizzata, furono i rabbini di Roma, all’inizio del XVI secolo.
Nel 1997, il braccio israeliano di Microsoft portò in tribunale alcune compagnie di software che ne avevano copiato i programmi. Il tribunale decise in loro favore, ma la vittoria non fu completa finché alla società creatrice di Windows non fu data ragione anche da parte della Corte rabbinica di Bnei Berak, che ribadiva come la protezione dei diritti d’autore rappresenti un principio centrale nella legge ebraica. È con questo episodio che la rivista americana Commentary apre la presentazione del libro “From Maimonides to Microsoft: The Jewish Law of Copyright Since the Birth of Print” (Da Maimonide a Microsoft: la legge ebraica del Copyright dalla nascita della stampa) di Neil Weinstock Netanel da poco uscito per la Oxford University Press. Perché il tema è antico quanto i caratteri mobili, precursori di tutto secoli prima della nascita di internet e di musica, film e programmi piratati. E tra i primi a mettere al bando la ripubblicazione non autorizzata, furono i rabbini di Roma, all’inizio del XVI secolo.
“I valori ebraici impongono di citare la fonte di un’idea: ‘Chiunque ripete un’idea nel nome di chi l’ha per primo formulata porta redenzione al mondo’ dicono i Saggi” ha scritto il rabbino Shlomo Brody, già insegnante alla Yeshivat HaKotel, in un approfondimento dedicato all’argomento sul Jerusalem Post. Allo stesso tempo, aggiunge il rav, una volta citata la fonte, importante è anche considerata la circolazione della conoscenza. Con una certa accortezza. “Diffondere la conoscenza rappresenta un investimento economico che richiede tempo e risorse. Se qualcuno riproduce questa conoscenza, causa danno economico a colui che l’ha originata, anche senza una lesione diretta o un furto nel senso fisico del termine, poiché la “proprietà intellettuale” è un’entità astratta. Oltre alla singola perdita, un’attività del genere può minacciare l’esistenza dell’intero settore, e di conseguenza minare la possibilità di diffondere la conoscenza”.
Un famoso caso di condanna per plagio fu la decisione emanata da rav Moses Isserles, l’autore della glossa ashkenazita dello Shulkhan Aruch, che nel XVI secolo mise al bando una edizione del Mishne Torah, codice halakhico firmato dal Maimonide, perché non aveva rispettato il diritto d’autore: coloro che in Polonia avessero comprato o si fossero trovati in possesso di una copia proibita, sarebbero incorsi niente meno che nella scomunica.
Il libro della Oxford University Press si conclude chiedendosi se la violazione del copyright sia paragonabile a un vero e proprio furto. “Riguardo a questo interrogativo, ci sono due prospettive ebraiche in concorrenza tra loro. La prima considera la proprietà intellettuale perfettamente alla stregua della proprietà fisica. La seconda, maggiormente accettata, legge il copyright come un amalgama di diritti derivanti da una moltitudine di fonti, che includono i vari bandi rabbinici, usi vincolanti, protezione contro concorrenza sleale e ingiusto arricchimento, rispetto della legge dello Stato riguardo a questioni di carattere commerciale. In questo modo dunque vediamo come l’halakhah incorpori idee che provengono dalla propria tradizione e da quelle che la circondano” scrive ancora il Commentary.
Ricordando poi, come sottolineato da rav Brody, che in questo ambito più che mai, la responsabilità di non violare il copyright ad ogni livello, dall’idea al download della musica online, ricade su ciascuno. La ricetta? “Resistere alla tentazione e rafforzare il nostro rispetto per la proprietà altrui. Fisica o intellettuale”.
Rossella Tercatin
