PAROLE E SOCIETA’ Post-verità, le bugie che mettono a rischio il nostro futuro
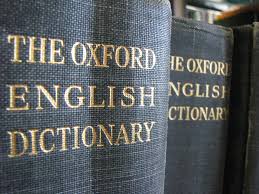 I redattori di Oxford Dictionary hanno scelto di inserire la parola “Post-Truth” ovvero “post verità” come parola non solo accreditata, ma come parola dell’anno. La cosa è meno bizzarra di quanto si potrebbe pensare e soprattutto ha molto a che fare con l’atmosfera culturale e politica che caratterizza il nostro presente. Che cosa s’intende con il termine “Post verità”? Soprattutto, che cosa s’intende per politica della post-verità, o più in generale per società post-fattuale? Si tratta della tendenza della società contemporanea ad accettare come vere informazioni (politiche e non) senza alcuna base reale. Non è una novità. Nella storia le verità affermate come vere, vissute come vere ma prive di fondamento hanno avuto molto successo in passato. Smontarle, in altre parole nell’ordine: decostruirle, dimostrarne l’infondatezza, e dunque uscire dal campo magnetico della loro forza di persuasione e di convinzione, non è stato facile e ha richiesto molte energie e molte competenze. Un esempio: la decostruzione della forza persuasiva dei Protocolli è stata una dura battaglia culturale, politica, emozionale, comunicativa che è durata non meno di mezzo secolo. Non è stato un mezzo secolo senza pesanti eventi: la vicenda è iniziata nel 1921 con il primo processo e si è finita negli anni ‘70. In mezzo ci sono stati milioni di morti, anche come conseguenza della capacità persuasiva dei falsi. Dunque quando parliamo di politica della posterità non parliamo di opinioni che si smontano con opinioni, parliamo di opinioni che nella storia, anche molto recente, hanno prodotto fatti. Per William Thomas (1863-1947) sociologo americano, la nostra realtà si sintetizza così: “Se gli uomini definiscono come reali certe situazioni, esse sono reali nelle loro conseguenze”. La prima parte del teorema è un’ennesima autorevole puntualizzazione del fatto che gli uomini non rispondono solo agli elementi oggettivi di una situazione, ma anche, ed a volte in primo luogo, al significato che questa situazione ha per loro. E una volta che essi hanno attribuito un qualunque significato ad una situazione, questo significato è la causa determinante del loro comportamento e di alcune conseguenze di questo. Ma tutto ciò è ancora piuttosto astratto e le astrazioni hanno la tendenza a diventare incomprensibili se non sono collegate a dati concreti. Dunque qualcuno si convince che la realtà è ingannevole e che gli eventi che possono accadere sono la conseguenza di questo inganno. La conseguenza è che la risposta da mettere in campo deve fare in modo di neutralizzarli. Un esempio concreto: La vittoria di Donald Trump. Quel risultato è anche la conseguenza di questa convinzione. Ossia il fatto che il confronto elettorale in caso di vittoria dell’avversario era percepito come la dimostrazione non solo dell’inganno ma della fondatezza dell’inganno. Vincere non era solo un dovere, ma la dimostrazione che la realtà dei fatti era più forte del supposto controllo che i “poteri forti” esercitano sui fatti. Per questo vincere non è stato rivendicato come un merito, ma è stata proposta come la dimostrazione che la realtà ha avuto ragione dell’inganno. Per questo quel risultato è assunto come “il riscatto dell’America reale contro il complotto”. Non è un giudizio sulla politica che sarà in atto a partire dal prossimo 21 gennaio, né una lettura preconfezionata del nuovo scenario politico internazionale che sarà conseguente a quella politica o al tentativo di metterla in pratica. È un quadro di ciò che abbiamo di fronte oggi, della mentalità, ma anche della convinzione che caratterizza il nostro presente immediato e segnerà profondamente il tempo prossimo. Il dato interessante è la sua estensione geografica, che oggi non è propria solo delle grandi autocrazie o delle dittature ma attraversa anche le democrazie consolidate.
I redattori di Oxford Dictionary hanno scelto di inserire la parola “Post-Truth” ovvero “post verità” come parola non solo accreditata, ma come parola dell’anno. La cosa è meno bizzarra di quanto si potrebbe pensare e soprattutto ha molto a che fare con l’atmosfera culturale e politica che caratterizza il nostro presente. Che cosa s’intende con il termine “Post verità”? Soprattutto, che cosa s’intende per politica della post-verità, o più in generale per società post-fattuale? Si tratta della tendenza della società contemporanea ad accettare come vere informazioni (politiche e non) senza alcuna base reale. Non è una novità. Nella storia le verità affermate come vere, vissute come vere ma prive di fondamento hanno avuto molto successo in passato. Smontarle, in altre parole nell’ordine: decostruirle, dimostrarne l’infondatezza, e dunque uscire dal campo magnetico della loro forza di persuasione e di convinzione, non è stato facile e ha richiesto molte energie e molte competenze. Un esempio: la decostruzione della forza persuasiva dei Protocolli è stata una dura battaglia culturale, politica, emozionale, comunicativa che è durata non meno di mezzo secolo. Non è stato un mezzo secolo senza pesanti eventi: la vicenda è iniziata nel 1921 con il primo processo e si è finita negli anni ‘70. In mezzo ci sono stati milioni di morti, anche come conseguenza della capacità persuasiva dei falsi. Dunque quando parliamo di politica della posterità non parliamo di opinioni che si smontano con opinioni, parliamo di opinioni che nella storia, anche molto recente, hanno prodotto fatti. Per William Thomas (1863-1947) sociologo americano, la nostra realtà si sintetizza così: “Se gli uomini definiscono come reali certe situazioni, esse sono reali nelle loro conseguenze”. La prima parte del teorema è un’ennesima autorevole puntualizzazione del fatto che gli uomini non rispondono solo agli elementi oggettivi di una situazione, ma anche, ed a volte in primo luogo, al significato che questa situazione ha per loro. E una volta che essi hanno attribuito un qualunque significato ad una situazione, questo significato è la causa determinante del loro comportamento e di alcune conseguenze di questo. Ma tutto ciò è ancora piuttosto astratto e le astrazioni hanno la tendenza a diventare incomprensibili se non sono collegate a dati concreti. Dunque qualcuno si convince che la realtà è ingannevole e che gli eventi che possono accadere sono la conseguenza di questo inganno. La conseguenza è che la risposta da mettere in campo deve fare in modo di neutralizzarli. Un esempio concreto: La vittoria di Donald Trump. Quel risultato è anche la conseguenza di questa convinzione. Ossia il fatto che il confronto elettorale in caso di vittoria dell’avversario era percepito come la dimostrazione non solo dell’inganno ma della fondatezza dell’inganno. Vincere non era solo un dovere, ma la dimostrazione che la realtà dei fatti era più forte del supposto controllo che i “poteri forti” esercitano sui fatti. Per questo vincere non è stato rivendicato come un merito, ma è stata proposta come la dimostrazione che la realtà ha avuto ragione dell’inganno. Per questo quel risultato è assunto come “il riscatto dell’America reale contro il complotto”. Non è un giudizio sulla politica che sarà in atto a partire dal prossimo 21 gennaio, né una lettura preconfezionata del nuovo scenario politico internazionale che sarà conseguente a quella politica o al tentativo di metterla in pratica. È un quadro di ciò che abbiamo di fronte oggi, della mentalità, ma anche della convinzione che caratterizza il nostro presente immediato e segnerà profondamente il tempo prossimo. Il dato interessante è la sua estensione geografica, che oggi non è propria solo delle grandi autocrazie o delle dittature ma attraversa anche le democrazie consolidate.
David Bidussa, Pagine Ebraiche, dicembre 2016
