CULTURA Il Rinascimento, la Bibbia e la lettura italiana
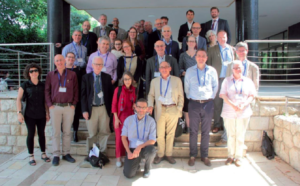 “La più antica e ancora esistente pièce in ebraico, ‘Una commedia di fidanzamento’ (Tsahut bedihuta deqiddushin), attribuita al drammaturgo ebreo mantovano Leone de’ Sommi (Yehuda Sommo) è un’intrigante fusione delle tradizioni testuali ebraiche riguardanti il matrimonio e delle usanze teatrali italiane rinascimentali. È probabilmente il primo tentativo nella storia di esplorare come la lingua ebraica possa funzionare nelle performance teatrali”. Arrivano anche dall’Italia le suggestioni che hanno animato la conferenza “The Bible in the Renaissance”, La Bibbia nel Rinascimento, che si è svolta alla fine di maggio all’Università ebraica di Gerusalemme, promossa, oltre che dall’ateneo della Capitale israeliana, da Israel Science Fund, Institute for Advanced Studies, Fondazione Giovanni XXIII for Religious Studies, Università di Bar Ilan. A esplorare il modo in cui i riferimenti biblici vengono usati nel corso di questo speciale esempio di opera teatrale è stato Yair Lipshitz, docente della Tel Aviv University, approfondendo in particolare la sua protagonista femminile, la giovane Beruriah, e in lei le eco dei personaggi femminili raccontati appunto nella Bibbia. Teatro dunque (con una particolare attenzioni anche agli straordinari prodotti del genio di William Shakespeare), ma anche letteratura, storia, teologia, sono stati al centro della tre giorni di conferenze, organizzata da Yaakov Mascetti, docente di letterature comparate dell’Università di Bar Ilan. “L’idea alla base della conferenza è proprio quella di esplorare a trecentosessanta gradi tutto ciò che ha a che fare con la Bibbia nel Rinascimento. Siamo partiti da una giornata dedicata più specificamente al contesto storico, per poi passare alla parte maggiormente legata ad arte e letteratura” spiega Mascetti, sottolineando l’attenzione alla multidisciplinarietà, persino con un assaggio di musica, con un ensemble che ha eseguito i brani del compositore Salomone Rossi, vissuto a Mantova a cavallo tra XVI e XVII secolo. A prendere parte alla conferenza studiosi americani, europei, israeliani, con background molto diversificati anche dal punto di vista religioso. “Abbiamo cercato di dare un’impronta pluralista con partecipanti di diversa provenienza geografica e non solo, protestanti, cattolici, musulmani, ebrei. L’idea era anche quella di mandare un messaggio a chi ci guardava da fuori, e di affermare che si può parlare di Bibbia, di fede, di storia della teologia in modo pacato e civile anche fra gente che la pensa diversamente” mette ancora in evidenza il docente. Approfondimenti sono stati dedicati anche al mondo del rapporto fra le varie lingue in cui la Bibbia venne studiata, e delle sue traduzioni. Tra i vari interventi, anche quello di Claudia Rosenzweig, professoressa di letteratura yiddish a Bar Ilan, su “l’antica lingua e cultura yiddish sviluppatasi nell’Europa cristiana nel corso di Medioevo e inizio dell’Età moderna e la loro relazione con la Bibbia ebraica, centrale in varie prospettive – linguistiche, esegetiche, letterarie, storiche – rispetto a cui tuttavia all’inizio della Modernità si presenta un nuovo fattore che diventa visibile nei testi letterari in Yiddish: da una parte un processo di quello che Jauss definì Literarisierung, la trasformazione delle narrative bibliche in generi diversi, dall’altra quello che io chiamo la ‘contro-ricezione’, un modo (ebraico) alternativo di leggere gli stessi testi che i cristiani leggevano nei vernacolari europei”. Varie le sessioni incentrate anche sulla lettura della Bibbia nelle Chiese protestanti, con particolare attenzione a quella anglicana. “Se nel Rinascimento questo tipo di spaccature esegetiche hanno creato enormi problemi che si sono andati a manifestare in guerre di religioni e conseguenze terribili oggi possiamo imparare la lezione e cercare di fare diversamente – conclude Mascetti, sottolineando l’attualità di argomenti che possono parere lontani del tempo. “Oggi possiamo affermare che l’atomizzazione esegetica non deve per forza accendere il fuoco della violenza, che ci si può confrontare pacificamente con l’altro. Un approccio questo che quasi non esisteva nell’Europa di quel periodo. Con alcune eccezioni, come per esempio alcuni cori interconfessionali che a Praga riuscivano a riunire fedeli di diverse confessioni, provando con la musica creare un’armonia anche tra persone differenti. Un simbolo importante di quello che abbiamo cercato di fare qui”.
“La più antica e ancora esistente pièce in ebraico, ‘Una commedia di fidanzamento’ (Tsahut bedihuta deqiddushin), attribuita al drammaturgo ebreo mantovano Leone de’ Sommi (Yehuda Sommo) è un’intrigante fusione delle tradizioni testuali ebraiche riguardanti il matrimonio e delle usanze teatrali italiane rinascimentali. È probabilmente il primo tentativo nella storia di esplorare come la lingua ebraica possa funzionare nelle performance teatrali”. Arrivano anche dall’Italia le suggestioni che hanno animato la conferenza “The Bible in the Renaissance”, La Bibbia nel Rinascimento, che si è svolta alla fine di maggio all’Università ebraica di Gerusalemme, promossa, oltre che dall’ateneo della Capitale israeliana, da Israel Science Fund, Institute for Advanced Studies, Fondazione Giovanni XXIII for Religious Studies, Università di Bar Ilan. A esplorare il modo in cui i riferimenti biblici vengono usati nel corso di questo speciale esempio di opera teatrale è stato Yair Lipshitz, docente della Tel Aviv University, approfondendo in particolare la sua protagonista femminile, la giovane Beruriah, e in lei le eco dei personaggi femminili raccontati appunto nella Bibbia. Teatro dunque (con una particolare attenzioni anche agli straordinari prodotti del genio di William Shakespeare), ma anche letteratura, storia, teologia, sono stati al centro della tre giorni di conferenze, organizzata da Yaakov Mascetti, docente di letterature comparate dell’Università di Bar Ilan. “L’idea alla base della conferenza è proprio quella di esplorare a trecentosessanta gradi tutto ciò che ha a che fare con la Bibbia nel Rinascimento. Siamo partiti da una giornata dedicata più specificamente al contesto storico, per poi passare alla parte maggiormente legata ad arte e letteratura” spiega Mascetti, sottolineando l’attenzione alla multidisciplinarietà, persino con un assaggio di musica, con un ensemble che ha eseguito i brani del compositore Salomone Rossi, vissuto a Mantova a cavallo tra XVI e XVII secolo. A prendere parte alla conferenza studiosi americani, europei, israeliani, con background molto diversificati anche dal punto di vista religioso. “Abbiamo cercato di dare un’impronta pluralista con partecipanti di diversa provenienza geografica e non solo, protestanti, cattolici, musulmani, ebrei. L’idea era anche quella di mandare un messaggio a chi ci guardava da fuori, e di affermare che si può parlare di Bibbia, di fede, di storia della teologia in modo pacato e civile anche fra gente che la pensa diversamente” mette ancora in evidenza il docente. Approfondimenti sono stati dedicati anche al mondo del rapporto fra le varie lingue in cui la Bibbia venne studiata, e delle sue traduzioni. Tra i vari interventi, anche quello di Claudia Rosenzweig, professoressa di letteratura yiddish a Bar Ilan, su “l’antica lingua e cultura yiddish sviluppatasi nell’Europa cristiana nel corso di Medioevo e inizio dell’Età moderna e la loro relazione con la Bibbia ebraica, centrale in varie prospettive – linguistiche, esegetiche, letterarie, storiche – rispetto a cui tuttavia all’inizio della Modernità si presenta un nuovo fattore che diventa visibile nei testi letterari in Yiddish: da una parte un processo di quello che Jauss definì Literarisierung, la trasformazione delle narrative bibliche in generi diversi, dall’altra quello che io chiamo la ‘contro-ricezione’, un modo (ebraico) alternativo di leggere gli stessi testi che i cristiani leggevano nei vernacolari europei”. Varie le sessioni incentrate anche sulla lettura della Bibbia nelle Chiese protestanti, con particolare attenzione a quella anglicana. “Se nel Rinascimento questo tipo di spaccature esegetiche hanno creato enormi problemi che si sono andati a manifestare in guerre di religioni e conseguenze terribili oggi possiamo imparare la lezione e cercare di fare diversamente – conclude Mascetti, sottolineando l’attualità di argomenti che possono parere lontani del tempo. “Oggi possiamo affermare che l’atomizzazione esegetica non deve per forza accendere il fuoco della violenza, che ci si può confrontare pacificamente con l’altro. Un approccio questo che quasi non esisteva nell’Europa di quel periodo. Con alcune eccezioni, come per esempio alcuni cori interconfessionali che a Praga riuscivano a riunire fedeli di diverse confessioni, provando con la musica creare un’armonia anche tra persone differenti. Un simbolo importante di quello che abbiamo cercato di fare qui”.
Rossella Tercatin, Pagine Ebraiche, giugno 2017
Quei Testi che non smettono di far riflettere
Le Scritture sono testi e i testi, come tutti sappiamo, fanno cose con le parole. Sin dalla mia dissertazione, scritta sotto la supervisione del professor William Kolbrener, il mio interesse accademico si è concentrato sui modi in cui testi (e parole) danno forma alla realtà (o alle cose). Dalla descrizione che ho presentato nel mio dottorato sui processi alchemici compiuti da John Donne nel suo poema del 1611 “L’Anatomia del Mondo” attraverso una rilettura delle tecniche omiletiche di Donne in quelli che nel 1628 chiamò “Acta Apothegmata”, sermoni e lavori verbali eseguiti di fronte ad ascoltatori, passando poi alla rappresentazione della distillazione Herbertiana dell’elisir cristico ne “Il Tempio”, andando all’esegesi di genere e l’Eucarestia di Aemilia Lanyer, la Bibbia è sempre rimasta sullo sfondo fornendo a poeti, e ai teologi di cui ho scritto, la materia prima del loro lavoro per la creazione di testi che si occupassero di questioni contemporanee attraverso le lenti delle Scritture. Un esempio di questo fenomeno è il modo in cui John Donne usò il concetto di “canto” (shir) per la sua produzione poetica e, più avanti, omiletica. Contro lo sfondo di ciò che Barbata Lewalski ha chiamato il “fenomeno del Rinascimento/diciassettesimo secolo” di “articolazione e pratica di una teoria completamente sviluppata dell’estetica biblica”, come fondamento per “una importante varietà di liriche religiose del XVII secolo”, l’uso di Donne del “canto” esemplifica le discussioni contemporanee sul “rapporto tra arte e verità, portato al centro dell’attenzione dalla Riforma”: eppure Donne non si limita a citare il canto biblico, ma invece ne scrive uno e le sue rianimate poesis bibliche possedevano quello che Erasmo chiamava, dopo Quintiliano e Cicerone, una ‘enargeia’, un’energia o potere che non si limitava a ‘narrare’ ma che mostrava per davvero la scena, portando le ‘emozioni’ del lettore a essere, spiegava Quintiliano, “non meno attivamente rimescolate che se fossimo stati veramente presenti al fatto descritto”.
Questo testo è la traduzione di parte del discorso pronunciato in apertura della conferenza “La Bibbia nel Rinascimento” svoltasi a Gerusalemme dal 22 al 24 maggio 2017.
Yaakov Mascetti, Università di Bar Ilan
