NARRATIVA “Il mio Otello rivive nell’America razzista”
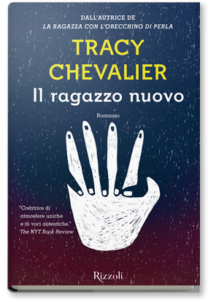 Tracy Chevalier / IL RAGAZZO NUOVO / Rizzoli
Tracy Chevalier / IL RAGAZZO NUOVO / Rizzoli
Tracy Chevalier è una scrittrice coraggiosa e lieve. Si è sempre buttata in operazioni audaci. Restituendo vita al fascinoso Vermeer con la “Ragazza dall’orecchino di perla” o all’enigmatico William Blake con “L’innocenza” o alle protofemministe inglesi di “Quando cadono gli angeli”, comunque piroettando con i suoi romanzi nel passato per coglierne nebulose ancora da mettere a fuoco e, con un linguaggio slegato dal tempo di allora, portandole anche ai lettori meno accorti, rendendole potabili, consumabili, gustabili subito, pop. E diventando uno degli autori più letti del pianeta. Stavolta l’impresa è davvero ardua. Gliel’ha proposta la Hogart Press in occasione dei 400 anni dalla morte di Shakespeare (impresa in cui ha coinvolto altri prestigiosi autori, da Margaret Atwood a Jo Nesbo, da Anne Tyler a Howard Jacobson) affidando ad ognuno la riscrittura di un dramma del Bardo. E lei ha raccolto la sfida. Scegliendo l’Otello, masterpiece dell’opacità strategica dell’autore di Stratford, del suo modo inarrivabile di focalizzarsi su personaggi misteriosi e abbaglianti. Pensiamo allo strano matrimonio di Desdemona e il Moro, la perfidia di Lago, la furia assassina di Otello scatenata da un fazzoletto, l’intrigo improbabile capace invece di convocare e illuminare la tragedia della gelosia, l’identità, la razza, il tradimento. Ed ecco la capriola di Tracy Chevalier: in Il ragazzo nuovo (Rizzoli) la scena passa dalla Venezia rinascimentale a una scuola di Washington D.C. negli anni ’70 del Novecento. Dove Otello si trasforma in Osei (detto anche O), il figlio dodicenne di un diplomatico del Ghana che si ritrova unico ragazzo in mezzo a tanti diffidenti coetanei e professori whasp, Desdemona diventa Dee, adolescente subito affascinata dall’intrigante diversità cosmopolita di O, e Iago entra in Ian, il bullo che vuole mantenere il suo potere sul campo da gioco dell’istituto, anche a costo di farlo diventare un’arena letale. Gioco d’azzardo dunque per la navigata Chevalier.
Lei dal passato trae personaggi famosi e li rende delle icone pop contemporanee. Qual è il suo segreto per farli apprezzare da un pubblico che talvolta ne sa davvero poco?
«Scelgo figure molto note, ma che in realtà hanno storie piene di lacune che posso colmare. Con Vermeer, ad esempio: tanto le sue tele sono conosciute, quanto lui e le persone che lo circondavano sono avvolte dal mistero. Così, si è scritto molto su William Blake, ma l’artista rimane criptico. Esploro questi vuoti e creo una finzione che li spieghi. Cerco l’universale, cose con le quali noi del XXI secolo possiamo relazionarci».
Che obiettivi si dà? Semplificare il linguaggio dei grandi? Identificarsi con loro o col lettore?
«Penso ai dettagli comuni alla nostra esperienza: lo sguardo di una ragazza, l’atmosfera di un cimitero, la gioia di una scoperta. Cerco di gettare un ponte verso il lettore. E non ho nessun pubblico specifico in mente».
Aveva paura a trasformare un’opera di Shakespeare in un romanzo contemporaneo?
«All’inizio ero scoraggiata. Shakespeare è un gigante. Ero preoccupata dei possibili paragoni (necessariamente sfavorevoli). Ma poi ho realizzato che lui stesso aveva scritto commedie da interpretare ogni volta diversamente. Come profili che andavano rielaborati di volta in volta. E infatti lui stesso le ha tratte da altre storie. L’ Otello è il rifacimento di un racconto italiano del XVI secolo, di Giovan Battista Giraldi Cintio. Quel che non ho voluto fare è cercare di imitare il linguaggio di Shakespeare — i suoi stupefacenti ritmi, giochi di parole, metafore, immagini».
Perché ha scelto l’Otello?
«Ero attratta dall’idea di un outsider e dal modo in cui una comunità si mette in relazione con un diverso. Sono un’americana che abita a Londra da 30 anni, mi sento un po’ fuori passo con la cultura dominante. E sono cresciuta da bianca in un quartiere e in una scuola di Washington dove la maggioranza era nera. Ho qualche esperienza sull’avere un colore di pelle differente da chi mi circonda. È stato questo a guidarmi nella scelta».
L’Otello è un dramma grondante disperazione e sangue. Non temeva, immaginando un plot immerso tra ragazzini di 11 anni, che avrebbe cancellato la sua carica tragica?
«Non si ricorda com’era un campo da gioco? Il mio era drammatico. Ragazzi che combattevano, si alleavano gli uni contro gli altri, volevano farti a fettine e sapere tutto di te. Anche se gli adulti non sembrano tenerne conto, gli adolescenti vivono intensamente e volevo cercare di coglierlo, togliendo un po’ delle interferenze dei grandi. E ho dato alla storia la lunghezza di un solo giorno perché tutto fosse compresso e intenso. E direi che la fine, anche se non è come quella di Otello, è drammatica e cambia la vita di ogni personaggio».
Ma un bambino di 11 anni come Ian può essere l’archetipo del Male che Iago rappresenta in Otello?
«No, Iago è percepito come il Male, anche perché il suo comportamento è avvolto nel mistero. Non potevo rendere Ian così. Gli ho dato un retroterra che lo spiegasse, il padre e i fratelli maggiori violenti».
Il tema che le interessa di più è la diversità del colore della pelle, della cultura. Ma oggi non sarebbe permesso agli insegnanti e ai compagni di scuola di essere crudeli con un ragazzo nero in una scuola di Washington. Non pensa?
«È bello che lei immagini i ragazzi gentili l’un con l’altro. Ma i bambini sono meschini e giudicanti verso gli altri come gli adulti. Credo anch’io che oggi gli insegnanti sarebbero più sensibili e severi verso atteggiamenti razzisti. Ma molto di quel che accade in un campo da gioco esclude gli adulti. E allora i piccoli possono essere molto crudeli».
Quante volte ha letto Otello prima di riscriverlo?
«L’ho studiato e visto molte volte, ma solamente un paio prima di mettermi a scrivere. Da allora ho cercato di non guardarlo più. Non volevo che il mio romanzo lo ricalcasse. Volevo che camminasse da solo».
Susanna Nirenstein, La Repubblica, 13 giugno 2017
