LETTERATURA Bellow, la verità della scrittura nasce a Parigi
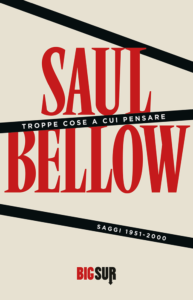 Saul Bellow / TROPPE COSE A CUI PENSARE. SAGGI /Sur
Saul Bellow / TROPPE COSE A CUI PENSARE. SAGGI /Sur
Dalla sua terrazza di Ravello Gore Vidal, scrittore che si occupava dell’America da un Paese di cui non parlava la lingua, diceva: «Perché no?» e indicava un’altra villa più in basso: «Lì James Fenimore Cooper scrisse L’ultimo dei Mohicani». Così anche un autore americanissimo come Saul Bellow trovò la sua vera voce a Parigi, dove con una borsa di studio stava faticosamente tentando di mettere insieme il suo terzo romanzo. Una mattina la luce riflessa sull’acqua degli scoli lungo i marciapiedi suscitò in lui una specie di rivelazione. II nostro rincasò, cestinò gli appunti e ricominciò daccapo. «Avevo dietro di me venti anni di esperienza da sfruttare.» Richiamò il mondo della sua adolescenza multietnica a Chicago; abbandonò il corretto inglese che si sforzava di imitare; recuperò le colorite inflessioni del suo quartiere. Cosi nacque Le avventure di Augie March, il suo primo successo, secondo la rievocazione che egli stesso fece al collega più giovane Philip Roth in una serie incompiuta di conversazioni autobiografiche. Queste fanno parte dell’odierna raccolta di saggi bellowiani curata da Luca Briasco, raccolta che mantiene il titolo di quella, anni addietro, di Benjamin Taylor ma ne riduce considerevolmente la mole – da 57 pezzi a 21- privilegiando, direi, quelli in cui Bellow parla soprattutto di se stesso. Ciò sembra peraltro in carattere con tutta la sua opera narrativa maggiore, che è sempre largamente autobiografica. Nei saggi torna più volte l’interrogativo di Bellow sulla propria identità di scrittore. Scrittore ebreo o americano? Prima americano e poi ebreo, ripete. Da giovane, a Chicago, «non andavo in biblioteca per leggere il Talmud, ma i romanzi e le poesie di Sherwood Anderson, Theodore Dreiser, Edgar Lee Masters e Vachel Lindsay.» Ormai famoso, incontra a Gerusalemme il decano degli scrittori israeliani, S.Y. Agnon, che gli rimprovera bonariamente di non usare l’ebraico: secondo quell’ortodosso solo a quanto è scritto in ebraico è garantita l’immortalità. Ma Bellow, che pure rivendica l’ebraicità della propria tradizione, osserva in molti luoghi di questo libro che lo scrittore, e particolarmente lo scrittore cresciuto in una terra dove tutti sono figli di immigrati sradicati dalla loro, ha il diritto di scegliere la lingua che vuole. L’importante è il contatto col pubblico. Quanta parte della grande letteratura moderna è di cosiddetti «métèques»? Conrad, Apollinaire, Babel’, Mandel’stam, Kaflka, Svevo, Naipaul, Nabokov… Non sorprendentemente, di letteratura Bellow si occupa spesso in queste pagine, anche in chiave polemica. Certi argomenti sono datati, vedi la «querelle» tra arte e scienza, fuoco di paglia degli anni 70. Bellow vi interviene mettendo in ridicolo delle affermazioni di Arthur Clarke (vi ricordate Odissea nello spazio?), cui contrappone un peso massimo. «L’Ulisse di Joyce non si occupa direttamente di tecnologia. Ciononostante, rimane il romanzo più moderno del ventesimo secolo: il resoconto più veritiero della vita umana nell’era dei manufatti». L’argomentazione è discutibile, ma poco dopo Bellow si lascia sfuggire le ragioni principali della sua ammirazione per questo capolavoro, ovvero che il suo protagonista è un ometto qualunque, e comico. Sono due punti su cui Bellow ha da dire parecchio. Il fatto che la narrativa moderna ha liquidato per sempre il protagonista romantico in favore appunto di un personaggio senza distinzioni (non usa il termine di antieroe, ma ama sottolineare come costui invece che concentrato su uno scopo sia spesso addirittura distratto); e la fondamentale importanza della comicità. Altrove Bellow cita G.B. Shaw quando dice che ogni sovrano ha bisogno di almeno un suddito sleale, e questo è il buffone. II comico è dunque per Bellow l’elemento centrale di tutta la narrativa davvero importante, al punto di fargli annoverare tra gli autori fondamentalmente comici persino Tolstoj e Dostoevskij. Nell’atteggiamento verso i contemporanei Bellow è appassionato, e mai conformista. In un lungo saggio-rassegna del ’63 mette a confronto due testimonianze inquietanti anche se non proprio ben scritte, Ivan Denisovic di Solzenicyn e La lunga linea rossa di James Jones, prima di segnalare l’esordiente Philip Roth e di apprezzare Salinger (più per i racconti che per il romanzo), e infine di approdare a un originale confronto tra Lolita e Morte a Venezia di Thomas Mann. Altro tema ricorrente della raccolta è il disprezzo per certa critica paludata che complica la letteratura invece di facilitarne l’accesso. L’atteggiamento di Bellow verso l’Università, dove pure insegnò per molti anni, è così ambivalente: lecito per gli scrittori appoggiarvisi onde trarne indipendenza economica, ma orrore per chi insegna a frugare nei testi alla ricerca di chissà quali astrusità. Tale diffidenza accompagna Bellow per tutta la vita. Ancora nel 1992 è diretta contro gli eredi dei «maître à penser» tromboni della sua giovinezza (H.GWells, Romain Rolland, Havelock Ellis…), che ravvisa negli anchormen televisivi, contraddistinti anche dall’acconciatura. «Cosa piuttosto strana, i tribuni di oggi (non magistrati scelti dal popolo), con le loro capigliature mastodontiche, offrono quanto di più simile sia dato trovare alle parrucche di Versailles o della Corte di San Giacomo». Come si vede, qua e là guizza il ben noto sarcasmo, e Luca Briasco si è adoperato a renderlo adeguatamente. Peccato solo che, lui quoque, soggiaccia alla prassi dilagante di ignorare che l’aggettivo «trivial», prediletto da Bellow, non significa affatto in italiano «triviale» ossia «volgare», bensì «leggero», «di scarso peso».
Masolino D’Amico, La Stampa Tuttolibri, 14 ottobre 2017
