Società – Europa, attenta i populismi ti devasteranno
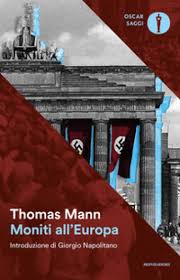 Thomas Mann / MONITI ALL’EUROPA / Mondadori
Thomas Mann / MONITI ALL’EUROPA / Mondadori
AI fatale 1933 si giunge sull’onda di quel fanatismo in cui Thomas Mann aveva colto con orrore il precipitare del vero e proprio imbarbarimento del suo Paese. Tra i cupi bagliori dell’incendio del Reichstag, preludio all’annientamento di ogni opposizione e libertà politica, e col compiersi dei bestiali massacri orditi dalle SS, Adolf Hitler – spazzato via ogni vecchio argine costituzionale – conquista e prende interamente nelle sue mani il potere. Se con l’estremo Un appello alla ragione Mann si era ancora rivolto ai Tedeschi, egli riprenderà la penna per mettere in guardia più in generale gli Europei dalla minaccia che sta per investire l’intero vecchio Continente e la pace mondiale. Lo fa con vari saggi che saranno via via pubblicati nel 1937 e nel 1938. Vale la pena di parlarne qui, a cominciare dal saggio del 1935, che dà il titolo Attenzione, Europa! all’intera raccolta. Il saggio di cui parlo è di tenore e spessore propriamente culturale, partendo da quelle che Mann considera le «orrende attuali condizioni dell’Europa». Un’Europa, non dimentichiamolo, che ha fatto la sua prima esperienza dittatoriale e totalitaria col fascismo italiano, con Benito Mussolini, il cui esempio non a caso è diventato punto di riferimento ideologico e propagandistico per la strategia di Hitler, come lo stesso Mann non ha mancato di sottolineare. In questo Attenzione, Europa! non viene mai citato il caso tedesco, quasi che esso potesse considerarsi a sé stante e chiuso in sé; si fa chiarezza tuttavia su ciò che non solo in Germania è ormai messo drammaticamente in questione. Innanzitutto le libertà civili e politiche in quella che si profila come l’era delle dittature, in primo luogo nella Spagna con la sedizione militare di Franco all’indomani della vittoria elettorale del Fronte Popolare e anche su ciò Mann prende nettamente posizione). La sedizione franchista sfociò in una guerra civile presto apertamente internazionalizzatasi. E viene insieme messa in questione la cultura, presidio prezioso fin quando essa rappresentava «il contrario della volgarità e della povertà umana» e in quanto «forma, volontà di libertà e di verità». Ma c’è di più: l’emergere in Europa di tendenze autoritarie di estrema destra ferisce mortalmente la dimensione e la valenza dell’individuo, sacrificate alla esaltazione della «vita collettiva». Mann vi reagisce, e splendida appare la sferzante valutazione dell’abbandonarsi alla suggestione della «ebbrezza collettivistica» come «liberazione dall’Io, … dalla moralità e dalla razionalità, … da ogni responsabilità individuale». Un’esperienza che in qualche modo «appartiene alla guerra». Egli non esita a difendere e valorizzare l’eredità dell’Ottocento, di quell’idealismo, di quella democrazia liberale che rischiano di esser travolti dalla «enorme ondata di barbarie eccentrica e di triviale volgarità primitiva democratico-plebea, che è stata sollevata dalla guerra e passa ora sul mondo». Questo saggio manniano è una lezione di storia del pensiero moderno, ed è una durissima messa in guardia contro il pericolo della «rovina della civiltà». E al tempo stesso, nel fare ancora i conti con la forza ambigua del sentimento patriottico, il grande intellettuale interprete del Novecento afferma: ogni radicale «dissidio tra patria e cultura» non può che essere «la sventura di tutti». A questo punto, è indispensabile tornare alla catastrofe del 1933, alla sanguinosa vittoria e all’inizio dell’opera di costruzione totalitaria di Hitler e della sua strategia razzista e bellicista. Egli sarà poi tra i primi, nel radiomessaggio del 27 settembre 1942, a dare notizie puntuali dell’attuarsi del criminale, mostruoso programma nazista di sterminio del popolo ebraico. Elenca, per farle conoscere agli stessi Tedeschi, le cifre spaventose degli ebrei uccisi in Polonia, dei deportati da Parigi in carri bestiame, dei tanti massacrati «in campi di esecuzione» col «gas venefico». Tuttavia, gli anni iniziali della dittatura hitleriana trascorrono senza che Thomas Mann si pronunci. Fino al 1936. In realtà, già ben prima Mann percorre l’Europa portando in molti Paesi il messaggio delle sue conferenze, di alta cultura e di vibrante passione ideale, accolte dovunque con il massimo interesse e successo. La sua è una vera e propria peregrinazione, durata sette mesi, fuori della Germania, in quanto lì sono già iniziate contro di lui odiose e minacciose misure ostili (come la confisca dell’abitazione a Monaco), e ormai appare concreto il rischio che a un suo ritorno in patria possa scattare il mandato d’arresto. Thomas e Katja Mann soggiornano a lungo ad Arosa in Svizzera, si recano per un periodo anche nel Sud della Francia, decidendo infine di stabilirsi nei pressi di Zurigo, a Küsnacht. Tuttavia, altre preoccupazioni e convinzioni lo trattengono ancora dallo sfidare in modo irrevocabile il regime di Hitler, e di questo egli parlerà ampiamente dopo aver deciso di cogliere l’occasione più opportuna per rompere ogni indugio e tagliare tutti i ponti. Si tratta dell’occasione offertagli da una «provocazione» di Eduard Korrodi, storico e studioso di letteratura sul tema degli scrittori tedeschi già stabilitisi fuori della Germania e di quelli rimasti ancora residenti in patria. Mann replica indirizzandogli il 3 febbraio 1936 una lettera che va ben oltre quella polemica specifica. La decisione di inviarla è tormentatissima, lo scrittore resta in bilico per qualche giorno. Essa contiene parole irrevocabili: «Non si è Tedeschi se si è nazionalisti. Ma l’odio tedesco, o almeno quello dei governanti tedeschi contro gli ebrei non si rivolge, dal punto di vista spirituale, contro gli ebrei stessi, o non a loro soltanto: si rivolge contro l’Europa e… contro le fondamenta classiche e cristiane della civiltà occidentale». E ancora: «La profonda convinzione … che nulla di buono può derivare, né per la Germania né per il mondo, dall’attuale regime tedesco, questa convinzione mi ha spinto a evitare il Paese nella cui tradizione spirituale sono … profondamente radicato». L’impatto è fortissimo, la reazione del regime è drastica. Al più grande scrittore di lingua tedesca viene strappata la cittadinanza tedesca, e addirittura cancellata la laurea ad honorem conferitagli dall’Università di Bonn. La secca comunicazione indirizzatagli dal Preside della Facoltà di Filosofia offre a Mann l’occasione di scrivere una lunga, rivelatrice ricostruzione del proprio atteggiamento negli anni precedenti e della propria decisione. La si legge in Un carteggio incluso anch’esso nella raccolta Attenzione, Europa! Egli spiega di avere «negli ultimi quattro anni provocato il furore di coloro che stavano al potere col suo rimanere al di fuori, con le manifestazioni insopprimibili del suo orrore. … Quando poi la Germania fu veramente caduta in quelle mani» aggiunge in prima persona Mann, «decisi di tacere; pensavo di essermi meritato, con i miei sacrifici, il diritto ad un silenzio che mi avrebbe reso possibile di conservare qualcosa che mi stava molto a cuore: il contatto col mio pubblico all’interno della Germania». La rivendicazione di quel diritto esprimeva la speranza, forse ingenua, di non perdere – pur restando lontano dalla Germania – il rapporto con i Tedeschi e con la stessa patria. Di qui il tormento che poi accompagnò la decisione dell’estrema rottura In una intensa versione romanzata di quei giorni della scrittrice Britta Bóhler, si attribuisce a Mann il sentimento che non gli si possa portare via la Germania, che dove sarà lui, lì sarà la Germania. E, animato effettivamente da questa fiducia, il 9 febbraio 1936 Mann scrive a Hermann Hesse: «non si rattristi del passo che ho compiuto! … io credo di aver fatto ciò ch’era giusto al momento giusto, “e da allora mi sento meglio”, come dice la canzone».
Giorgio Napolitano, La Stampa Tuttolibri, 25 novembre 2017
