Storia – Il fascismo e il (benevolo) sguardo Usa
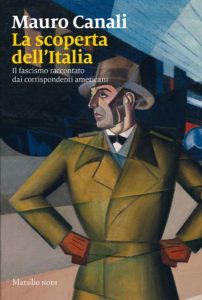 Mauro Canali / LA SCOPERTA DELL’ITALIA / Marsilio
Mauro Canali / LA SCOPERTA DELL’ITALIA / Marsilio
Negli anni Venti del Novecento e per una buona metà del decennio successivo l’atteggiamento di gran parte della stampa statunitense verso il regime fascista fu improntato in genere da valutazioni di segno positivo, quando non da giudizi talmente elogiativi da risultare, in parecchi casi, apologetici. In pratica, ci vollero l’aggressione all’Etiopia, la partecipazione dell’Italia alla guerra civile spagnola a soccorso di Franco e il suo progressivo abbraccio alla Germania nazista per segnare una svolta negli orientamenti espressi, sino ad allora, da quasi tutti i corrispondenti americani nei loro dispacci da Roma. A ispirare la commistione fra la simpatia e l’idillio, che per lungo tempo caratterizzò le visuali di tanti giornalisti e “inviati speciali”, ancorché autorevoli, avvicendatisi in Italia dagli Stati Uniti, fu la scoperta di un personaggio come Mussolini che ben si prestava ad alimentare l’interesse del pubblico americano. Il suo passato di socialista rivoluzionario convertitosi agli ideali nazionalistici e divenuto poi leader indiscusso di un movimento politico che si proponeva di forgiare il destino di un Paese, che sino a poco tempo prima era apparso sull’orlo di una rivoluzione proletaria, attrasse l’attenzione di un crescente stuolo di cronisti e commentatori non solo d’Oltreatlantico. D’altronde il fatto che, dopo la sua ascesa al potere, Mussolini avesse proclamato di voler realizzare una «terza via» fra capitalismo e comunismo aveva contribuito a concentrare sulla sua figura molti riflettori tanto da parte degli ambienti politici conservatori che di quelli progressisti. L’instaurazione di un sistema totalitario, quale si profilò con le “leggi fascistissime” del novembre 1926 e venne poi consolidandosi con l’impronta cesarista del duce, fu considerato, per lo più, nel mondo anglosassone alla luce del decisionismo e dell’iperattivismo di Mussolini, della sua ferrea volontà di imporre determinate regole e direttive di marcia a un popolo ritenuto, all’estero, sostanzialmente anarchico e ingovernabile nell’ambito di istituzioni liberali. Fu quindi anche in base a certi stereotipi tradizionali sul nostro Paese che numerosi giornalisti, insieme a vari diplomatici ed esponenti politici, concorsero ad accreditare in Europa e altrove l’avvento della dittatura fascista D’altra parte, se essi divennero poi dei suoi estimatori, lo si deve anche alle suggestioni destate in loro da quel tanto di vernice modernizzante (tra opere pubbliche, incentivi all’industrializzazione, bonifiche agricole e iniziative dopolavoristiche) spalmato dal regime sul corpo di una società che avevano considerato congeneticamente immobile e arretrata. Di qui la spiegazione che molti giornalisti americani, e non solo loro, diedero della popolarità di cui il duce godeva fra le masse e il ceto medio. Tanto il Minculpop che il ministero degli Esteri esercitarono un rigido controllo sia sui reportage dei corrispondenti americani e di altri Paesi, sia sulle fonti delle loro notizie (tramite una rete capillare di informatori e di intercettazioni telefoniche): così da blandire, all’occorrenza, quanti erano inclini a enfatizzare l’operato del dittatore, o da condizionare, minacciando di espellerli su due piedi, quanti erano invece portati a esprimere pur larvati motivi di dissenso. Ciò che emerge dall’analisi di Canali, suffragata da una vasta documentazione da lui rintracciata anche in archivi privati di vari giornalisti e testate americane, risulta inoltre come sovente si poneva ad alcuni corrispondenti un dilemma di deontologia professionale fra la libertà di investigare al di là di qualsiasi veto o il rischio di scontrarsi con i vincoli del Regime e di dover quindi abbandonare l’Italia, accusati di essere dei “piantagrane”, non senza un serio danno per il proprio giornale, in quanto restava perciò privo di un proprio ufficio di corrispondenza da Roma. Di fatto fu sul terreno della politica estera che si consumò pressoché definitivamente, nella seconda metà degli anni Trenta, l’indirizzo improntato da un tendenziale apprezzamento oda un benevolo attendismo nei riguardi dell’Italia fascista prevalso sino ad allora tra i corrispondenti americani. E che aveva contribuito, di riflesso, alle credenziali acquisite da Mussolini in vari settori della classe politica e dell’opinione pubblica Usa.
Valerio Castronovo, Il Sole 24 Ore Domenica, 11 febbraio 2018
