Orizzonti – L’ambasciatore, il cardinale, il presidente e il re
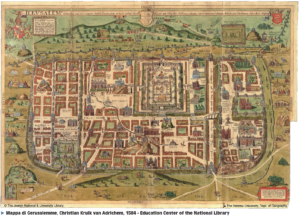 Nel dicembre 1994 accompagnai l’Ambasciatore Lopez in udienza dall’arcivescovo di Torino. Era il primo rappresentante ufficiale dello Stato d’Israele presso il Vaticano all’indomani dell’apertura delle relazioni diplomatiche. Quando il cardinale ci accolse, l’ambasciatore si rivolse a lui in perfetto italiano: “Eminenza, Le porto i saluti della mia città, Gerusalemme”. Il prelato allargò le braccia e rispose: “Gerusalemme è anche la mia città”. Di rimando immediato, il diplomatico israeliano osservò allora: “Sì, ma io ci sono nato!”. L’uomo di chiesa ammutolì. I dati di fatto parlano da soli. Nel dicembre scorso, dopo la dichiarazione con cui Donald Trump proclamava Gerusalemme capitale dello Stato d’Israele e annunciava il trasferimento dell’ambasciata americana, alcuni reagirono indignati sostenendo che non c’è alcun legame fra Gerusalemme e il popolo ebraico. Quella che sul piano storico-politico potrebbe essere liquidata come una battuta di dubbio gusto, costituisce in realtà una profonda asserzione sul piano teologico. Una volta revocata l’Alleanza a seguito della nuova Rivelazione che gli Ebrei hanno rifiutato – sosterranno i teologi sia cristiani che musulmani – anche i luoghi della Rivelazione sono passati sotto altro padrone e della vecchia relazione non esiste più traccia. Alla base della questione Gerusalemme, intendo dire, non c’è una problematica politica, bensì squisitamente religiosa. E ciò richiede la massima attenzione. Se infatti la politica si presta a giochi mutevoli a seconda degli interessi del momento, la religione si fonda su valori assoluti. Per questa ragione il conflitto su Gerusalemme, se lasciato alla discrezione delle parti, non sarà mai risolto. Neanche la millantata proposta di internazionalizzare la città troverà mai un accordo. Basti osservare a titolo d’esempio ciò che accade a Hebron, dove la grotta di Makhpelah è tuttora sottoposta a giurisdizione musulmana e a noi Ebrei viene impedito, con la sola eccezione di due giorni all’anno, l’accesso al piano sotterraneo che ospita secondo la tradizione le tombe dei Patriarchi. Lo stesso accadrebbe verso i Cristiani e questi lo sanno bene. L’atteggiamento esclusivista di almeno una delle religioni coinvolte nei confronti delle altre impedisce di fatto qualsiasi progresso nella trattativa. Gli unici nella Storia recente ad avere dimostrato di garantire libertà di accesso ai Luoghi Santi per ciascuno siamo stati noi. E anche questo è risaputo. Insomma, lo status quo è il male minore per tutti. Noi Ebrei non abbiamo interesse a mutarlo, né ad appoggiare alcuna iniziativa che lo faccia scricchiolare. Il libro di Devarim parla tante volte di Gerusalemme come centro politico e spirituale del nostro popolo, senza tuttavia mai nominarla: “perché soltanto nel luogo che il S. vostro D. sceglierà fra tutte le vostre tribù per collocarvi il Suo Santuario, là, nella Sua residenza, Lo ricercherete e là andrete. Ivi porterete i vostri sacrifici…” (12, 5-6). Maimonide nota questo fatto e fornisce tre ragioni: 1) evitare che i Cananei che allora possedevano Gerusalemme la distruggessero in previsione della conquista israelitica; 2) evitare lo scontro interno fra le tribù d’Israele che avrebbero cercato di impadronirsi della capitale per includerla nel proprio territorio qualora il nome fosse stato rivelato in anticipo. Secondo una tradizione questo problema avrebbe trovato soluzione nel fatto che all’epoca del Tempio Gerusalemme divenne una sorta di “District of Columbia”, non appartenente a nessuna tribù in particolare (Meghillah 26a); 3) evitare lo scontro delle nazioni che avrebbero a loro volta scatenato una guerra per impadronirsi della capitale d’Israele una volta divenuta manifesta l’importanza di Gerusalemme per la nostra religione (Moreh Nevukhim 3,45). A distanza di secoli è la Torah stessa a insegnarci prudenza. Siamo abituati a vivere di dati di fatto, senza bisogno di proclami e dichiarazioni di sorta. Dopo sette anni di regno a Hebron il re David decise di trasferirsi a Gerusalemme, forse proprio per considerazioni politiche: la centralità del luogo nel paese, le vie di comunicazione, la conquista relativamente tarda che garantiva l’indipendenza dalle singole tribù ecc. Ma credo che il momento storico che ha consacrato Gerusalemme a capitale eterna di Israele sia stato un evento successivo. David dovette poi abbandonare Gerusalemme sotto le pressioni di suo figlio Avshalom che si era ribellato al padre. Il testo biblico racconta che lungo la strada incontrò Tzadoq e Eviatar con i Kohanim del Tempio che avevano deciso di unirsi a lui nella fuga portando con sé l’Arca, ma David li respinse e intimò loro di tornare indietro (2Shemuel 15, 23 sgg.). David avrebbe potuto mettere i simboli della religione alla mercé della propria causa e invece non lo fece. Il sacro non può essere messo al servizio dell’individuo, anche se potente. David preferì rispettare lo status della città a scapito del suo destino personale. Gerusalemme non si tocca. Gerusalemme è troppo elevata spiritualmente perché possa prestarsi a giochi di potere. Per tale ragione in questo capitolo Gerusalemme è chiamata con il suo nome: “- Torna dunque in pace (shalom) -… Tzadoq e Eviatar riportarono l’Arca a Gerusalemme (Yerushalaim) e lì rimasero” (v. 27-29). Non sappiamo che cosa esattamente abbia mosso il Presidente degli Stati Uniti a fornire la sua dichiarazione. Da un lato gli siamo grati per il pensiero, ma dall’altro non ci formalizziamo più di tanto se anche le ambasciate dovessero rimanere a Tel Aviv. Riteniamo anzi che Gerusalemme debba stare fuori dalla politica. Proprio per il ruolo religioso che riveste. Nell’interesse di tutti.
Nel dicembre 1994 accompagnai l’Ambasciatore Lopez in udienza dall’arcivescovo di Torino. Era il primo rappresentante ufficiale dello Stato d’Israele presso il Vaticano all’indomani dell’apertura delle relazioni diplomatiche. Quando il cardinale ci accolse, l’ambasciatore si rivolse a lui in perfetto italiano: “Eminenza, Le porto i saluti della mia città, Gerusalemme”. Il prelato allargò le braccia e rispose: “Gerusalemme è anche la mia città”. Di rimando immediato, il diplomatico israeliano osservò allora: “Sì, ma io ci sono nato!”. L’uomo di chiesa ammutolì. I dati di fatto parlano da soli. Nel dicembre scorso, dopo la dichiarazione con cui Donald Trump proclamava Gerusalemme capitale dello Stato d’Israele e annunciava il trasferimento dell’ambasciata americana, alcuni reagirono indignati sostenendo che non c’è alcun legame fra Gerusalemme e il popolo ebraico. Quella che sul piano storico-politico potrebbe essere liquidata come una battuta di dubbio gusto, costituisce in realtà una profonda asserzione sul piano teologico. Una volta revocata l’Alleanza a seguito della nuova Rivelazione che gli Ebrei hanno rifiutato – sosterranno i teologi sia cristiani che musulmani – anche i luoghi della Rivelazione sono passati sotto altro padrone e della vecchia relazione non esiste più traccia. Alla base della questione Gerusalemme, intendo dire, non c’è una problematica politica, bensì squisitamente religiosa. E ciò richiede la massima attenzione. Se infatti la politica si presta a giochi mutevoli a seconda degli interessi del momento, la religione si fonda su valori assoluti. Per questa ragione il conflitto su Gerusalemme, se lasciato alla discrezione delle parti, non sarà mai risolto. Neanche la millantata proposta di internazionalizzare la città troverà mai un accordo. Basti osservare a titolo d’esempio ciò che accade a Hebron, dove la grotta di Makhpelah è tuttora sottoposta a giurisdizione musulmana e a noi Ebrei viene impedito, con la sola eccezione di due giorni all’anno, l’accesso al piano sotterraneo che ospita secondo la tradizione le tombe dei Patriarchi. Lo stesso accadrebbe verso i Cristiani e questi lo sanno bene. L’atteggiamento esclusivista di almeno una delle religioni coinvolte nei confronti delle altre impedisce di fatto qualsiasi progresso nella trattativa. Gli unici nella Storia recente ad avere dimostrato di garantire libertà di accesso ai Luoghi Santi per ciascuno siamo stati noi. E anche questo è risaputo. Insomma, lo status quo è il male minore per tutti. Noi Ebrei non abbiamo interesse a mutarlo, né ad appoggiare alcuna iniziativa che lo faccia scricchiolare. Il libro di Devarim parla tante volte di Gerusalemme come centro politico e spirituale del nostro popolo, senza tuttavia mai nominarla: “perché soltanto nel luogo che il S. vostro D. sceglierà fra tutte le vostre tribù per collocarvi il Suo Santuario, là, nella Sua residenza, Lo ricercherete e là andrete. Ivi porterete i vostri sacrifici…” (12, 5-6). Maimonide nota questo fatto e fornisce tre ragioni: 1) evitare che i Cananei che allora possedevano Gerusalemme la distruggessero in previsione della conquista israelitica; 2) evitare lo scontro interno fra le tribù d’Israele che avrebbero cercato di impadronirsi della capitale per includerla nel proprio territorio qualora il nome fosse stato rivelato in anticipo. Secondo una tradizione questo problema avrebbe trovato soluzione nel fatto che all’epoca del Tempio Gerusalemme divenne una sorta di “District of Columbia”, non appartenente a nessuna tribù in particolare (Meghillah 26a); 3) evitare lo scontro delle nazioni che avrebbero a loro volta scatenato una guerra per impadronirsi della capitale d’Israele una volta divenuta manifesta l’importanza di Gerusalemme per la nostra religione (Moreh Nevukhim 3,45). A distanza di secoli è la Torah stessa a insegnarci prudenza. Siamo abituati a vivere di dati di fatto, senza bisogno di proclami e dichiarazioni di sorta. Dopo sette anni di regno a Hebron il re David decise di trasferirsi a Gerusalemme, forse proprio per considerazioni politiche: la centralità del luogo nel paese, le vie di comunicazione, la conquista relativamente tarda che garantiva l’indipendenza dalle singole tribù ecc. Ma credo che il momento storico che ha consacrato Gerusalemme a capitale eterna di Israele sia stato un evento successivo. David dovette poi abbandonare Gerusalemme sotto le pressioni di suo figlio Avshalom che si era ribellato al padre. Il testo biblico racconta che lungo la strada incontrò Tzadoq e Eviatar con i Kohanim del Tempio che avevano deciso di unirsi a lui nella fuga portando con sé l’Arca, ma David li respinse e intimò loro di tornare indietro (2Shemuel 15, 23 sgg.). David avrebbe potuto mettere i simboli della religione alla mercé della propria causa e invece non lo fece. Il sacro non può essere messo al servizio dell’individuo, anche se potente. David preferì rispettare lo status della città a scapito del suo destino personale. Gerusalemme non si tocca. Gerusalemme è troppo elevata spiritualmente perché possa prestarsi a giochi di potere. Per tale ragione in questo capitolo Gerusalemme è chiamata con il suo nome: “- Torna dunque in pace (shalom) -… Tzadoq e Eviatar riportarono l’Arca a Gerusalemme (Yerushalaim) e lì rimasero” (v. 27-29). Non sappiamo che cosa esattamente abbia mosso il Presidente degli Stati Uniti a fornire la sua dichiarazione. Da un lato gli siamo grati per il pensiero, ma dall’altro non ci formalizziamo più di tanto se anche le ambasciate dovessero rimanere a Tel Aviv. Riteniamo anzi che Gerusalemme debba stare fuori dalla politica. Proprio per il ruolo religioso che riveste. Nell’interesse di tutti.
Rav Alberto Somekh, Pagine Ebraiche, maggio 2018
