STORIA Leo Diena, la Resistenza e la ricostruzione
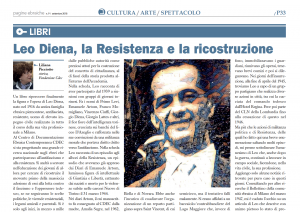 Anna Grasselli Diena, Clemente Diena / UNA RICERCA / SEB 27
Anna Grasselli Diena, Clemente Diena / UNA RICERCA / SEB 27
Un libro ripercorre finalmente la figura e l’opera di Leo Diena, nato nel 1916 da antica famiglia ebraica piemontese, antifascista, resistente, uomo di elevato impegno civile realizzato in tutto il corso della sua vita professionale a Milano. Al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC si sta progettando una grande ricerca nazionale sugli ebrei che parteciparono all’antifascismo e alla resistenza. Si andrà a scavare nell’educazione dei giovani di allora per cercare di ricostruire il movente primo della massiccia adesione di essi alla lotta contro il fascismo e l’oppressore tedesco, se ne seguiranno le scelte politiche, le vicende resistenziali, i legami amicali e parentali. Si è solo agli inizi, in mezzo a mille difficoltà. La principale è che non si hanno più a disposizione testimoni diretti da interrogare. Ne sopravvive un pugno in Piemonte; per il resto, ci si dovrà accontentare della letteratura e di un fondo archivistico molto importante che si trova presso il CDEC. È questo il frutto di una felice intuizione di un gruppo di giovani ebrei riunito nella Federazione Giovanile Ebrei d’Italia FGEI. Nella seconda metà degli Anni Cinquanta e negli Anni Sessanta del ‘900 si diedero come compito di ritrovare le tracce dell’impegno resistenziale dei padri o degli amici dei genitori, distribuendo decine di questionari e riunendoli in un fondo archivistico ad hoc creato, da consegnare alla storia. Il CDEC ha ereditato questo materiale, che costituisce anche uno dei primi nuclei fondanti del suo archivio come preziosa pietra miliare su qualsiasi ricerca si voglia condurre sugli ebrei partigiani. È del 1962 la scheda che fu sottoposta per la compilazione a Leo Diena; la riempì con entusiasmo e dovizia di notizie. Appare evidente la funzione di collettore di notizie di un istituto come il CDEC che, come gli istituti storici della Resistenza, dovrebbero essere considerati dalle pubbliche autorità come preziosi attori per la costruzione del concetto di cittadinanza, al di fuori della storia prodotta all’interno dell’Accademia. 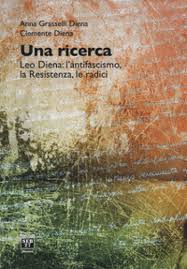 Nella scheda, Leo racconta di aver partecipato dal 1939 a riunioni con gruppi di giovani torinesi. Fa i nomi di Primo Levi, Emanuele Artom, Franco Momigliano, Vincenzo Ciuffi, Giorgio Diena, Giorgio Lattes e altri, il fior fiore dell’intelligenza torinese, cresciuta sui banchi del liceo D’Azeglio e rafforzata nelle sue convinzioni da una militanza morale che portava diritto dritto verso l’antifascismo. Nella scheda Leo racconta di un episodio agli albori della Resistenza, un episodio che avevamo già appreso dai Diari di Emanuele Artom, luminosa figura di intellettuale di Giustizia e Libertà, catturato dai nazisti e morto per le violenze subite nelle carceri Nuove di Torino il 31 marzo 1944. Nei diari Artom, il cui manoscritto fu consegnato al CDEC dalla madre, Amalia Segre, nel 1962, e curati recentemente da Guri Schwarz per una nuova edizione critica (dopo quella del 1966 a cura di Paola De Benedetti e Eloisa Ravenna), si parla di manifesti antisemiti cresciuti come funghi in via Roma a Torino tra il 15 e 20 ottobre 1941 e di odiose scritte murarie vergate con il gesso o con vernice indelebile. Una ventina di giovani ebrei, assieme a qualche amico non ebreo, strapparono quei manifesti e ripulirono i muri. Tra quei giovani vi era anche Leo Diena, già convinto aderente al movimento Giustizia e Libertà. Dopo l’8 settembre 1943, Leo entrò a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale CLN di Asti come rappresentante del Partito d’Azione. Ebbe parecchi incarichi tra cui quello di commissario politico e organizzatore sindacale. Partecipò anche alla pianificazione della resistenza in città e alla strutturazione dei primi nuclei partigiani nell’astigiano. Visitava reparti nel biellese e teneva i contatti con il CLN di Biella e di Novara. Ebbe anche l’incarico di coadiuvare l’organizzazione di un reparto partigiano sopra Saint Vincent, di cui facevano parte Primo Levi, Vanda Maestro, Guido Bachi, Aldo Piacenza e Luciana Nissim. Leo purtroppo giunse in Val d’Aosta il 14 dicembre 1943, il giorno dopo che i resistenti erano stati accerchiati dai fascisti, saliti in montagna con le scarpe avvolte da cotone per poterli sorprendere meglio. Messosi disperatamente a cercare il fratello Italo con la moglie incinta, rifugiatisi in una baita dei paraggi, ricevette da loro la tragica notizia. Vana fu l’idea di organizzare la fuga dal carcere di Aosta dei partigiani ivi imprigionati, il suo superiore nella Resistenza, Vittorio Foa, non volle rischiare di perdere altri uomini. Siamo in un mondo in cui le amicizie, le affinità culturali e valoriali contano moltissimo. Alla fine di febbraio del 1944 Leo perde un altro amico. Si tratta del giovane Franco Tedeschi, fidanzato della sorella di Primo, Annamaria Levi. Era stato Franco a trovare rifugio per la propria famiglia e per i Diena a Pratomorone di Asti presso la famiglia Ravera, una famiglia contadina la cui figlia era stata collaboratrice domestica in casa Tedeschi. Franco aveva tentato di portare in Svizzera l’anziano suo padre semicieco, ma il tentativo fallì malamente. Si erano affidati a un barcaiolo/contrabbandiere del Lago Maggiore che, invece di farli sbarcare in Svizzera, per errore li fece sbarcare in Italia, facile preda delle guardie di frontiera. I due furono portati al carcere di Varese, anticamera della terribile prigione di San Vittore di Milano e non ci fu più niente da fare. Leo sapeva che Franco era a Varese ma non riuscì ad organizzare la sua fuga. Leo, dal marzo del 1944, fu responsabile dell’organizzazione sindacale del Partito d’Azione a Torino in sostituzione di Franco Momigliano che aveva dovuto allontanarsi dalla città, per raggiungere le formazioni partigiane della val Pellice. Poco a poco riuscì a creare un vero e proprio comitato sindacale formato da uomini coraggiosi che continuavano a lavorare in fabbrica o che dovettero passare nella clandestinità perché ormai ricercati. Come una trottola, si occupava della distribuzione della stampa clandestina, della produzione e distribuzione di volantini in preparazione degli scioperi, di attivare piccoli raduni volanti all’interno delle fabbriche, che si interrompevano bruscamente in caso di pericolo. Nel 1945 fu mandato a Milano, dove partecipò ad azioni dimostrative all’interno delle fabbriche, assieme a partigiani che, appunto, penetravano negli stabilimenti, tagliavano i fili del telefono, immobilizzavano i guardiani, riunivano gli operai, tenevano brevi comizi e poi si dileguavano. Nei giorni dell’insurrezione, alla fine di aprile del 1945, troviamo Leo a capo di un gruppo partigiano che realizza diverse azioni in città, tra cui la cacciata del comando tedesco dall’Hotel Regina. Fece poi parte del CLN della Lombardia fino alla cessazione di questo nel 1946. Ma più che le azioni di militanza politica e di Resistenza, delle quali ho fatto qui una breve enumerazione saltando molti episodi, mi preme sottolineare l’umanesimo di Leo che, anche dopo la guerra, continuò a lavorare in campo sociale, facendone, nella vita civile, la sua professione. Aggiungo solo alcune notizie ritrovate per puro caso in questi giorni. Consultando per altre ricerche il Bollettino della comunità ebraica di Milano del marzo 1947, mi è caduto l’occhio su un articolo di Leo che descrive con animo pietoso lo stato di prostrazione, di desolante mancanza di averi e di speranze dei profughi, giunti attraverso la frontiera austriaca e accolti in via Unione 5. Era questa la nuova sede della comunità ebraica di Milano temporaneamente prestata dal Prefetto Riccardo Lombardi, giacché la sinagoga di via Guastalla, assieme alla maggior parte degli uffici, era in stato di macerie dopo il bombardamento dell’autunno del 1942. In via Unione 5 la comunità mosse i primi passi dopo le tragedie passate e attivò una mensa, una sinagoga, un ambulatorio, un ufficio ricerche degli scomparsi, un dormitorio, appunto, per quelli che fuggivano dai Paesi che avevano attentato alle loro vite. Via Unione è anche l’approdo del distaccamento partigiano proveniente dalla Russia che aveva girovagato, dopo la liberazione, per tutta Europa, descritto da Primo Levi nel suo romanzo Se non ora quando? uscito nel 1982. Leo, subito dopo la guerra, era stato dunque attivista anche della ricostruzione della comunità ebraica e frequentava Via Unione. La sua fu una vita piena di moralità e di impegno verso gli altri. È stata una di quelle persone che ci ha indicato la strada e siamo grati alla moglie e al figlio di avercelo ricordato attraverso questo libro.
Nella scheda, Leo racconta di aver partecipato dal 1939 a riunioni con gruppi di giovani torinesi. Fa i nomi di Primo Levi, Emanuele Artom, Franco Momigliano, Vincenzo Ciuffi, Giorgio Diena, Giorgio Lattes e altri, il fior fiore dell’intelligenza torinese, cresciuta sui banchi del liceo D’Azeglio e rafforzata nelle sue convinzioni da una militanza morale che portava diritto dritto verso l’antifascismo. Nella scheda Leo racconta di un episodio agli albori della Resistenza, un episodio che avevamo già appreso dai Diari di Emanuele Artom, luminosa figura di intellettuale di Giustizia e Libertà, catturato dai nazisti e morto per le violenze subite nelle carceri Nuove di Torino il 31 marzo 1944. Nei diari Artom, il cui manoscritto fu consegnato al CDEC dalla madre, Amalia Segre, nel 1962, e curati recentemente da Guri Schwarz per una nuova edizione critica (dopo quella del 1966 a cura di Paola De Benedetti e Eloisa Ravenna), si parla di manifesti antisemiti cresciuti come funghi in via Roma a Torino tra il 15 e 20 ottobre 1941 e di odiose scritte murarie vergate con il gesso o con vernice indelebile. Una ventina di giovani ebrei, assieme a qualche amico non ebreo, strapparono quei manifesti e ripulirono i muri. Tra quei giovani vi era anche Leo Diena, già convinto aderente al movimento Giustizia e Libertà. Dopo l’8 settembre 1943, Leo entrò a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale CLN di Asti come rappresentante del Partito d’Azione. Ebbe parecchi incarichi tra cui quello di commissario politico e organizzatore sindacale. Partecipò anche alla pianificazione della resistenza in città e alla strutturazione dei primi nuclei partigiani nell’astigiano. Visitava reparti nel biellese e teneva i contatti con il CLN di Biella e di Novara. Ebbe anche l’incarico di coadiuvare l’organizzazione di un reparto partigiano sopra Saint Vincent, di cui facevano parte Primo Levi, Vanda Maestro, Guido Bachi, Aldo Piacenza e Luciana Nissim. Leo purtroppo giunse in Val d’Aosta il 14 dicembre 1943, il giorno dopo che i resistenti erano stati accerchiati dai fascisti, saliti in montagna con le scarpe avvolte da cotone per poterli sorprendere meglio. Messosi disperatamente a cercare il fratello Italo con la moglie incinta, rifugiatisi in una baita dei paraggi, ricevette da loro la tragica notizia. Vana fu l’idea di organizzare la fuga dal carcere di Aosta dei partigiani ivi imprigionati, il suo superiore nella Resistenza, Vittorio Foa, non volle rischiare di perdere altri uomini. Siamo in un mondo in cui le amicizie, le affinità culturali e valoriali contano moltissimo. Alla fine di febbraio del 1944 Leo perde un altro amico. Si tratta del giovane Franco Tedeschi, fidanzato della sorella di Primo, Annamaria Levi. Era stato Franco a trovare rifugio per la propria famiglia e per i Diena a Pratomorone di Asti presso la famiglia Ravera, una famiglia contadina la cui figlia era stata collaboratrice domestica in casa Tedeschi. Franco aveva tentato di portare in Svizzera l’anziano suo padre semicieco, ma il tentativo fallì malamente. Si erano affidati a un barcaiolo/contrabbandiere del Lago Maggiore che, invece di farli sbarcare in Svizzera, per errore li fece sbarcare in Italia, facile preda delle guardie di frontiera. I due furono portati al carcere di Varese, anticamera della terribile prigione di San Vittore di Milano e non ci fu più niente da fare. Leo sapeva che Franco era a Varese ma non riuscì ad organizzare la sua fuga. Leo, dal marzo del 1944, fu responsabile dell’organizzazione sindacale del Partito d’Azione a Torino in sostituzione di Franco Momigliano che aveva dovuto allontanarsi dalla città, per raggiungere le formazioni partigiane della val Pellice. Poco a poco riuscì a creare un vero e proprio comitato sindacale formato da uomini coraggiosi che continuavano a lavorare in fabbrica o che dovettero passare nella clandestinità perché ormai ricercati. Come una trottola, si occupava della distribuzione della stampa clandestina, della produzione e distribuzione di volantini in preparazione degli scioperi, di attivare piccoli raduni volanti all’interno delle fabbriche, che si interrompevano bruscamente in caso di pericolo. Nel 1945 fu mandato a Milano, dove partecipò ad azioni dimostrative all’interno delle fabbriche, assieme a partigiani che, appunto, penetravano negli stabilimenti, tagliavano i fili del telefono, immobilizzavano i guardiani, riunivano gli operai, tenevano brevi comizi e poi si dileguavano. Nei giorni dell’insurrezione, alla fine di aprile del 1945, troviamo Leo a capo di un gruppo partigiano che realizza diverse azioni in città, tra cui la cacciata del comando tedesco dall’Hotel Regina. Fece poi parte del CLN della Lombardia fino alla cessazione di questo nel 1946. Ma più che le azioni di militanza politica e di Resistenza, delle quali ho fatto qui una breve enumerazione saltando molti episodi, mi preme sottolineare l’umanesimo di Leo che, anche dopo la guerra, continuò a lavorare in campo sociale, facendone, nella vita civile, la sua professione. Aggiungo solo alcune notizie ritrovate per puro caso in questi giorni. Consultando per altre ricerche il Bollettino della comunità ebraica di Milano del marzo 1947, mi è caduto l’occhio su un articolo di Leo che descrive con animo pietoso lo stato di prostrazione, di desolante mancanza di averi e di speranze dei profughi, giunti attraverso la frontiera austriaca e accolti in via Unione 5. Era questa la nuova sede della comunità ebraica di Milano temporaneamente prestata dal Prefetto Riccardo Lombardi, giacché la sinagoga di via Guastalla, assieme alla maggior parte degli uffici, era in stato di macerie dopo il bombardamento dell’autunno del 1942. In via Unione 5 la comunità mosse i primi passi dopo le tragedie passate e attivò una mensa, una sinagoga, un ambulatorio, un ufficio ricerche degli scomparsi, un dormitorio, appunto, per quelli che fuggivano dai Paesi che avevano attentato alle loro vite. Via Unione è anche l’approdo del distaccamento partigiano proveniente dalla Russia che aveva girovagato, dopo la liberazione, per tutta Europa, descritto da Primo Levi nel suo romanzo Se non ora quando? uscito nel 1982. Leo, subito dopo la guerra, era stato dunque attivista anche della ricostruzione della comunità ebraica e frequentava Via Unione. La sua fu una vita piena di moralità e di impegno verso gli altri. È stata una di quelle persone che ci ha indicato la strada e siamo grati alla moglie e al figlio di avercelo ricordato attraverso questo libro.
Liliana Picciotto, Pagine Ebraiche, settembre 2018
