MEMORIA «La mamma si vestì da suora, così la Chiesa fiorentina salvò noi ebrei»
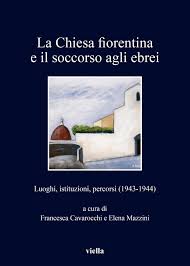 Francesca Cavarocchi e Elena Mazzini (a cura di) / LA CHIESA FIORENTINA E IL SOCCORSO AGLI EBREI / Viella
Francesca Cavarocchi e Elena Mazzini (a cura di) / LA CHIESA FIORENTINA E IL SOCCORSO AGLI EBREI / Viella
Settantacinque anni dopo la deportazione degli ebrei fiorentini arriva la più completa ricerca sull’opera della Chiesa fiorentina nel soccorso degli ebrei perseguitati dalle leggi razziste e dal regime nazi-fascista. E si scopre non solo l’eccezionalità di quanto accaduto a Firenze, con Diocesi e l’associazione ebraica Delasem affiancate ed unite fin dall’inizio, ma anche che furono ben 42 i conventi, monasteri, istituti religiosi cattolici che divennero un rifugio, molti di più di quanto finora conosciuto. E si scoprono o riscoprono i nomi di chi si salvò, memorie inedite, frutto di tre anni di lavoro, scaturito dall’evento nel 2012 della proclamazione di Giusto tra le Nazioni del cardinale Elia Dalla Costa che volle e guidò la rete di salvataggio. L’ampiezza e profondità delle iniziative del 1943-44 sono il tema del libro «La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei» a cura di Francesca Cavarocchi e Elena Mazzini e promosso dall’Istituto storico toscano della Resistenza, con il contributo del ministero dei beni culturali, della Fondazione Cr Firenze e dell’associazione Amicizia ebraico-cristiana di Firenze. Un volume in cui la mappa dei 42 luoghi di rifugio è accompagnato per ciascuno da una scheda che ricostruisce tutta la memoria del luogo e le 83 memorie autonarrative danno informazioni spesso inedite e che rischiavano di andare perdute, ottenute incrociando gli archivi della Diocesi con quelli della Comunità ebraica, degli istituti religiosi. II libro è stato presentato ieri all’istituto dal direttore Matteo Mazzoni, da Elena Mazzini e dalla storica Marta Baiardi, assieme ad Umberto Di Gioacchino e Guidobaldo Passigli, bambini che furono messi in salvo grazie all’alleanza tra la Chiesa cattolica e le organizzazioni ebraiche e che sono diventati testimoni della tragedia della Shoah. Di due delle tante vite normali e felici — come nelle foto che ritraggono le loro famiglie prima della bufera razzista — trasformate per sempre anche quando alcuni si sono salvati. Umberto Di Gioacchino aveva meno di 4 anni e fu protetto nel Convento delle suore di Santa Marta a Settignano, guidato da madre Benedetta Vespignani, da dove dopo sei mesi un’amica cattolica dei genitori lo portò al Colle di Compito in provincia di Lucca. Guidobaldo Passigli e sua nonna Darla Modena Mondolfi, a cui si aggiunse poi la madre Albana Mondolfi Passigli, su indicazione del parroco di Grassina, don Dino Vezzosi, furono accolti all’Istituto delle suore del patrocinio di Perugia, in via del Guarlone, guidato da suor Rosaide, Vincenza Orlando. «Mi ricordo mamma e nonna vestite da suora e io fui istruito a non dire a nessuno il mio vero nome — dice Passigli — Rimasi lì quasi un anno e nessuno tentò di convertirmi. Voglio presentare la candidatura a Giusto tra le Nazioni per l’istituto delle suore e per una famigli che ospitò mia mamma». Di Gioacchino, il cui zio era il rabbino Nathan Cassuto, deportato e morto ad Auschwitz assieme alla moglie, ricorda poco delle suore, ma bene «il tedesco alto, biondo, un ufficiale che era un “tedesco buono”, ci disse che lui faceva la guerra solo ai soldati». «Anche gli italiani non erano tutti uguali, ci fu chi denunciava e chi salvava — sottolinea Baiardi — Come ci furono conventi che non aprirono le porte, nonostante la direttiva del cardinale Dalla Costa». «Questa ricerca ha un valore civile: c’è bisogno di restituire verità alla storia a fronte delle tendenze negazioniste», conclude Mazzoni.
Mauro Bonciani, Corriere Fiorentino, 7 novembre 2018
