NARRATIVA I resti della nostra infanzia ungherese
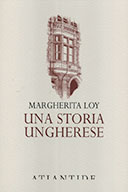 Margherita Loy / UNA STORIA UNGHERESE / Atlantide
Margherita Loy / UNA STORIA UNGHERESE / Atlantide
Dall’1 gennaio 1945 ad aprile inoltrato di quello stesso anno una ragazza racconta al suo diario l’assedio di Buda. Con la madre, il fratello e la fidanzata di lui si è rifugiata nella cantina, fredda, gremita, mentre il palazzo sovrastante viene via via sgretolato dall’onda d’urto delle bombe che cadono tutt’intorno. L’armata rossa è a pochi chilometri da Pest, l’esercito ungherese allo sbaraglio, ma i tedeschi non mollano. Kinga, ventunenne immaginaria, è l’artificio con cui Margherita Loy ha deciso di narrare Una storia ungherese, precipitato romanzesco degli indizi sbocconcellati che il suocero Manfredo fece trapelare in vita a proposito della sua infanzia e del suo paese, di cui non parlava volentieri. «Se fai troppe domande mi costringerai a dirti qualche bugia», le rispose, consegnandole nondimeno 28 pagine dattiloscritte dal titolo The siege of Budapest, redatte dalla madre Alinka in inglese, e alcune foto di resti bruciati. A partire da questi documenti, Loy trova una sua strada, luminosa anche se dolorosa, tra i tetri ricordi che ogni famiglia si trasmette a proposito dell’ultima guerra e delle persecuzioni razziali. Ricordi che stanno diventando sempre più frammentari ed evanescenti man mano che gli ultimi testimoni perdono la lucidità e muoiono e su cui bisognerebbe soffiare, per ravvivarli, soprattutto ora che vacilla l’Europa costruita sopra quelle ceneri. Ricordi che si possono reinventare con la letteratura: «”Beauty is truth, truth beauty”, – that is all/ Ye know on earth, and all ye need to know» («”Bellezza è verità, verità bellezza,” – questo solo/ sulla terra sapete, ed è quanto basta») scriveva John Keats in Ode su un’urna greca. Con una leggerezza sapiente – che condivide con l’amica Pia Pera, scrittrice e collaboratrice di questo giornale scomparsa nel 2016, cui il libro è dedicato – Loy ricostruisce la cronaca delle astuzie per sopravvivere, delle sortite per procurarsi la carne dei cavalli morti, delle voci su ciò che accade fuori, gli stupri, i rastrellamenti e gli omicidi razziali, alternata a lunghe digressioni sui due anni che Kinga, tredicenne, lasciatasi alle spalle la fitta città, trascorse al confine nordorientale dell’Ungheria. Qui la nonna materna aveva una tenuta che dava le spalle alla puszta, la grande steppa dove le raffiche corrono senza incontrare ostacoli. «Certi giorni a Zsursk sembrava che l’azzurro fosse stato pennellato in modo uniforme dal vento, tanto il cielo era limpido e compatto». Kinga torna sempre con la mente a quel tempo non solo perché è stato il periodo più facile della sua vita, il principio, «come se qualcuno avesse iniziato a mettere creta su uno scheletro in ferro», ma anche perché qui aveva conosciuto e amato Gyalima, un giovane ebreo che da allora non ha più rivisto ma cui pensa in continuazione chiedendosi se sia riuscito a sfuggire agli assassini che in tutta l’Ungheria stanno cercando di annientare gli ebrei. I racconti umidi e scarni dei giorni passati in cantina si riempiono allora della luce che inondava i campi di tabacco e i meleti di Zsursk. È il ricordo di Gyalima a tenerla viva e umana nel lungo assedio. Fino a quando, allontanato il pericolo e costretta a fare i conti con quel che rimane, la memoria perde il suo effetto benefico e – come accade a molti sopravvissuti, alla guerra o anche solo alla vita – «ora temo ciò che avviene nella mia immaginazione, voglio restare attaccata alla vita. Poggiata la schiena sui gradini della fontana, sogno di mangiare, di riposarmi, di dormire».
Lara Ricci, Il Sole 24 Ore Domenica, 18 novembre 2018
