LETTERATURA “Dalla Diaspora a Israele, l’identità nei libri”
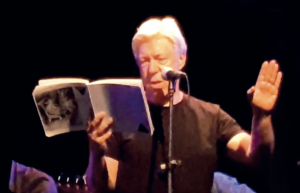 Se al centro di ogni individuo e comunità vi è un racconto, scritto oppure orale, attorno a cui costruire sé stessi e il proprio modo di guardare il mondo, questo è particolarmente vero per il popolo ebraico di cui prima matrice è la narrazione biblica. Nel corso di una conversazione nella sua casa di Gerusalemme, Ariel Hirschfeld, critico letterario e docente all’Università Ebraica, ci ha spiegato gli elementi di continuità e rottura tra la letteratura israeliana contemporanea e i tentativi di “scrivere in ebraico” che hanno attraversato le diverse diaspore europee, a partire da quella italiana.
Se al centro di ogni individuo e comunità vi è un racconto, scritto oppure orale, attorno a cui costruire sé stessi e il proprio modo di guardare il mondo, questo è particolarmente vero per il popolo ebraico di cui prima matrice è la narrazione biblica. Nel corso di una conversazione nella sua casa di Gerusalemme, Ariel Hirschfeld, critico letterario e docente all’Università Ebraica, ci ha spiegato gli elementi di continuità e rottura tra la letteratura israeliana contemporanea e i tentativi di “scrivere in ebraico” che hanno attraversato le diverse diaspore europee, a partire da quella italiana.
Ariel, qual è il ruolo della letteratura nella cultura ebraica? E che rapporto c’è tra letteratura ebraica, prodotta nella diaspora, e letteratura israeliana contemporanea?
La letteratura ebraica, in prosa e in poesia, è uno dei fenomeni più impressionanti e di rilievo prodotti dalla nuova cultura ebraica, sionista, israeliana – se è possibile utilizzare queste definizioni. È un successo sorprendente. Fino alla fine del XIX secolo la letteratura ebraica secolare è stata espressione di una minoranza che imitava in modo passivo le suggestioni dell’ambiente circostante, e sempre con grande ritardo. Prendiamo il caso dell’Italia, dove questo fenomeno è evidente. Tra gli esponenti dell’Haskalà ebraica vi è M. H. Luzzato: il suo modello è Tasso, un autore di centocinquant’anni precedente. È evidente che ciò non dipendeva da una sua scarsa competenza intellettuale. Il fatto è che la cultura ebraica, ovunque si trovasse, possedeva un suo proprio tempo, un orologio e un mondo autonomo. Poi, improvvisamente, alla fine del XIX secolo, con il sionismo, sia in prosa che in poesia emersero all’improvviso autori di un tale livello, che anche paragonandoli con i grandi occidentali, non solo non si prova vergogna, ma talvolta si percepisce persino che sono, per così dire, all’avanguardia. Non solo non imitavano in ritardo ciò che accadeva nell’ambiente circostante ma lo afferravano al volo creando a loro volta qualcosa di nuovo e autentico. Di Bialik e Tshernikhovski è possibile dire che, anche per via della loro agenda nazionale si trovano nella posizione, diciamo, per gli italiani, di Leopardi; ma se si guarda, per esempio, a Brenner e Gnessin, essi intrapresero ciò che Faulkner, Joyce e Woolf fecero 20 anni più tardi. E a un livello straordinario. Purtroppo una parte di queste opere sono accessibili solo a chi conosce l’ebraico. Solo una piccola parte, infatti, è tradotta e spesso, nelle traduzioni, si perde quella complessità storica, quella stratificazione, tipica dell’ebraico. La scena artistico-letteraria ebraica è davvero impressionante anche oggi. In nessun altro campo la cultura israeliana è stata così innovativa come in quello letterario. La spiritualità ebraica che era stata occupata per duemila anni quasi solo in un lavoro di interpretazione rivolto alle opere autorevoli del passato, improvvisamente ricevette una specie di libertà, la possibilità di slanciarsi in avanti, di procedere, e con la stessa sensibilità e spiritualità.
Dunque il sionismo ha giocato un ruolo fondamentale nella nascita della letteratura ebraica?
Sì, ma bisogna tenere in conto che l’elemento nazionale, in quanto tale, non costituisce motivo letterario. Certo, vi sono opere impegnate politicamente, ma in esse si sente che qualcosa non va, non procede, sono opere a tesi, un po’ come per D’Annunzio in Italia.
Tuttavia è sullo sfondo dell’entusiasmo suscitato dal sionismo che l’interesse per l’ebraico come lingua viva, e quindi anche matrice di letteratura, ha potuto affermarsi…
Certo è stato una sorta di Rinascimento, se vogliamo. Improvvisamente si pensò in modo nuovo a tutto, e ciò comportò un’entrata vigorosa dell’ambito laico all’interno del mondo ebraico. Fu qualcosa che produsse miracoli. Non perché il laico di per sé sia qualcosa di straordinario. Bisogna poi tenere presente che non vi è quasi alcun autore o pensatore israeliano che non abbia qualche relazione con la Tradizione. Ad ogni modo l’elemento laico è entrato, portando con sé un pensiero fresco. La scrittura artistica è per sua stessa essenza laica poiché il suo interesse è guardare più all’umano che al divino. In fin dei conti il suo scopo fondamentale è estetico, come lo è quello dell’arte sacra del Rinascimento italiano. Da un punto di vista storico questo processo iniziò prima del sionismo ed è, in un certo senso, autonomo. Fu il sionismo, in quanto movimento politico, a inserirsi poi in questo processo e a perpetuarlo. Ma non vi è identità tra i due termini. L’arte e letteratura ebraica da tempo non sono più impegnate in «questioni sioniste» – anche per quanto concerne autori impegnati politicamente.
Lei ha scritto che attraverso la nuova letteratura ebraica è stata costruita anche una personalità ebraica, nuova. Prima l’ebraismo diasporico si risolveva nella dimensione religiosa – anche se sarebbe da discutere cosa si intenda con ‘religione’. In quel contesto i singoli ebrei avevano, ovviamente, una loro personalità, ma questa non si esprimeva, non si costruiva, all’interno della lingua ebraica. Invece, attraverso la nuova letteratura, anche la personalità, l’interiorità, diviene ebraica.
Sì, è così. È un processo davvero interessante. Dal 1890 in Europa orientale vi è una civiltà ebraica forte, ed è sionista. Vi sono case editrici, periodici, lettori. Vi è una soggettività che è già “ivrit”, ebraica, e che si diffonde anche negli Stati Uniti. E ciò diverso tempo prima della dichiarazione Balfour – prima, dunque, che il centro di questo processo passasse in terra di Israele. Vi era una base che non era affatto legata ai congressi sionisti – i quali avevano luogo in tedesco o in altre lingue europee. Ma l’ebraico come letteratura – questa «repubblica letteraria» – venne in essere prima dell’istituzione dell’altra repubblica [lo Stato di Israele]. In molti sensi il suo fondatore fu Mendele Mokher Sfarim. Spesso sentiamo ricorrere una domanda: qual è il ruolo del singolo nella storia e quanto, invece, è la forza del contesto? Naturalmente senza un ambiente circostante un autore di questo tipo non sarebbe nato. Tuttavia, Mendele fu veramente all’origine di un fenomeno unico, sia per l’ebraico che per lo yiddish. Nelle sue opere scritte in ebraico c’è un’idiomaticità rivoluzionaria. Non sono una mera «autotraduzione » dallo yiddish. Proprio per questa sua originalità divenne in seguito il modello di scrittura letteraria per antonomasia. Tutti i nomi successivi, sino ad Agnon, continuarono questo «mendelismo ». Ma il suo contributo fu equivalente, quanto ad originalità, anche in yiddish, dove inaugurò un vero e proprio stile realista.
Tornando all’ambito dell’ebraico, sostenne la necessità che si trovasse un nuovo e diretto rapporto con la natura. Un’istanza in cui si manifesta il suo legame con il romanticismo.
Anche in un autore come Ben Yizhak, che abbiamo tradotto di recente, ricorre questa istanza, anche se declinata secondo un registro lirico…
Sì, ma in Ben Yizhak ciò avviene per il tramite di Bialik, il romantico per antonomasia, perché in lui tutto l’aspetto mistico passa attraverso la natura. Questo processo iniziò con Mendele, quando questi tradusse un libro di storia naturale dal tedesco e si trovò di fronte alla necessità di dare nomi alle differenti tipologie di pesci, uccelli e alberi – laddove l’ebraico di allora non disponeva di parole per la maggior parte degli animali e delle piante. Certo, vi era un lessico botanico e faunistico derivante dal Tanakh, ma non sufficiente. La letteratura rabbinica presentava alcuni rinnovamenti lessicali, sempre troppo pochi, però. Questo tipo di carenza indusse alcuni intellettuali, come Ahad Ha-am, a ritenere che non ci sarebbe mai stata una scienza in ebraico. Del resto Herzl riteneva che nelle università dello Stato degli ebrei si sarebbe studiato in tedesco. E lo stesso si potrebbe dire rispetto ad altri campi del sapere: non si era mai venuta a formare prima di allora una forma di consapevolezza, di descrizione e di critica «ebraica» attorno a molti argomenti. Ritorniamo all’Italia. Pensiamo, per esempio, a Vasari. Non vi era stato un fenomeno simile prima, la consapevolezza meta-artistica di qualcuno che scrive sui maestri del passato, l’evoluzione delle scuole e così via. È questo tipo di consapevolezza che permette l’inizio di qualcosa come una repubblica letteraria o artistica. Nell’ambito ebraico ciò venne fatto nell’ambito dell’interpretazione delle fonti, producendo un contributo importante, ma sempre in un solo campo. È tuttavia per il tramite di questo ambito, attraverso la rete intellettuale dei maestri, che si è custodita la lingua ebraica, mantenendo così mantenere una sorta di continuità con l’ebraico delle fonti. Così anche nell’ebraico contemporaneo – in particolare quello letterario, ma non solo – vi è una presenza costante della matrice biblica. L’ebraico non dimentica mai che il suo inizio è in Bereshit [il libro della Genesi].
La direzione in cui si è incamminata oggi la letteratura israeliana è quella di una sorta di normalizzazione? Come se, finito il momento glorioso, si comportasse come tutte le letterature del mondo?
Non è necessario che quello slancio perduri perché la letteratura non si riduca a mero mercato. Il momento sionista eroico è terminato da molto tempo. Per molti versi già Agnon non gli appartiene. L’ordine del giorno dei grandi scrittori è sempre aperto al futuro. E non sempre è adatto, non del tutto almeno, alla funzione d’intrattenimento della letteratura. Se nominiamo Eshkol Nevo, allora sì, abbiamo un esempio di qualcuno adatto al mercato e vi è in un intero milieu di scrittori di questo tipo. Nevo è un buon scrittore, ed è popolare, ma non apporta alcun pensiero innovativo rispetto a come la letteratura guarda alla vita. Se pensiamo a Grossman, allora ci rendiamo conto di come ogni suo libro affronta la questione di cos’è un racconto e di cos’è la cultura in modo originale. Rimane un autore popolare e nonostante ciò presenta sempre un aspetto di avanguardia, e ha la capacità di formulare profonde analisi sulla situazione politica e culturale israeliana e internazionale. Da questo punto di vista continua la posizione tipica dei grandi autori dell’epoca sionista, del resto una caratteristica universale che non appartiene solo al sionismo. Come è noto dopo la morte di suo figlio ha scritto un’opera che è estremamente personale e, allo stesso tempo, una sorta di portavoce per tutti i genitori che hanno perso un figlio, un racconto fuori del tempo. Così, al di là del valore letterario in sé, con il suo lavoro ha realizzato quello che in ebraico chiamiamo un pithon pe, la possibilità di articolare linguisticamente esperienze nei confronti delle quali le persone ordinarie non trovano parole. Ha trasformato il suo lutto in qualcosa che potesse esprimere il dolore di tutti. Quando la letteratura è forte all’interno di una società, ha un significato che va ben oltre quello del successo commerciale, diventa una voce che è ascoltata.
Anna Linda Callow, Cosimo Nicolini Coen
Pagine Ebraiche, gennaio 2019
