Il progetto UCEI nelle classi
“Solo la conoscenza vince il pregiudizio”
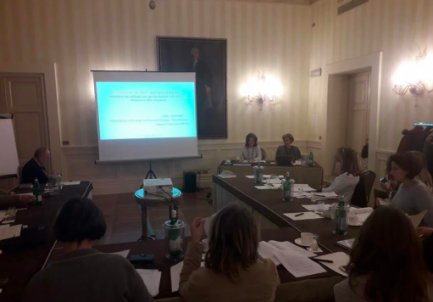 Entrerà presto nelle scuole, con una sperimentazione rivolta a studenti in fascia d’età 3-5 anni e a studenti di scuole medie superiori, il progetto “Prevenire il pregiudizio, educare alla convivenza” realizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con il contributo del Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale Tedesca. Ieri a Firenze l’ultimo incontro di un ciclo che ha portato un team di insegnanti a confrontarsi con la visione delle tre religioni monoteiste su concetti quali uguaglianza, diversità, parità, rispetto.
Entrerà presto nelle scuole, con una sperimentazione rivolta a studenti in fascia d’età 3-5 anni e a studenti di scuole medie superiori, il progetto “Prevenire il pregiudizio, educare alla convivenza” realizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con il contributo del Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale Tedesca. Ieri a Firenze l’ultimo incontro di un ciclo che ha portato un team di insegnanti a confrontarsi con la visione delle tre religioni monoteiste su concetti quali uguaglianza, diversità, parità, rispetto.
“Un’operazione dall’alto valore culturale, che si pone in modo innovativo rispetto a questi temi” sottolinea con soddisfazione Saul Meghnagi, coordinatore della Commissione Scuola, Educazione e Giovani UCEI, che ha allestito il progetto con il sostegno di Odelia Liberanome, anima di molti progetti educativi dell’Unione. I docenti, che già avevano avuto modo di approfondire il punto di vista ebraico grazie a un intervento del rabbino capo rav Gadi Piperno, nelle scorse ore hanno nuovamente approfondito la visione delle chiese cristiane e l’approccio islamico a tali in questioni in compagnia di Daniele Garrone e Adnane Mokrani. Il primo, pastore valdese e da oltre 30 anni professore ordinario della Facoltà Valdese di Teologia dove insegna Antico Testamento. Il secondo, teologo musulmano italo-tunisino, da tempo impegnato nel dialogo interreligioso a livello nazionale e internazionale. A concludere il pomeriggio è stata poi Cristina Zucchermaglio, professore ordinario dell’Università La Sapienza di Roma, con una relazione sulla formazione “ai valori” orientata su aspetti psico-pedagogici e fondamenti metodologici per la sperimentazione educativa e la formazione delle insegnanti
. Il punto di partenza per l’esportazione di quanto acquisito nelle classi, i luoghi per eccellenza dove si costruisce futuro ma anche dove, se non si interviene in modo tempestivo e adeguato, scontri e divergenze possono diventare, negli anni a seguire, ferite insanabili.
“Nelle società occidentali – riflette Meghnagi – l’unificazione politica, la diffusione dell’istruzione scolastica, l’omogeneizzazione linguistica, la mobilità territoriale, il riconoscimento delle differenze di genere, il cosmopolitismo industriale accompagnato da forme crescenti di interdipendenza economica ed estensione della comunicazione, hanno modificato vincoli comunitari tradizionali e ridotto le differenze culturali”.
“Lo sviluppo di tale sistema sociale – prosegue – è peraltro fonte, da parte degli individui e gruppi lasciati ai margini, di conflitti che possono assumere il carattere di un rifiuto totale. Un sistema di valori che viene vissuto e proposto come propulsore di democrazia, può risultare estraneo a tradizioni di convivenza e rispetto tra singoli, gruppi e collettività, nella misura in cui rompe processi di trasmissione culturale fondati su regole, poteri, relazioni, consuetudini consolidate e riconosciute”.
Il progetto si propone di intervenire in questo ambito favorendo comprensione dell’Altro e abbattimento di pregiudizi, spesso veicolati dalle stesse religioni. Al centro un percorso scandito da conoscenza e consapevolezza.
“L’attuale sostegno della maggior parte delle confessioni cristiane all’affermazione della dignità umana a prescindere da ogni presupposto etnico, sociale, sessuale e religioso, delle libertà e dei diritti umani – ha infatti spiegato Garrone – ha implicato il superamento di una storia tragica che ha compreso anche antigiudaismo, persecuzione degli eretici, crociate e guerre di religione, misoginia, regime di cristianità, omofobia, legittimazione del colonialismo”. La coscienza di questa storia, per Garrone, “scardina ogni atteggiamento trionfalistico o anche soltanto apologetico”. Essa invita inoltre “ad avere un atteggiamento critico anche nei confronti della religione, a cominciare dalla propria, che non è esente dall’ambivalenza di ogni fenomeno umano”.
“Chi è il musulmano?”: è una delle domande che si è posto Mokrani. “Una prima risposta veloce – ha spiegato – potrebbe essere: il musulmano è colui che si dichiara musulmano. Una risposta inclusiva che impedisce l’esclusione o la scomunica. Una seconda risposta un po’ più dettagliata: il musulmano è colui che crede nella profezia di Muhammad e nella rivelazione coranica. Ovviamente, la profezia e la rivelazione hanno un contenuto centrale, l’unicità di Dio, Tawhid, una dottrina che accumuna le religioni abramitiche. Dentro questo quadro generale, troviamo un mondo di interpretazioni e di comprensioni lungo la Storia fino ad oggi”. La religione è infatti un fiume “che porta realtà molto diverse, e talvolta tra di loro contraddittorie”. Nella sua esposizione una lettura che considera allo stesso tempo la complessità del mondo islamico e le esigenze delle società moderne, in particolare in Europa. Una lettura che, ha detto Mokrani, “interagisce positivamente con la modernità, cercando una etica comune con valori condivisi, nonostante riserve e esitazioni”.
“La convivenza tra culture diverse – ricordava rav Piperno – è una sfida che non può essere elusa ma che non va neanche sottovalutata. Esistono dei prerequisiti al dialogo che non possono essere sminuiti. Il primo tra questi è il riconoscimento dell’identità di chi ci sta di fronte, evitando di incorrere nell’errore di attribuirgli caratteristiche che non gli appartengono ma che possono essere frutto di nostri convincimenti, cosa che sarebbe quindi nei suoi confronti un atto di prevaricazione”. Dal punto di vista ebraico, aggiungeva poi, non c’è possibilità di dialogo “con una cultura che di principio non rispetti il valore della vita umana, la proprietà, il dolore degli animali, che accetti l’incesto o che non porti rispetto per il divino, e che non metta in atto un sistema che regoli le controversie tra le persone”. Accolti questi requisiti, “è un dovere collaborare con tutti coloro che formano la società in cui si vive, portando ciascuno il proprio contributo al benessere collettivo”.
Tre ulteriori saggi, parte del documento conclusivo e della formazione, sono stati affidati ad altrettanti esperti accademici: Giorgio Sacerdoti, giurista e presidente della Fondazione Cdec, che in “Uguaglianza, Diversità, Parità e Diritto” proporrà una analisi dal punto di vista giuridico costituzionale. Il sociologo Enzo Campelli che, in “Popolazione italiana: composizione e specificità”, svilupperà un punto di osservazione sociale e demografico. La sociologa Marida Cevoli, che scriverà sul tema “Gli studenti della scuola italiana: diversità e provenienza e di genere”.
Spunti di riflessione utili per lasciare il segno nelle scuole, dove si andrà ad intervenire dai primi mesi del prossimo anno.
(18 dicembre 2019)
