L’anticonformismo di Gershom Scholem
 Gershom Scholem (nella foto a fianco) è stato l’intellettuale ebraico che ha avuto più autorità, in tutto il Novecento, colui che è stato essenziale rendere un legittimo oggetto di studio accademico tutta la tradizione ebraica, anche quella meno ortodossa e meno omologata a una idea “benpensante” di religione nel senso occidentale e soprattutto protestante del termine. Oggi è difficile rendersi conto, quando leggiamo scritti sulla Kabbalah o sugli strati più profondi e segreti del pensiero ebraico, che questi temi erano non solo sottaciuti, ma attivamente censurati dalla grande tradizione ottocentesca della “scienza dell’ebraismo” e lasciati alle pratiche, anch’esse sopportate con qualche vergogna, dell’ebraismo chassidico “orientale” o di quello sefardita ancora meno noto. La competenza filologica, l’immensa cultura, la capacità di Scholem di trattare in maniera ostentatamente distaccata e “oggettiva” temi scottanti come le ondate (pseudo)messianiche di Shabbatai Zvi o le pratiche teurgiche di certe correnti della Kabbalah (per esempio Abulafia), le ha trasformate in oggetti storici interessanti e legittimi anche al di là del mondo ebraico. Nessuno potrebbe pensare, dopo la sua opera, alla cultura ebraica nei termini consueti fino a un secolo fa, come un confuso e “arcaico” ammasso di riti e regole privo di rilevanza teologica e in definitiva di senso. Dopo la morte di Scholem il suo lavoro è stato naturalmente oggetto di revisione, le sue interpretazioni sono discusse e magari contraddette su singoli punti; sono sorti altri grandi studiosi come Moshé Idel; ma nessuno nega la legittimità della sua mossa fondamentale di prendere la mistica ebraica come uno dei grandi temi del pensiero di Israele, alla pari del pensiero filosofico influenzato dalla tradizione greco-araba o di quello alakhico/talmudico.
Gershom Scholem (nella foto a fianco) è stato l’intellettuale ebraico che ha avuto più autorità, in tutto il Novecento, colui che è stato essenziale rendere un legittimo oggetto di studio accademico tutta la tradizione ebraica, anche quella meno ortodossa e meno omologata a una idea “benpensante” di religione nel senso occidentale e soprattutto protestante del termine. Oggi è difficile rendersi conto, quando leggiamo scritti sulla Kabbalah o sugli strati più profondi e segreti del pensiero ebraico, che questi temi erano non solo sottaciuti, ma attivamente censurati dalla grande tradizione ottocentesca della “scienza dell’ebraismo” e lasciati alle pratiche, anch’esse sopportate con qualche vergogna, dell’ebraismo chassidico “orientale” o di quello sefardita ancora meno noto. La competenza filologica, l’immensa cultura, la capacità di Scholem di trattare in maniera ostentatamente distaccata e “oggettiva” temi scottanti come le ondate (pseudo)messianiche di Shabbatai Zvi o le pratiche teurgiche di certe correnti della Kabbalah (per esempio Abulafia), le ha trasformate in oggetti storici interessanti e legittimi anche al di là del mondo ebraico. Nessuno potrebbe pensare, dopo la sua opera, alla cultura ebraica nei termini consueti fino a un secolo fa, come un confuso e “arcaico” ammasso di riti e regole privo di rilevanza teologica e in definitiva di senso. Dopo la morte di Scholem il suo lavoro è stato naturalmente oggetto di revisione, le sue interpretazioni sono discusse e magari contraddette su singoli punti; sono sorti altri grandi studiosi come Moshé Idel; ma nessuno nega la legittimità della sua mossa fondamentale di prendere la mistica ebraica come uno dei grandi temi del pensiero di Israele, alla pari del pensiero filosofico influenzato dalla tradizione greco-araba o di quello alakhico/talmudico.
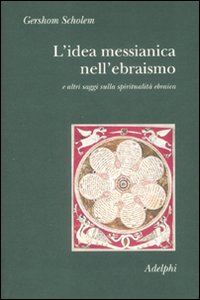 All’ombra del monumento di questa straordinaria impresa intellettuale, noi oggi rischiamo però di darla per scontata, dimenticando il suo carattere costruttivo, ma anche polemico e perfino scandaloso. Per aiutarci a non perdere questa dimensione antagonistica e innovatrice, che è stata fondamentale nell’opera di Scholem come lui stesso ha talvolta riconosciuto, ci aiuta l’ultimo bellissimo volume di scritti raccolti da Adelphi sotto il titolo L’idea messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica (a cura di Roberto Donatoni e Elisabetta Zevi, pp. 388, 34 euro).
All’ombra del monumento di questa straordinaria impresa intellettuale, noi oggi rischiamo però di darla per scontata, dimenticando il suo carattere costruttivo, ma anche polemico e perfino scandaloso. Per aiutarci a non perdere questa dimensione antagonistica e innovatrice, che è stata fondamentale nell’opera di Scholem come lui stesso ha talvolta riconosciuto, ci aiuta l’ultimo bellissimo volume di scritti raccolti da Adelphi sotto il titolo L’idea messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica (a cura di Roberto Donatoni e Elisabetta Zevi, pp. 388, 34 euro).
Che la costruzione di una storia del pensiero ebraico – nel senso ampio che oggi diamo per scontato – fosse un gesto polemico mirante all’autodefinizione dell’ebraismo in una stretta storica centrale per la sua esistenza e non solo un interesse filologico antiquario, lo vediamo per esempio dai saggi sugli autori della scienza dell’ebraismo e sull’opera di Martin Buber, in cui Scholem, pur riconoscendo i meriti di questi autori, chiarisce perfettamente la differenza del suo approccio. Zunz, Steinschneider e gli altri autori della Wissenschaft des Judentums appaiono a Scholem meritori per il loro lavoro di precisazione della storia ebraica, per la difesa che ne fanno nel momento dell’insediamento ebraico nella società occidentale, ma del tutto inconsapevoli e sostanzialmente chiusi alla reale complessità del pensiero ebraico tradizionale e disinteressati o perfino ostili alla sorte di Israele come popolo: in definitiva intenti programmaticamente a “dare una degna sepoltura” alla grande ricchezza culturale della tradizione ebraica, come Scholem riferisce con trattenuta indignazione.
Buber ha per Scholem il merito di aver presentato all’Occidente il chassidismo, ma il torto di averne visto solo il lato aneddotico o “esistenziale”, ignorando la continuità di pensiero con la Kabbalah e i rapporti (antagonistici ma stretti) con lo pseudo-messianesimo di Zvi e Frank. Il saggio sulla devequt (o “comunione con Dio”) nella prima generazione chassidica è un bellissimo esempio del diverso approccio che Scholem ha nei confronti del Baal Shem Tov e dei suoi continuatori: non pittoreschi maestri di saggezza e di pietà ebraica, da guardare come una sorta di enigmatici maestri zen, ma pensatori sottili, innovatori di quel grande edificio che è la riflessione ebraica sui rapporti con il divino.
L’interesse di Scholem va a tutto ciò che esprime questo interesse teologico o metafisico, soprattutto dove questo interesse diventa scommessa estrema, anticonvenzionale, rottura dell’ebraismo perbenistico dell’assimilazione. Al centro di questo “estremismo teologico” che affascina Scholem, fin dai tempi della Kabbalah luriana è la funzione di redenzione pubblica attribuita al messia: un’idea del tutto opposta al regno “interiore” del messia cristiano. Di questa funzione pubblica del messianesimo ebraico Scholem ricostruisce le oscillazioni più recenti in una serie di saggi magistrali, dall’esaltazione cabbalistica alla “neutralizzazione” chassidica. Questo interesse per le manifestazioni messianiche si estende ben al di là della teologia delle “scintille” da recuperare e delle “bucce” da neutralizzare. Ritroviamo in questi saggi la figura di Shabbatai Zvi, cui Scholem ha dedicato un grande libro ben noto anche in Italia, e soprattutto leggiamo una serie di studi sugli esiti antinomici della sua esperienza estrema: da un lato il frankismo e la sua teoria di una “redenzione attraverso il peccato” (che secondo Scolem influenza, magari a contrario, tutti i maggiori momenti successivi di pensiero ebraico, dal chassidismo alla askalà fino al sionismo) e dall’altro per le manifestazioni di marranesimo volontario come quella della setta doenme, che prolungando l’ambigua conversione di Shabbatai Zvi all’Islam continuò a esistere semiclandestinamente almeno fino al 1950 in tutto l’ambiente turco, a partire dal suo insediamento originario di Salonicco. Scholem non esprime giudizi su questi percorsi, ma li ricostruisce con evidente passione; mentre dimostra un evidente fastidio per i tentativi “borghesi” di rifondare l’ortodossia ebraica facendo a meno della metafisica cabbalistica e non solo dell’anitinomismo messianico. Si capisce bene come ancor più di un fenomeno accademico come la “scienza dell’ebraismo”, la sua bestia nera sia Samson Rafael Hirsch, il fondatore della moderna ortodossia da cui dipende larga parte dell’ebraismo contemporaneo come si pratica in Europa occidentale. Scholem gli dedica alcuni giudizi sprezzanti, come è raro leggerne per una personalità così rilevante.
Il volume è completato da qualche saggio curioso, da cui emerge ancora l’anticonformismo di Scholem, come quello dedicati con ammirazione molto critica alla traduzione della Bibbia di Rosenzweig e Buber, l’altro in cui si discute con altrettanto reverente distacco del capolavoro filosofico di Rosenzweig, La stella della redenzione e soprattutto quello in cui si ricostruiscono le vicende del simbolo che noi oggi chiamiamo maghen David e trattiamo come se fosse da sempre il grafema ebraico per eccellenza. Scholem ha buon gioco nello smentire questa ingenua adesione, mostrando che l’affermazione della stella a sei punte come simbolo dell’ebraismo non è più antica dell’Ottocento e che la sua origine è magica, non religiosa.
Ugo Volli
