Piccoli mostri crescono 1
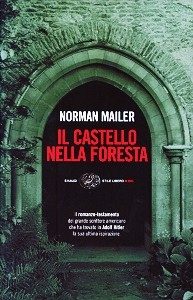 Nella sua duplice biografia dei due macellai più sanguinari e peggiori mostri morali del XX secolo, Stalin e Hitler (ma Mao non è al loro stesso livello? E Pol Pot non merita la stessa attenzione?), Alan Bullock ripubblica affiancate fotografie scolastiche del giovane Iosif e del giovane Adolf, scattate rispettivamente nel 1889 e nel 1899, vale a dire quando avevano entrambi circa dieci anni. Osservando le due facce, si cerca di scorgere qualche essenza, qualche oscuro alone, qualche segreto annuncio degli orrori futuri; ma le fotografie sono vecchie, la loro definizione è mediocre, non si può essere sicuri, senza contare che la macchina fotografica non è un congegno per prevedere l’avvenire.
Nella sua duplice biografia dei due macellai più sanguinari e peggiori mostri morali del XX secolo, Stalin e Hitler (ma Mao non è al loro stesso livello? E Pol Pot non merita la stessa attenzione?), Alan Bullock ripubblica affiancate fotografie scolastiche del giovane Iosif e del giovane Adolf, scattate rispettivamente nel 1889 e nel 1899, vale a dire quando avevano entrambi circa dieci anni. Osservando le due facce, si cerca di scorgere qualche essenza, qualche oscuro alone, qualche segreto annuncio degli orrori futuri; ma le fotografie sono vecchie, la loro definizione è mediocre, non si può essere sicuri, senza contare che la macchina fotografica non è un congegno per prevedere l’avvenire.
Il test delle fotografie scolastiche – quali saranno i destini di questi bambini, chi di loro andrà più lontano? – ha una particolare efficacia nei casi di Stalin e di Hitler. E possibile che alcuni di noi siano malvagi dal momento in cui lasciano l’utero delle proprie madri? Se no, quando entra in noi il male, e in quale modo? O, per porre la domanda in termini meno metafisici, come avviene che alcuni di noi non elaborino mai una reprimente coscienza morale? Per quanto riguarda Stalin e Hitler, la colpa è del modo in cui furono educati con i metodi pedagogici vigenti in Georgia e in Austria alla fine dell’Ottocento? Oppure i ragazzi elaborarono in realtà una coscienza, e poi, in un momento successivo, la persero? Quando furono fotografati, Iosif e Adolf erano ancora ragazzi normali, gentili, e si tramutarono poi in mostri come conseguenza dei libri che lessero o delle compagnie che frequentavano, delle pressioni del loro tempo? O forse, dopo tutto, in loro non c’era nulla di speciale, né all’inizio né in seguito, ma il copione della storia richiedeva due macellai, uno tedesco e uno russo? Se Iosif Dzugasvili ed Adolf Hitler non si fossero trovati nel posto giusto al momento giusto, la storia avrebbe trovato un altro paio cli attori, altrettanto bravi (cioè, altrettanto cattivi) a sostenere quei ruoli?
Non sono domande che ai biografia piacere porsi. Ci sono limiti a quello che potremo mai sapere come dati di fatto sul giovane Stalin e sul giovane Hitler, sul loro ambiente familiare, sulla loro educazione, sulle loro prime amicizie, sulle prime influenze esercitate sudi loro. Il salto dalla magra documentazione effettiva alla vita interiore è enorme, tale che gli storici e i biografi (considerando il biografo uno storico dell’individuo) sono comprensibilmente riluttanti a compierlo. Se quindi vogliamo sapere che cosa succedeva in quelle due anime infantili, dovremo rivolgerci al poeta, a quel tipo cli verità che il poeta offre e che non è la stessa verità dello storico.
E a questo punto che entra in ballo Norman Mailer. Lo scrittore non ha mai considerato la verità poetica una verità di genere inferiore. Da Un sogno americano e Pubblicità per me stesso, attraverso Le armate della notte e Perché siamo nel Vietnam?, fino a Il canto del boia e Marilyn, si è sentito libero di seguire lo spirito e i metodi dell’indagine romanzesca per conquistarsi l’accesso alla verità dei nostri tempi, in un’operazione che può essere più rischiosa di quella dello storico, ma offre ricompense più ricche. Il soggetto del suo nuovo libro è Hitler. Hitler può appartenere al passato, ma il passato cui egli appartiene è ancora vivo, o almeno non è ancora morto, Ne Il castello nella foresta, Mailer ha scritto la storia del giovane Hitler, e precisamente la storia cli come il giovane Hitler finì posseduto dalle forze del male.
L’albero genealogico di Adolf Hitler è complicato e, secondo i criteri di Norimberga, non del tutto a posto. Suo padre, Alois, era figlio illegittimo di una certa Maria Anna Schicklgruber. Il candidato padre più attendibile, Johann Nepomuk Hùttler, a causa di una relazione adulterina era anche il nonno di IClara Poelzl, nipote di Alois e sua terza moglie, nonché madre di Adolf. .Alois Schicklgruber si legittimò come Alois Hitler (scelse lui questa grafia) a quarant’anni, poco prima di sposare la ben più giovane Klara. Ma secondo voci che non si spensero mai del tutto, il vero padre di Alois – e quindi il nonno di Adolf – sarebbe stato un ebreo di nome Frankenberger. Ci fu persino chi insinuò che Klara fosse la figlia naturale di .Alois. Una volta entrato nella vita politica, negli anni Venti, Adolf Hitler fece tutto il possibile per nascondere, e anche per falsificare, la sua genealogia. Non si sa se perché credesse di avere un antenato ebreo. All’inizio degli anni Trenta, i giornali d’opposizione cercarono di screditare l’antisemita Hitler mettendo in rilievo la presenza cli un ebreo nel suo armadio di famiglia, ma i loro sforzi cessarono bruscamente quando i nazisti presero il potere.
Grazie al suo impegno, Alois Hitler passò dalla condizione di contadino ai ranghi intermedi del servizio doganale austriaco. Con Klara mise al mondo tre figli; e ne introdusse nella famiglia anche altri due nati da un matrimonio precedente. Uno di loro, Alois junior, scappò di casa per darsi al vagabondaggio e, in parte, alla malavita (oltre che alla bigamia). Il figlio di Alois junior, William Patrick Hitler (nato da una madre irlandese), cercò senza risultato di ricattare il Fuhrer sui segreti di famiglia prima di emigrare nel 1939 negli Stati Uniti, dove, dopo un breve periodo di conferenze come esperto sullo zio, si arruolò in Marina.
In Mein Kampf, il libro che scrisse mentre era in carcere, Hitler fornisce una versione delle proprie origini fortemente epurata. Non si dice nulla dell’incesto, nulla dell’illegittimità, assolutamente nulla degli antenati ebrei, e nulla neanche dei fratelli. Ci viene invece presentata la storia di un ragazzino sveglio, che resiste a un padre dispotico (anche se amato), il quale vorrebbe fargli seguire le sue orme nell’amministrazione statale. Deciso a diventare un artista, il ragazzo si fa deliberatamente bocciare agli esami scolastici, frustrando così i progetti paterni. A questo punto il genitore provvidenzialmente muore, e il ragazzo, con l’appoggio della madre, ancor più amata, è libero di seguire il proprio destino.
La storia che andasse male a scuola deliberatamente è una palese spiegazione a posteriori. Adolf era un ragazzo sveglio, ma non, come gli piaceva pensare, un genio. Convinto che il successo gli fosse dovuto semplicemente per ciò che lui era, disdegnava lo studio. Una volta passato dalla scuola elementare alla Realschule, la scuola tecnica superiore, rimase sempre più indietro rispetto ai suoi compagni e alla fine gli fu chiesto cli andarsene.
Il mondo sarebbe stato più felice se Alois senior l’avesse avuta vinta e se Adolf fosse diventato uno scribacchino in qualche angolo oscuro della burocrazia austriaca. E certo che Alois castigò il figlio, come facevano allora quasi tutti i padri, e molto peso è stato dato a quelle percosse da parte dei biografi. Nel caso di Stalin, le botte per mano del padre, un ciabattino analfabeta, furono all’origine di una furiosa brama di vendetta di cui i russi avrebbero poi pagato il fio. Nel caso di Hitler, se accettiamo l’analisi di Erik Erikson, le percosse e le altre manifestazioni dell’autorità paterna generarono nel ragazzo la ferma decisione di non diventare a sua volta un pater familias, ma di assumere invece nell’immaginazione del popolo tedesco l’identità del figlio implacabilmente ribelle, oggetto dell’ammirazione di milioni di figli e di figlie, nei cui petti bruciava ancora il ricordo delle umiliazioni passate. In entrambi i casi la lezione sembra essere che la punizione corporale è una cattiva idea – che una cultura in cui il giovane orgoglio maschile viene energicamente umiliato rischia di provocare il ritorno del represso, ingrandito mille volte.
Il romanzo cli Mailer comprende tutto lo scontro fra Alois senior e Adolf, che però, tanto per cambiare, è presentato sia dal punto di vista del figlio sia da quello del padre. Il tanto diffamato tiranno domestico Alois figura simpaticamente come un accorto funzionario doganale, un marito fiero della propria virilità nonostante l’avanzare degli anni, un appassionato anche se sfortunato apicoltore dilettante, un uomo di scarsa formazione scolastica che s’arrampica ansiosamente sulla scala sociale. Le scene in cui Alois si sforza di non rendersi ridicolo nelle riunioni con altri notabifi provinciali valgono il Flaubert di Bouvard e Pécuchet.
L’Adolf di Mailer è invece un figlio antipatico, piagnucoloso e manipolatore, tormentato da desideri incestuosi e da gelosie edipiche e assolutamente implacabile. Emana un cattivo odore di cui non riesce a sbarazzarsi e ha anche l’abitudine di svuotarsi gli intestini quando è spaventato. La sua azione più sconvolgente è di contagiare deliberatamente col morbillo l’affascinante e amatissimo fratello minore Edmund: «“Perché mi baci?” — aveva domandato Edmund? — ‘Perché ti voglio bene” … e aveva baciato ripetutamente Edmund, con quei baci sbrodolati che danno i bambini, e Edmund li aveva ricambiati. Era così contento che Adi gli volesse bene». Edmund muore, secondo il piano. Adolf rimane trionfalmente padrone del nido.
Quando il giovane Adolf disse che voleva diventare un artista, non fu per un divorante amore dell’arte, ma perché voleva essere riconosciuto come genio: diventare un grande artista gli sembrava il modo più rapido, per un giovane oscuro con poco denaro e nessuna relazione, di ottenere quel riconoscimento.
Al tempo in cui entrò in politica, negli anni Venti, aveva già abbandonato le pretese artistiche e si era trovato un modello di ruolo più congeniale. Federico lidi Prussia, Federico il Grande, era diventato il suo idolo; negli ultimi mesi della guerra, assediato nel suo bunker berlinese, per svagarsi ascoltava racconti tratti dalla biografia di Federico di Thomas Carlyle, antidemocratico, germanofilo e massimo propagandista della teoria del grande uomo nella storia.
Hitler era ossessionato dal proprio posto nella storia, cioè da come le sue azioni presenti sarebbero state viste nel futuro.
«Per me ci sono due possibilità», disse ad Alberi Speer, «riuscire completamente nei miei piani o fallire. Se riuscirò, sarò uno dei grandi uomini della storia – se fallirò, sarò condannato, rifiutato e vituperato».
Nei romanzi di Fédor Dostoevskij ci sono due uomini alla deriva ai margini della società russa,
il Raskolnikov di Delitto e castigo e lo Stavrogin dei Demoni, che pensano di poter giungere con una scorciatoia alla posizione di grande uomo separando la bontà dalla grandezza e commettendo quelli che immaginano essere grandi crimini: uccidere vecchiette a colpi d’accetta, a esempio, o violentare bambine.
La convergenza fra il concetto del genio, l’essere umano con un potere quasi divino, molto in anticipo sul gregge, e quello del grande uomo, l’uomo che esemplifica e insieme porta al livello più alto le qualità del suo tempo, che scrive la storia anziché esserne scritto, ulteriormente contaminato con il concetto del grande criminale, il ribelle i cui atti luciferini contestano le regole della società, ebbero sul carattere di Hitler un potente effetto formativo. Si accenna in Mein Kampf che la teoria del grande uomo gli fu esposta per la prima volta a scuola da un insegnante di storia. A soli quindici anni si convinse di essere un genio. Per quanto riguardava i grandi crimini (titolo al quale, come riconosce Stavrogin, possono ambire anche crimini apparentemente piccoli purché siano abbastanza squallidi, ignobili, malvagi e volgari), la vita in casa Hitler, almeno secondo la versione di Mailer, forniva al giovane Adolf sufficienti occasioni per praticarli. Hitler non aveva né la consapevolezza storica né la distanza da se stesso per riconoscere sino a qual punto fosse in balia della teoria del grande uomo; ed è improbabile che, se l’avesse capito, avrebbe voluto liberarsene.
Il marxismo contesta, notoriamente, il potere di agenti individuali di imporre la propria volontà alla storia. Trovando inaccettabile questa particolare tesi marxista, Stalin, che aspirava alla fama tanto quanto Hitler, reintegrò la teoria del grande uomo nella dottrina marxista in quella forma che sarebbe stata poi definita culto della personalità. La strada che egli imboccò verso il culmine della grandezza fu più diretta di quella di Hitler. Il verdetto della storia, agli occhi di Stalin, dipendeva soprattutto da chi scriveva i libri di storia. Si servì quindi del suo Breve corso della storia del Partito Comunista Bolscevico, edizione del 1948, lettura obbligatoria nelle scuole, per pronunciare su se stesso il verdetto della storia. Come comandante in capo delle forze armate sovietiche, egli scrisse che il suo genio gli aveva permesso di prevedere i piani del nemico e di vanificarli in ogni occasione. Per quanto riguardava le arti della pace, sebbene esercitasse il ruolo di leader del partito con consumata abilità e godesse del sostegno senza riserve di tutto il popoio sovietico, non avrebbe mai permesso che il suo lavoro venisse sciupato dal minimo accenno di vanità, dalla boria o dall’autoadulazione.
Senza più un padre che lo infastidisse, e con una docile madre che provvedeva ai suoi bisogni, Adolf Hitler si concesse un intervallo di due anni dopo la scuola secondaria, e rimase a casa, leggendo tutta la notte (uno dei suoi scrittori preferiti era Karl May, autore tedesco di racconti western), alzandosi tardi, disegnando, strimpellando saltuariamente il piano. E qui che Il castello nella foresta s’avvia alla fine.
Secondo i suoi editori, Mailer aveva in progetto una trilogia che avrebbe compreso l’intera vita terrena di Hitler. Il secondo volume avrebbe dovuto portarci sino agli anni Trenta e sarebbe stato imperniato sulla relazione tra Hitler e sua nipote Angelica (Geli) Raubal. 11 rapporto con Geli, in realtà, è già stato ricostruito da Ron Hansen in Hitler’s Niece (1999), un romanzo che barcolla pesantemente sotto il carico di una ricerca storica non assimilata, ma contiene un episodio — sulle (immaginarie) tendenze sessuali di Hitler — degno di Mailer al massimo della sua scabrosità. Il secondo volume di Mailer, presumibilmente, si sarebbe dovuto occupare anche degli anni che Hitler trascorse nella Vienna d’anteguerra, nonché del periodo passato nell’esercito tedesco, quando avvenne il suo risveglio politico. Ne Il castello nella foresta è tuttavia già implicito che il seme pernicioso del male che egli avrebbe inferto al mondo era già ben sviluppato nel 1905, quando Hitler aveva sedici anni. Se stiamo cercando la verità su Adolf Hitler, la verità poetica, sembra dire Mailer, gli anni dal suo concepimento e dalla sua nascita al termine del suo periodo scolastico forniranno materiale a sufficienza.
E certo una verità lapalissiana che il carattere si formi nei nostri primi anni, che il bambino sia il padre dell’uomo. Ma in Austria c’erano migliaia di ragazzini che amavano le loro madri, si opponevano ai propri padri e andavano male a scuola, tuttavia non divennero dei massacratori. Ameno di essere disposti a compiere un salto come quello di Mailer, dalla fedeltà ai dati reali alla percezione intuitiva, nessuna rielaborazione per quanto estesa della scarna documentazione storica sull’infanzia di Hitler potrà rivelarci cosa ci fosse in lui di speciale che lo distinguesse dai suoi coetanei.
Con il trasferimento di Hitler dalla provincia alla capitale nel 1906, l’immagine cambia. La documentazione diventa più ricca. Possiamo seguire i suoi movimenti, scoprire le persone che conobbe, leggere i libri e i giornali che lesse, ascoltare la musica che gli piaceva. Diventa quindi possibile un tipo diverso di romanzo biografico.
Nel 1907 Hitler si presentò agli esami d’ammissione all’Accademia di Belle Arti viennese. Con sua sorpresa e con suo fastidio, fece fiasco. «Saggio di disegno insoddisfacente», fu il verdetto degli esaminatori; che gli consigliarono invece di provare con l’architettura. Ma, poiché gli mancava il retroterra tecnico per studiare architettura, non poté seguire il loro consiglio. Passò quindi l’anno dopo bighellonando per Vienna, vivendo in pensioni, scrivendo lettere a casa per mantenere in vita la fantasia che egli fosse uno studente dell’Accademia, leggendo copiosamente, andando all’opera ogni volta che poteva permetterselo, Wagner era il suo compositore preferito; sostenne cli aver assistito ad almeno trenta rappresentazioni di Tristano e Isotta. Sessualmente rimase casto, o almeno autosufficiente; gli faceva orrore l’idea di essere infettato dalla sifilide.
Richiamato a Linz al capezzale della madre malata di cancro, l’assistette durante la sua agonia. Morta lei, Hitler tornò a Vienna e falli per la seconda volta l’esame d’ammissione all’Accademia di Belle Arti. Era un inverno gelido quando le sue risorse si esaurirono costringendolo a ricorrere a un rifugio per i senzatetto. Poi, con l’aiuto di un conoscente, cominciò a vendere qualche quadro e le sue prospettive divennero più rosee. Andò a vivere in un circolo per lavoratori, perseguendo una vita di artista semiprofessionista che si rivolgeva al mercato dei turisti. Nel 1913 lasciò Vienna per trasferirsi a Monaco, dove si stabilì in un quartiere bohémien. Può darsi, ma non è detto, che il trasferimento fosse dovuto al fatto di essere stato richiamato alle armi dalle autorità militari austriache.
Gli anni di Vienna richiederebbero un certo tipo di romanzo, un romanzo che facesse per la Vienna di Hitler ciò che fecero I quaderni di Malte Laurids Brigge per la Parigi di Rilke o Fame per la Oslo cli Knut Hamsun: fondendo insieme le esperienze interiori e quelle esteriori, ci restituirebbero non solo il mondo in cui il soggetto agiva, ma le percezioni e le reazioni di quest’ultimo in rapporto a esso. Col sostegno d’indagini approfondite come quelle condotte in Hitler. Gli anni dell’apprendistato (1996) dalla studiosa Brigitte Hamann, il romanziere che volesse rispondere a questa sfida potrebbe non solo risalire alle origini da cui si dipanano i singoli fili dell’ideologia nazionalsocialista, ma anche permetterci di capire come e perché essi finirono con l’intrecciarsi nella mente di Hitler…
