Stefania Dazzetti, la storia dell’ebraismo italiano attraverso la sua organizzazione giuridica
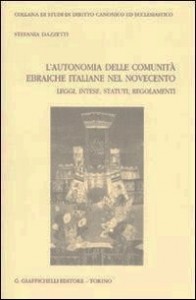 Un viaggio lungo la storia dell’ebraismo italiano nell’ultimo secolo quello compiuto da Stefania Dazzetti, dottore di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico. Un affascinante percorso che si snoda dagli inizi del 900 e giunge ai nostri giorni studiando l’ebraismo italiano attraverso le sue istituzioni. Quello che ne è uscito è un corposo volume che attraverso la mediazione delle fonti storiche e giuridiche fornisce un esauriente immagine della poliedrica realtà giuridica delle organizzazioni comunitarie ebraiche indagando soprattutto il complesso rapporto fra organismo centrale (l’Unione) e comunità. Un libro per addetti ai lavori in ambito storico e giuridico, ma dedicato anche agli appassionati dei temi della libertà e del pluralismo religioso in Italia.
Un viaggio lungo la storia dell’ebraismo italiano nell’ultimo secolo quello compiuto da Stefania Dazzetti, dottore di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico. Un affascinante percorso che si snoda dagli inizi del 900 e giunge ai nostri giorni studiando l’ebraismo italiano attraverso le sue istituzioni. Quello che ne è uscito è un corposo volume che attraverso la mediazione delle fonti storiche e giuridiche fornisce un esauriente immagine della poliedrica realtà giuridica delle organizzazioni comunitarie ebraiche indagando soprattutto il complesso rapporto fra organismo centrale (l’Unione) e comunità. Un libro per addetti ai lavori in ambito storico e giuridico, ma dedicato anche agli appassionati dei temi della libertà e del pluralismo religioso in Italia.
Abbiamo avuto occasione di parlarne con l’autrice qualche ora prima della sua presentazione al Centro Bibliografico dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
Stefania da che cosa è scaturita l’idea di lavorare su un libro che si occupi della legislazione delle comunità?
Alla ricerca mi ha condotto, anzitutto, la constatazione dell’assenza, nel panorama
degli studi giuridici, di una trattazione sistematica in tema di autonomia delle comunità ebraiche italiane. Da sempre, e anche dopo la comparsa degli enti unitari di rappresentanza – il Consorzio e poi l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane -, le
comunità hanno rivestito, e ancora oggi conservano, un ruolo di assoluto rilievo nell’assetto organizzativo dell’ebraismo in Italia. Le comunità continuano a costituire le principali istituzioni della vita associativa degli ebrei italiani. E non v’è dubbio che l’autonomia ne costituisca la caratteristica, la prerogativa più significativa, intendendo per essa la capacità di tali enti di darsi un’organizzazione interna, distinta da quelle
dello Stato e degli altri corpi sociali, interni ed esterni all’ebraismo.
Quanto tempo ha impiegato nella ricerca documentaria?
La ricerca mi ha impegnato per diversi anni. Mi proponevo di ricostruire gli assetti giuridici che, nel corso del Novecento, hanno regolato la vita delle comunità e l’apporto che ciascuna di esse ha fornito al processo di formazione delle norme regolatrici dell’autonomia. Ho intrapreso così una serie di indagini il più possibile accurate presso gli archivi storici e correnti delle principali comunità, oltre che naturalmente dell’UCEI. Inutile dire che si è trattato di un’esperienza particolarmente laboriosa ma anche molto appassionante sul piano personale, oltre che scientifico: una sorta di viaggio nell’ebraismo italiano che mi ha consentito di attingere, in presa diretta, grazie anche a una serie di incontri con personalità eminenti della vita ebraica – penso ad esempio agli avvocati Guido Fubini, Vittorio Ottolenghi e Dario Tedeschi -, oltre che attraverso la mediazione delle fonti storiche e giuridiche, ai diversi volti e aspetti di una tradizione che trova la sua cifra più significativa proprio nell’estrema varietà e ricchezza delle sue tante componenti dislocate sul territorio nazionale. In questo senso, credo si possa a ragione parlare non di un solo, ma di diversi ‘ebraismi’, ciascuno dei quali, con le sue peculiarità e storie, concorre a comporre un multiforme mosaico nazionale. E naturalmente, in questo mio personale percorso, ho contratto numerosi debiti di riconoscenza con istituzioni e personalità, che hanno molto agevolato il mio lavoro, accordandomi sia libero accesso a fonti di straordinario interesse, sia consigli e orientamenti preziosi.
A quale pubblico è indirizzato? E perché ritiene che sarebbe utile leggere questo libro?
Il lavoro ha naturalmente un taglio scientifico e si rivolge quindi in primo luogo agli addetti ai lavori nei campo storico e giuridico, in particolare a quanti hanno a cuore i temi della libertà e del pluralismo religioso nel nostro Paese. E, tuttavia, credo possa interessare in genere chi intenda approfondire le vicende storiche dell’ebraismo italiano nel Novecento da una prospettiva interna alla minoranza, che di solito si tende a trascurare, ma anche nell’ottica del contributo da essa offerto al consolidamento dei diritti fondamentali in Italia.
Uno spunto interessante di riflessione che ritiene scaturisca dal suo libro
Credo si possa riconoscere nella tensione dialettica tra la libertà religiosa del gruppo e quella dei singoli, che impegna ogni confessione religiosa e che, nel caso ebraico, prima ha dato luogo a un ampio, intenso dibattito democratico, quindi è sfociata, a livello normativo, nello statuto dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane del 1987. E non v’è dubbio che, adeguando l’organizzazione interna delle comunità ai principi costituzionali (art. 8), lo statuto si sia a suo tempo proposto e continui oggi a rappresentare in seno all’ebraismo italiano lo strumento più efficace e congruo di contemperamento delle ragioni individuali e collettive.
Lucilla Efrati
Stefania Dazzetti
L’autonomia delle Comunità Ebraiche Italiane nel Novecento, pagg. 299
Giappichelli Editore, Torino 37 euro
