Musica contro lo sterminio. L’esperienza di KZ Musik
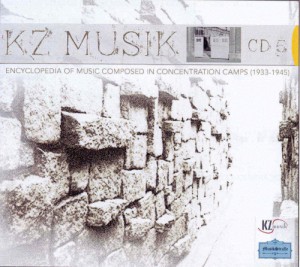 KZ Musik (Musikstrasse Roma–Membran Hamburg) è la più completa e aggiornata Enciclopedia discografica contenente l’intera produzione musicale composta dal 1933 al 1945 da musicisti imprigionati, deportati, uccisi, sopravvissuti di qualsiasi contesto nazionale, sociale, religioso, civile e militare nei Campi di transito, lavoro, concentramento, sterminio, penitenziari, Oflag e Stalag aperti in Europa, Africa e Asia coloniale e Australia da Terzo Reich, Italia, Giappone, Repubblica di Salò, regime di Vichy e altri Paesi dell’Asse, Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica e altri Paesi Alleati. Un progetto ambizioso, un lavoro colossale importante non soltanto per le dimensioni e per l’accurato lavoro di ricerca che richiede, ma soprattutto per il significato che ha l’idea di raccogliere in un unica opera musica composta da internati nei campi di concentramento nazisti e musica composta da prigionieri tedeschi nei campi sovietici o di altri Paesi alleati, musica composta da prigionieri di tante confessioni religiose tutte diverse fra loro perché “la musica – come sostiene Francesco Lotoro, autore dell’opera – “ha un linguaggio universale”.
KZ Musik (Musikstrasse Roma–Membran Hamburg) è la più completa e aggiornata Enciclopedia discografica contenente l’intera produzione musicale composta dal 1933 al 1945 da musicisti imprigionati, deportati, uccisi, sopravvissuti di qualsiasi contesto nazionale, sociale, religioso, civile e militare nei Campi di transito, lavoro, concentramento, sterminio, penitenziari, Oflag e Stalag aperti in Europa, Africa e Asia coloniale e Australia da Terzo Reich, Italia, Giappone, Repubblica di Salò, regime di Vichy e altri Paesi dell’Asse, Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica e altri Paesi Alleati. Un progetto ambizioso, un lavoro colossale importante non soltanto per le dimensioni e per l’accurato lavoro di ricerca che richiede, ma soprattutto per il significato che ha l’idea di raccogliere in un unica opera musica composta da internati nei campi di concentramento nazisti e musica composta da prigionieri tedeschi nei campi sovietici o di altri Paesi alleati, musica composta da prigionieri di tante confessioni religiose tutte diverse fra loro perché “la musica – come sostiene Francesco Lotoro, autore dell’opera – “ha un linguaggio universale”.
Il Palazzo della Cultura in Roma con il patrocinio della Comunità Ebraica di Roma e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha ospitato la presentazione della seconda parte dell’opera (volumi 7-12), erano presenti il Presidente Ucei Renzo Gattegna, Riccardo Pacifici Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Franco Bixio Presidente dell’Associazione Musikstrasse di Roma, Markus Engelhardt direttore della sezione Storia della musica dell’Istituto storico germanico di Roma, Carlo Spartaco Capogreco storico, Presidente della Fondazione Ferramonti e l’autore dell’opera Francesco Lotoro (nell’immagine di seguito) pianista.
 Professor Francesco Lotoro, può descriverci in due parole l’enciclopedia?L’Enciclopedia intende raccogliere come opera omnia e quindi non un’antologia, tutta la produzione musicale dei più diversi generi, composta nei campi di concentramento nei campi di internamento, ma anche nei campi civili e militari. Questo significa non soltanto la musica composta nei campi di concentramento tedeschi, ma per capirci anche quella scritta dai prigionieri di guerra tedeschi nei campi francesi o britannici.
Professor Francesco Lotoro, può descriverci in due parole l’enciclopedia?L’Enciclopedia intende raccogliere come opera omnia e quindi non un’antologia, tutta la produzione musicale dei più diversi generi, composta nei campi di concentramento nei campi di internamento, ma anche nei campi civili e militari. Questo significa non soltanto la musica composta nei campi di concentramento tedeschi, ma per capirci anche quella scritta dai prigionieri di guerra tedeschi nei campi francesi o britannici.
Da che cosa è nata l’idea?
Ho iniziato ad avvicinarmi all’idea per passione, ho iniziato negli anni novanta, mi sono detto se non faccio io da battistrada, difficilmente si potrà arrivare a una perimetrazione della fenomenologia musicale concentrazionaria. In quegli anni ancora non esisteva internet nel senso di ciò che è oggi, pertanto ho dovuto costruire con maggiore difficoltà tutti i contatti con istituzioni, memoriali, biblioteche, archivi, antiquariati
librari, musicisti ex–deportati ancora in vita, loro parenti e sopratutto musicologi e
ricercatori che hanno cominciato prima di me, verso i quali ho la più sincera gratitudine e riconoscenza. Parlo di Bret Werb del USHMM di Washington D.C., Guido Fackler
dell’Università di Wuerzburg, Werner Grunzweig dell’Akademie der Kunst di Berlino ma
anche Lena Makarova, Claude Torres, Damien Top e pochi altri. Per tacer di Aleksandr Kulisiewicz, che non ho mai conosciuto e che, sopravvissuto a Sachsenhausen, trascorse tutto il resto della sua vita a raccogliere materiale musicale e poetico dei Campi. Mi sono considerato sempre l’ultimo arrivato e tuttavia colui che in seno alla tematica ha uno scopo ben preciso: unificare tutte le produzioni musicali concentrazionarie (lirica, sinfonica, cameristica, strumentale, pianistica, liederistica, corale, ecc.) e dare a esse una definitiva strutturazione enciclopedica e bibliotecaria.
 Qual’è stata la prima cosa che l’ha spinta verso questa musica e questo progetto?
Qual’è stata la prima cosa che l’ha spinta verso questa musica e questo progetto?
Come pianista, le grandi pagine musicali scritte da Viktor Ullmann (nell’immagine a fianco) a Theresienstadt e da Emile Goué a Nienburg/Weser. Come musicista, forte è stata l’esigenza di far luce su una vastissima letteratura musicale che, scritta in cattività, non ha conosciuto la fama e l’importanza che le spetta. La ormai famosa produzione musicale di Theresienstadt non esaurisce il discorso della musica scritta nei Campi; essa ne è solo una piccola parte. In una immaginaria biblioteca contenente l’intera Storia della Musica, nello scaffale della musica del Novecento,mancava un poderoso volume: la musica concentrazionaria. La prima cosa che ho sentito nei confronti di questa musica scritta da ebrei, cattolici, evangelici, quaccheri, sufi, Sinti soldati, sottufficiali e ufficiali di tutte le parti in guerra, era che solo un ebreo come me poteva realizzare KZ Musik perché ho, come ogni ebreo, l’imperativo della Memoria. Anche dinanzi a Messe scritte da
preti e monaci musicisti o persino dinanzi a musiche scritte da ufficiali tedeschi nei Campi militari degli Alleati, ho ritenuto che tutta questa musica dovesse essere pubblicata in KZ Musik. La musica è un linguaggio universale; la musica scritta nei Campi di concentramento, da chiunque sia stata scritta, è un patrimonio dell’Umanità.
Cosa hanno comportato le sue ricerche?
Molte cose: innanzitutto una internazionalizzazione delle ricerche. Dal 1939 al 1945 il
mondo intero era in Guerra, pertanto il pianeta si riempì di Campi di concentramento, dai grossi impianti concentrazionari di Auschwitz ai più sperduti Campi aperti dal Giappone nella Manciuria, a Taiwan, a Singapore passando per i Campi aperti nell’Africa settentrionale e nell’India coloniale britannica. Pertanto ho dovuto crearmi anche una fitta rete di informatori, colleghi o semplici musicofili che potessero segnalarmi o acquistare nei 5 Continenti tutto il materiale cartaceo musicale ma anche fotografico, biografico oltre a mettermi in contatto con le famiglie dei musicisti ex–deportati. Ciò naturalmente comporta un aggiornamento continuo delle biografie di ogni musicista, lo studio di tutta la vasta letteratura storica e memorialistica sull’argomento da leggersi in tutte le lingue possibili. Tutto ciò si alterna allo studio musicale vero e proprio; ci sono centinaia di opere da studiare. Ogni mese teniamo due cicli di registrazioni che vengono preparate con assoluta meticolosità.
Ha parlato delle famiglie dei musicisti ex-deportati, è entrato in contatto con alcune di loro?
Non sempre è possibile contattare le famiglie dei musicisti ma nei casi in cui è stato
possibile si è sviluppato un ottimo rapporto con esse. Nella maggior parte dei casi sono diventato loro amico. Mi sono talora imbattuto in parenti che avevano materiale musicale ancora giacente nelle loro abitazioni, magari accatastato in qualche scaffale, con tutti i rischi derivanti dal deterioramento cartaceo.
Quali sono le sue speranze per questo progetto, quali i motivi di orgoglio, quanto la emoziona?
Mi emoziona che questo avvenga sotto il patrocinio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e della Comunità Ebraica di Roma, per me che sono un ebreo della periferia questo è un grande riconoscimento. Ovviamente si può fare di più e spero che l’Ucei sia l’interlocutore anche per il futuro. Nei miei progetti vi è la fondazione di un Istituto Internazionale di Letteratura Musicale Concentrazionaria, che non è detto debba sorgere nella capitale. Forse si può regionalizzare. Questo è un patrimonio che deve essere a disposizione di tutti. Io comunque sento di doverci essere, mi sembra un motivo di orgoglio che sia un ebreo a recuperare questo materiale.
Lucilla Efrati
