Il figlio ribelle e l’importanza dell’educazione
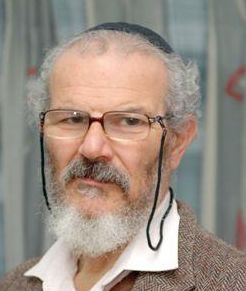 La Torà prende in considerazione un caso particolarmente penoso: “Quando un individuo avrà un figlio traviato e ribelle che non dà ascolto al padre e alla madre e per quanto lo correggano egli non ubbidisce loro, il padre e la madre lo prenderanno e lo porteranno agli anziani della loro città, al tribunale del luogo, e diranno agli anziani della loro città: Questo nostro figlio è traviato e ribelle; non ci da ascolto e mangia e beve eccessivamente. Tutti gli uomini della città lo lapideranno ed egli morrà e toglierai il male da mezzo a te e tutto Israele udrà e avrà timore”. (Deut. 21, 18-21).
La Torà prende in considerazione un caso particolarmente penoso: “Quando un individuo avrà un figlio traviato e ribelle che non dà ascolto al padre e alla madre e per quanto lo correggano egli non ubbidisce loro, il padre e la madre lo prenderanno e lo porteranno agli anziani della loro città, al tribunale del luogo, e diranno agli anziani della loro città: Questo nostro figlio è traviato e ribelle; non ci da ascolto e mangia e beve eccessivamente. Tutti gli uomini della città lo lapideranno ed egli morrà e toglierai il male da mezzo a te e tutto Israele udrà e avrà timore”. (Deut. 21, 18-21).
Si tratta di un figlio che trasgredisce la parola di suo padre o di sua madre, la cui importanza è fondamentale nell’educazione dei figli. Il potere del padre è sottoposto a due importanti limitazioni: 1) il padre non può giudicare da solo il figlio ma dovrà portarlo davanti agli anziani della città (cioè davanti al tribunale locale) perchè essi decidano se è effettivamente colpevole e passibile di pena. Il potere giudiziario, la decisione finale è attribuita quindi al tribunale; 2) il potere del padre di portare il figlio davanti al tribunale è limitato dalla necessità del consenso materno; la madre – normalmente più pietosa verso suo figli – si trova qui in condizione di parità rispetto al padre: i genitori hanno il potere di perdonare e avere pietà dei loro figli, lasciando loro decidere se portare o meno il caso davanti al tribunale anzi tale potere vige fino al momento in cui il tribunale non abbia ancora pronunciato la sua sentenza (T.B. Sanhedrin 88b).
I Maestri del Talmud hanno insegnato che vi sono altre limitazioni al potere paterno, come ad esempio che il potere è concesso soltanto verso il figlio ribelle (e non la figlia), che il figlio non deve essere più minorenne e non ancora maggiorenne: “I giorni in cui il figlio può essere considerato figlio traviato e ribelle non sono che tre mesi” (T.B., Sanhedrin 69a); inoltre è richiesto che padre e madre abbiano la stessa voce, lo stesso aspetto e la stessa statura, situazioni tali che fanno dire al Talmud (ivi): “il figlio traviato e ribelle non è esistito e non esisterà. Ed allora perchè il suo caso è riportato nella Torà? Per farti studiare ed avere dei meriti”, come a dire è meglio studiare questo caso teoricamente per non dover incorrere nel pericolo di una situazione pratica.
Nel Talmud (ivi, 71a) troviamo una divergenza di opinione fra due Amoraim: secondo Rabbì Shim’on non è concepibile che per alcuna colpa dei genitori facciano uccidere il proprio figlio, ma Rabbì Yochanan risponde affermando: “Io l’ho visto e ho riposato sulla sua tomba”. Fra le varie interpretazioni che sono state date alle parole di Rabbì Yochanan vi è quella che ritiene che Rabbì Yochanan sedette sulla tomba dell’istituto, volendo cioè stabilire che da tempo immemorabile non vi era stato un caso di “figlio traviato e ribelle”; ma anche interpretando letteralmente l’opinione di Rabbì Yochanan vediamo che si tratta di un caso unico, eccezionale, che sottolinea come generalmente i genitori ebrei non facessero uso di tale diritto.
È evidente, secondo i Maestri, anche la responsabilità dei genitori, che hanno purtroppo fallito nella loro missione educativa e vi sono infatti commentatori che interpretano: prenderanno attraverso lui (il figlio) il padre e la madre, che sono responsabili per lui e la responsabilità educativa è fra le più grandi responsabilità che abbiamo. È evidente che la soluzione di questo fallimento non è portare il figlio davanti a un tribunale (come deriva dalla posizione di Rabbì Shim’on); ma la Torà ci vuole insegnare che un fallimento serio nell’educazione di un figlio provoca dolore mortale sia per i genitori, sia per il figlio (come possiamo apprendere dall’insegnamento di Rabbì Yochanan). Se questa procedura sarà riuscita a scuoterci e agitarci in tempo per poter dare una buona educazione ai nostri figli, Questo sarà senz’altro il miglior premio che la Torà poteva concederci.
Il divorzio
Nella parashà di Ki tezé troviamo trattato anche il divorzio: Deut. 24,1-2: «Quando un uomo abbia sposato una donna e abbia con lei convissuto, se essa non gli piacerà più perché ha trovato in lei qualche cosa di sconveniente, scriverà per lei un documento di divorzio, glielo consegnerà in sue mani e la manderà via dalla sua casa. Essa uscirà quindi dalla sua casa, se ne andrà via e potrà unirsi con un altro uomo».
Più tardi, nel V secolo a.e.v., ritroviamo la riprovazione morale di un Profeta, ma non il divieto legale del divorzio stesso: Malachia 2,14-16: «E avete chiesto: “Per qual motivo?” Per aver ciascuno di voi infranto il patto, stipulato alla Mia presenza, con la donna della propria giovinezza, con la propria compagna e legittima sposa. Forse che uno solo di voi non ha fatto ciò? E cosa glien’è derivato se non vanità? Che cosa infatti desidera ciascuno di voi se non prole benedetta da D-o? Moderate allora il vostro istinto e non tradite la compagna della vostra giovinezza! Giacché io odio il ripudio, dice il Signore D-o d’Israele».
Il passo del Deuteronomio viene esaminato dalle due scuole del I secolo, quella di Shammai, normalmente più rigorosa e quella di Hillel. Mishnà Ghittin 9,10: «La scuola di Shammai insegna che il marito non deve ripudiare la moglie fuorché nel caso in cui egli constati in lei un contegno immorale, conforme al testo che dice: “avendo egli trovato in lei qualche cosa di sconcio”. La scuola di Hillel ritiene: [Egli può divorziare da lei] anche se essa ha recato offesa comunque (letteralmente: abbia rovinato una pietanza), come è scritto, “avendo egli trovato in lei qualche cosa di sconcio in qualsiasi cosa”. Rabbi Akivà dice: “Anche se ne ha trovata un’altra più bella di lei”, conforme a ciò che dice il testo, “E avverrà se ella non troverà grazia ai suoi occhi» (Traduzione di V. Castiglioni).
Le due scuole si soffermano sulle parole ervàt davar (qualche cosa di sconveniente, di sconcio); la parola ervà è generalmente riferita alla condotta sessuale, e attraverso una interpretazione letterale, la scuola di Shammai ritiene che il divorzio sia ammesso solo per qualche cosa di sconveniente in campo sessuale. La scuola di Hillel si riferisce invece a tutte e due le parole ervat davar prese nel loro insieme, rilevando che le troviamo assieme anche in un altro passo biblico Deut. 23,15: «Egli non dovrà vedere in te alcuna cosa sconcia (ervàt davar) perché si ritrarrebbe da te». Attraverso una interpretazione analogica si ritiene di dover dare anche qui la stessa interpretazione
data nell’altro verso, sostenendo quindi che il marito può divorziare dalla moglie per ogni cosa di sconveniente che abbia trovato in lei La terza opinione, di Rabbì Akivà (Maestro del II secolo) si sofferma invece sulla prima parte del versetto: se essa non gli piacerà più sostenendo che se egli avrà trovato un’altra donna più bella di sua moglie, potrà divorziare. Nella tradizione ebraica la figura di Rabbì Akivà è legata anche al suo matrimonio per amore, assai combattuto dalla famiglia della sposa, con la figlia di Kalba Sabua; potrebbe quindi a prima vista sorprendere questa interpretazione che potrebbe sembrare assai permissiva; in realtà Rabbì Akivà insegna che se uno cerca e trova una donna più bella di sua moglie, vuol dire che il legame soggettivo che univa i due si è ormai rotto e sarà difficile tenere in piedi un simile legame. Rabbì Akivà si basa su una interpretazione logica del testo biblico per addivenire ad una soluzione di grande importanza psicologica.
Il testo biblico e il commento della Mishnà si riferiscono esclusivamente al divorzio della moglie in base ad un atto voluto dal marito, per suo libero volere e che richiede la preparazione e consegna di un documento speciale. Come si vede anche nel mondo ebraico del periodo della Mishnà troviamo divergenze di opinioni su questo problema.
Testi più tardi tendono a risolvere problemi come quello di dare importanza al volere della moglie senza ledere, almeno giuridicamente, il volere del marito (Una traduzione italiana con relativo commento si trova nel mio “Il Matrimonio” (a cura di S. Ferrari, Rorino, 2006, 53 ss.).
Il Maimonide spiega il motivo del divorzio e delle sue formalità nella sua Guida degli smarriti (III, 49): «Dato che può capitare talvolta che non regni un perfetto accordo nella loro unione e che il loro modo di vivere non sia ben ordinato, è stato permesso il divorzio. Ma se il divorzio avesse potuto essere compiuto con una semplice parola, o attraverso il mandare la donna fuori di casa, essa cercherebbe un momento di
negligenza (da parte del marito), in cui non sarebbe osservata ed uscirebbe (di casa) pretendendo di essere divorziata; oppure se un uomo avesse avuto una relazione (adulterina) con lei, lei e il seduttore pretenderebbero che essa era stata divorziata prima. È per questo che la Torà vuole che il divorzio non sia valido senza che vi sia uno scritto che lo attesti: “scriverà per lei un documento di divorzio”».
Alfredo Mordechai Rabello, Giurista, Università Ebraica di Gerusalemme
