Davar Acher – L’etica della responsabilità
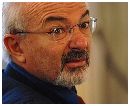 Ma è giusto sentirsi in lutto a Tishà be Av, che ricorda le due cadute di Gerusalemme, ancora oggi, sessantadue anni dopo la fondazione dello Stato di Israele e quarantatre dopo la riconquista della città? Difficile negare che questa ricorrenza abbia perso per molti la sua base emotiva, una volta così forte. La tradizione rabbinica insegna però che vi sono molte ragioni per rispettarla. Le nostre ricorrenze hanno sempre molti aspetti: in questo caso non solo la caduta del Tempio, ma una serie di altri eventi negativi che cadono in questa data e le loro radici nel comportamento collettivo. Non intendo entrare qui in quest’ordine di discorso, ma sono d’accordo, per ragioni tutte civili e politiche.
Ma è giusto sentirsi in lutto a Tishà be Av, che ricorda le due cadute di Gerusalemme, ancora oggi, sessantadue anni dopo la fondazione dello Stato di Israele e quarantatre dopo la riconquista della città? Difficile negare che questa ricorrenza abbia perso per molti la sua base emotiva, una volta così forte. La tradizione rabbinica insegna però che vi sono molte ragioni per rispettarla. Le nostre ricorrenze hanno sempre molti aspetti: in questo caso non solo la caduta del Tempio, ma una serie di altri eventi negativi che cadono in questa data e le loro radici nel comportamento collettivo. Non intendo entrare qui in quest’ordine di discorso, ma sono d’accordo, per ragioni tutte civili e politiche.
Mi concentrerò solo su un paio di ragioni puramente storico-nazionali per riflettere su questa giornata. La prima ragione per mantenere vivo il ricordo della caduta di Gerusalemme è ovvia: non vi è oggi intorno a Israele né pace né riconoscimento generale; la restaurazione del nostro popolo sulla sua terra non è né stabilizzata né completata né appare probabile che possa esserlo in tempi prevedibili. Anzi, è forte il rischio di altre guerre, di altri lutti e non manca certo chi, fuori ma anche dentro il mondo ebraico, lavora instancabilmente per distruggere, demonizzare, delegittimare lo stato di Israele anche nei suoi limiti attuali. Vi è dunque ancora ragione se non di lutto, di angoscia e di preoccupazione. Tishà be Av è una buona occasione per esprimerli e riflettervi.
La seconda ragione è più specifica: Tishà be Av parla innanzitutto del pericolo della scissione di Israele in sette e fazioni che caratterizzò gli ultimi secoli della sua antica autonomia. Proprio per la divisione nel popolo ebraico cadde il Secondo Tempio, ci suggerisce infatti il Talmud (Yomà 9b). Leggiamo, oltre che da accenni talmudici, anche dalle fonti storiche di cui disponiamo (Giuseppe Flavio, “Guerra Giudaica” II, “Antichità giudaiche” XIII e XVIII, ecc.) che in quel periodo in Israele si combattevano fazioni accanitamente nemiche: saddiucei, farisei, esseni, zeloti, i primi cristiani, altri gruppi di cui ignoriamo tutto salvo una vaga denominazione (per esempio “la quarta filosofia” – ancora G. Flavio). Ciascuno convinto di essere il vero erede della tradizione di Israel e intollerante nei confronti degli altri. I documenti di Qumran, per esempio, come le apocalittiche di altra fonte che ci sono arrivate da quel periodo, sono piene di immagini belliche, di profezie di distruzione, di maledizioni e diffamazioni e intolleranza e del rifiuto del riconoscimento degli avversari come membri dello stesso popolo. Il rischio è che questa situazione si stia ripetendo oggi. Laici e religiosi, destra e sinistra, haredim e modernisti, ebrei di Israele e della diaspora soprattutto americana, sionisti e “post” non sono più differenze che arricchiscono, ma contrapposizioni che separano e indeboliscono: il motore della divisione ha ripreso oggi la sua piena attività. Da Tishà be Av dobbiamo proporci la necessità di un discrimine per non affogare oggi nelle lotte intestine.
Chi è lucido non può farsi troppe illusioni sulla possibilità di superare questi conflitti oggi come ieri attraverso la semplice buona volontà. Non possiamo attendercela certo da parte di quegli ultraortodossi che vanno a far visita a Ahamadinedjad con la bandiera dell’Olp al petto, per condividere la sua delegittimazione di Israele, né da quei docenti universitari “postsionisti” delle università israeliane che pretendono di aver diritto, per via della libertà della scienza, a organizzare il boicottaggio di Israele e delle loro stesse università da cui ricevono lo stipendio. In nome di che cosa giudicheremo queste posizioni?
A me sembra chiaro che il solo criterio possibile sia quello che si trova già nella Torà e che è alla base della democrazia: il rispetto delle scelte della maggioranza: dunque non solo della cornice istituzionale dello Stato di Israele – che è la forma attuale che si è dato il nostro popolo -, ma anche delle scelte politiche che vengono fatte da Governo e Parlamento, cioè dei contenuti di questa cornice. E’ di fronte a questo criterio fondamentale – l’adesione al destino storico dell’Israele concreta, non di un’idea astratta e non impegnativa – che tutti gli ebrei devono sentirsi chiamati a esercitare quella che Hans Jonas ha chiamato “etica della responsabilità” in contrapposizione all'”etica della convinzione” o ai semplici interessi di parte. La responsabilità unisce, la convinzione divide. E’ facile dare per scontato che esseni, zeloti, cristiani, ecc. fossero perfettamente convinti di fare il giusto con le loro posizioni settarie. Più difficile, ma non impossibile, capire che anche oggi tutti gli estremisti più distruttivi siano in buona fede. Il problema è che la buona fede non basta e neppure la convinzione di avere dalla propria la Torà o la ragione, occorre molto umilmente tener conto dei vincoli e dei dati di fatto per assicurare la sopravvivenza collettiva. Chi non lo fa, chi non rispetta questi limiti, per quanto possa nutrire la fede più grande e l’etica più ferma, rischia di lavorare per un nuovo Tisha be Av, per una nuova caduta di Gerusalemme e per una nuova Shoà. Lo sappia o meno. Su questo rischio la ricorrenza ci chiama a riflettere tutti. Ma soprattutto devono pensarci quelli che si proclamano giudici severi del loro popolo, coloro che hanno la pretesa di indicargli la fede o la giustizia smarrita.
Ugo Volli
